
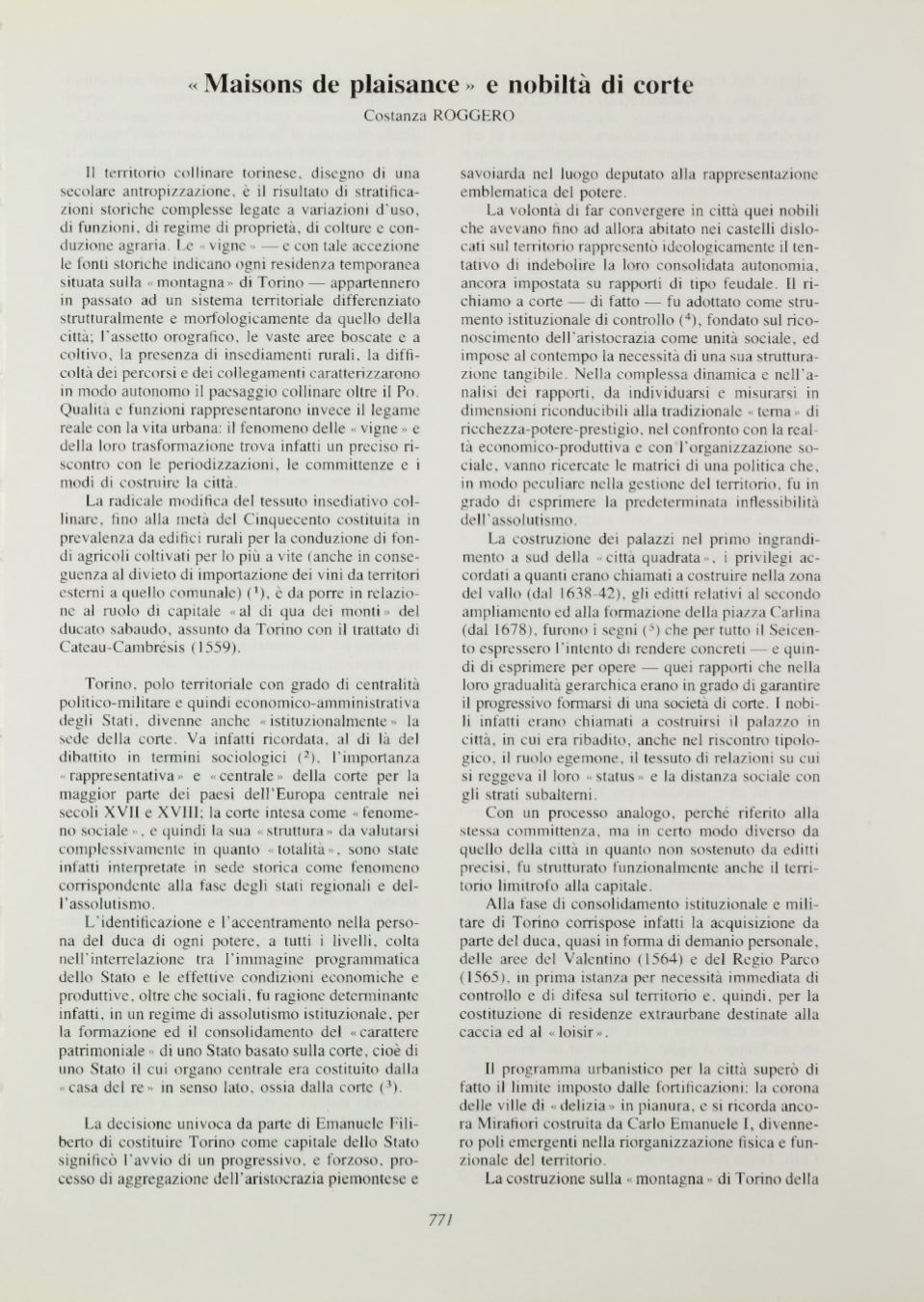
« Maisons de plaisance »
e nobiltà
di
corte
Costanza
ROGGERO
Il territorio collinare torinese, disegno di una
secolare antropizzazione, è il risultato di stratifica-
zioni storiche complesse legate a variazioni d'uso,
di funzioni, di regime di proprietà, di colture e con-
duzione agraria. Le « vigne » e con tale accezione
le fonti storiche indicano ogni residenza temporanea
situata sulla « montagna»
di
Torino appartennero
in passato ad un sistema territoriale differenziato
strutturalmente e morfologicamente da quello della
città; l'assetto orografico, le vaste aree boscate e a
coltivo, la presenza di insediamenti rurali, la diffi-
coltà dei percorsi e dei collegamenti caratterizzarono
in modo autonomo il paesaggio collinare oltre il Po.
Qualità e funzioni rappresentarono invece il legame
reale con la vita urbana: il fenomeno delle « vigne » e
della loro trasformazione trova infatti un preciso ri-
scontro con le periodizzazioni, le committenze e i
modi di costruire la città.
La radicale modifica del tessuto insediativo col-
linare, fino alla metà del Cinquecento costituita in
prevalenza da edifici rurali per la conduzione di fon-
di agricoli coltivati per lo più a vite (anche in conse-
guenza al divieto di importazione dei vini da territori
esterni a quello comunale) (
1
), è da porre in relazio-
ne al ruolo di capitale «al di qua dei monti » del
ducato sabaudo, assunto da Torino con il trattato di
Cateau-Cambrésis (1559).
Torino, polo territoriale con grado di centralità
politico-militare e quindi economico-amministrativa
degli Stati, divenne anche « istituzionalmente » la
sede della corte. Va infatti ricordata, al di là del
dibattito in termini sociologici (
2
), l'importanza
« rappresentativa » e « centrale » della corte per la
maggior parte dei paesi dell'Europa centrale nei
secoli XVII e XVIII; la corte intesa come «fenome-
no sociale », e quindi la sua « struttura » da valutarsi
complessivamente in quanto «totalità», sono state
infatti interpretate in sede storica come fenomeno
corrispondente alla fase degli stati regionali e del-
l'assolutismo.
L'identificazione e l'accentramento nella perso-
na del duca di ogni potere, a tutti i livelli, colta
nell'interrelazione tra l'immagine programmatica
dello Stato e le effettive condizioni economiche e
produttive, oltre che sociali, fu ragione determinante
infatti, in un regime di assolutismo istituzionale, per
la formazione ed il consolidamento del « carattere
patrimoniale » di uno Stato basato sulla corte, cioè di
uno Stato il cui organo centrale era costituito dalla
«casa del re» in senso lato, ossia dalla corte (
3
).
La decisione univoca da parte di Emanuele Fili-
berto di costituire Torino come capitale dello Stato
significò l'avvio di un progressivo, e forzoso, pro-
cesso di aggregazione dell'aristocrazia piemontese e
savoiarda nel luogo deputato alla rappresentazione
emblematica del potere.
La volontà di far convergere in città quei nobili
che avevano fino ad allora abitato nei castelli dislo-
cati sul territorio rappresentò ideologicamente il ten-
tativo di indebolire la loro consolidata autonomia,
ancora impostata su rapporti di tipo feudale. Il ri-
chiamo a corte di fatto — fu adottato come stru-
mento istituzionale di controllo (
4
), fondato sul rico-
noscimento dell'aristocrazia come unità sociale, ed
impose al contempo la necessità di una sua struttura-
zione tangibile. Nella complessa dinamica e nell'a-
nalisi dei rapporti, da individuarsi e misurarsi in
dimensioni riconducibili alla tradizionale «terna» di
ricchezza-potere-prestigio, nel confronto con la real-
tà economico-produttiva e con l'organizzazione so-
ciale, vanno ricercate le matrici di una politica che,
in modo peculiare nella gestione del territorio, fu in
grado di esprimere la predeterminata inflessibilità
dell'assolutismo.
La costruzione dei palazzi nel primo ingrandi-
mento a sud della «città quadrata», i privilegi ac-
cordati a quanti erano chiamati a costruire nella zona
del vallo (dal 1638-42), gli editti relativi al secondo
ampliamento ed alla formazione della piazza Carlina
(dal 1678), furono i segni (
5
) che per tutto il Seicen-
to espressero l'intento di rendere concreti e quin-
di di esprimere per opere quei rapporti che nella
loro gradualità gerarchica erano in grado di garantire
il progressivo formarsi di una società di corte. I nobi-
li infatti erano chiamati a costruirsi il palazzo in
città, in cui era ribadito, anche nel riscontro tipolo-
gico, il ruolo egemone, il tessuto di relazioni su cui
si reggeva il loro « status » e la distanza sociale con
gli strati subalterni.
Con un processo analogo, perché riferito alla
stessa committenza, ma in certo modo diverso da
quello della città in quanto non sostenuto da editti
precisi, fu strutturato funzionalmente anche il terri-
torio limitrofo alla capitale.
Alla fase di consolidamento istituzionale e mili-
tare di Torino corrispose infatti la acquisizione da
parte del duca, quasi in forma di demanio personale,
delle aree del Valentino (1564) e del Regio Parco
(1565), in prima istanza per necessità immediata di
controllo e di difesa sul territorio e, quindi, per la
costituzione di residenze extraurbane destinate alla
caccia ed al « loisir» .
Il programma urbanistico per la città superò di
fatto il limite imposto dalle fortificazioni: la corona
delle ville di «delizia» in pianura, e si ricorda anco-
ra Mirafiori costruita da Carlo Emanuele
I,
divenne-
ro poli emergenti nella riorganizzazione fisica e fun-
zionale del territorio.
La costruzione sulla «montagna» di Torino della
771


















