
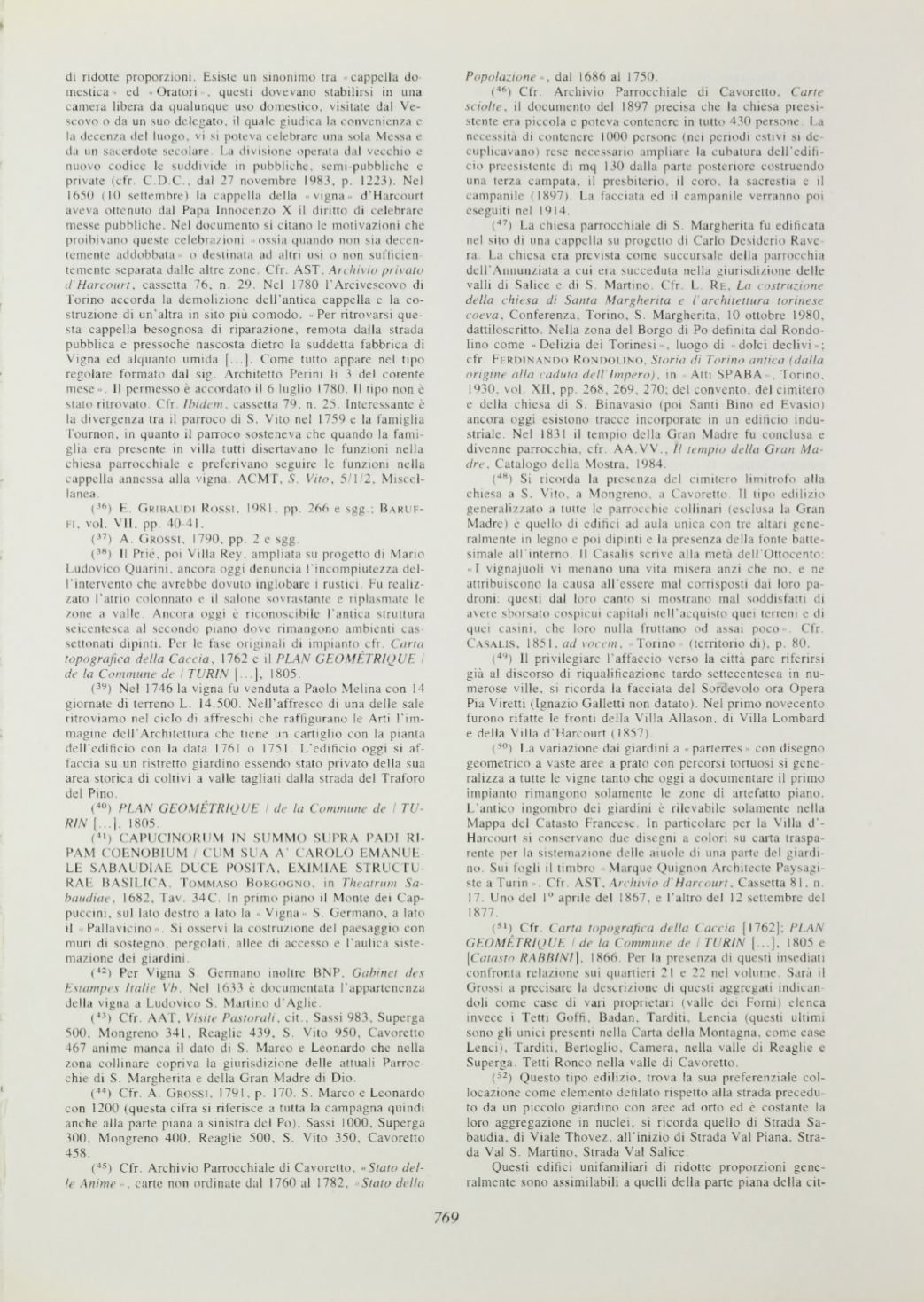
di ridotte proporzioni. Esiste un sinonimo tra «cappella do-
mestica» ed « Oratori., questi dovevano stabilirsi in una
camera libera da qualunque uso domestico, visitate dal Ve-
scovo o da un suo delegato, il quale giudica la convenienza e
la decenza del luogo, vi si poteva celebrare una sola Messa e
da un sacerdote secolare. La divisione operata dal vecchio e
nuovo codice le suddivide in pubbliche, semi-pubbliche e
private (cfr. C.D.C., dal 27 novembre 1983, p. 1223). Nel
1650 (10 settembre) la cappella della « vigna. d'Harcourt
aveva ottenuto dal Papa Innocenzo X il diritto di celebrare
messe pubbliche. Nel documento si citano le motivazioni che
proibivano queste celebrazioni «ossia quando non sia decen-
temente addobbata» o destinata ad altri usi o non sufficien-
temente separata dalle altre zone. Cfr. AST,
Archivio privato
d'Harcourt,
cassetta 76, n. 29. Nel 1780 l'Arcivescovo di
Torino accorda la demolizione dell'antica cappella e la co-
struzione di un'altra in sito più comodo. « Per ritrovarsi que-
sta cappella besognosa di riparazione, remota dalla strada
pubblica e pressoché nascosta dietro la suddetta fabbrica di
Vigna ed alquanto umida [...]. Come tutto appare nel tipo
regolare formato dal sig. Architetto Perini li 3 del corente
mese». Il permesso è accordato il 6 luglio 1780. Il tipo non è
stato ritrovato. Cfr.
Ibidem,
cassetta 79, n. 25. Interessante è
la divergenza tra il parroco di S. Vito nel 1759 e la famiglia
Tournon, in quanto il parroco sosteneva che quando la fami-
glia era presente in villa tutti disertavano le funzioni nella
chiesa parrocchiale e preferivano seguire le funzioni nella
cappella annessa alla vigna. ACMT,
S. Vito,
5/1/2, Miscel-
lanea.
(36) E.
GRIBAUDI Rossl,
1981, pp. 266 e sgg.;
BARUF-
FI, vol.
VII, pp. 40-41.
(37) A.
GRossI,
1790, pp. 2 e sgg.
(38) Il Prié, poi Villa Rey, ampliata su progetto di Mario
Ludovico Quarini, ancora oggi denuncia l'incompiutezza del-
l'intervento che avrebbe dovuto inglobare i rustici. Fu realiz-
zato l'atrio colonnato e il salone sovrastante e riplasmate le
zone a valle. Ancora oggi è riconoscibile l'antica struttura
seicentesca af secondo piano dove rimangono ambienti cas-
settonati dipinti. Per le fase originali di impianto cfr.
Carta
topografica delta Caccia,
1762 e il
PLAN GEOMETRIQUE I
de ta Commune de l TURIN [...],
1805.
(39) Nel 1746 la vigna fu venduta a Paolo Melina con 14
giornate di terreno L. 14.500. Nell'affresco di una delle sale
ritroviamo nel ciclo di affreschi che raffigurano le Arti l'im-
magine dell'Architettura che tiene un cartiglio con la pianta
dell'edificio con la data 1761 o 1751. L'edificio oggi si af-
faccia su un ristretto giardino essendo stato privato della sua
area storica di coltivi a valle tagliati dalla strada del Traforo
del Pino.
(45)
PLAN GEOMETRIQUE I de la Commune de I TU-
RIN [...],
1805.
(41) CAPUCINORUM IN SUMMO SUPRA PADI RI-
PAM COENOBIUM / CUM SUA A' CAROLO EMANUE-
LE SABAUDIAE DUCE POSITA, EXIMIAE STRUCTU-
RAE BASILICA,
TOMMASO BORGOGNO,
in
Theatrum Sa-
baudiae,
1682, Tav. 34C. In primo piano il Monte dei Cap-
puccini, sul lato destro a lato la « Vigna. S. Germano, a lato
il «Pallavicino». Si osservi la costruzione del paesaggio con
muri di sostegno, pergolati, allee di accesso e l'aulica siste-
mazione dei giardini.
(42) Per Vigna S. Germano inoltre BNP,
Gabinet des
Estampes Italie Vb.
Nel 1633 è documentata l'appartenenza
della vigna a Ludovico S. Ma
rt
ino d'Aglié.
(43) Cfr. AAT,
Visite Pastorali,
cit., Sassi 983, Superga
500, Mongreno 341, Reaglie 439, S. Vito 950, Cavoretto
467 anime manca il dato di S. Marco e Leonardo che nella
zona collinare copriva la giurisdizione delle attuali Parroc-
chie di S. Margherita e della Gran Madre di Dio.
(44) Cfr. A.
GROSSI,
1791, p. 170. S. Marco e Leonardo
con 1200 (questa cifra si riferisce a tutta la campagna quindi
anche alla parte piana a sinistra del Po), Sassi 1000, Superga
300, Mongreno 400, Reaglie 500, S. Vito 350, Cavoretto
458.
(45) Cfr. Archivio Parrocchiale di Cavoretto,
«Stato del-
le Anime »,
carte non ordinate dal 1760 al 1782,
«Stato della
Popolazione.,
dal 1686 al 1750.
(46) Cfr. Archivio Parrocchiale di Cavoretto,
Carte
sciolte,
il documento del 1897 precisa che la chiesa preesi-
stente era piccola e poteva contenere in tutto 430 persone. La
necessità di contenere 1000 persone (nei periodi estivi si de-
cuplicavano) rese necessario ampliare la cubatura dell'edifi-
cio preesistente di mq 130 dalla parte posteriore costruendo
una terza campata, il presbiterio, il coro, la sacrestia e il
campanile (1897). La facciata ed il campanile verranno poi
eseguiti nel 1914.
(47) La chiesa parrocchiale di S. Margherita fu edificata
nel sito di una cappella su progetto di Carlo Desiderio Bave-
ra. La chiesa era prevista come succursale della parrocchia
dell'Annunziata a cui era succeduta nella giurisdizione delle
valli di Salice e di S. Ma
rt
ino. Cfr. L. RE,
La costruzione
della chiesa di Santa Margherita e l'architettura torinese
coeva,
Conferenza, Torino, S. Margherita, 10 ottobre 1980,
dattiloscritto. Nella zona del Borgo di Po definita dal Rondo-
lino come «Delizia dei Torinesi», luogo di «dolci declivi»;
cfr.
FERDINANDO RONDOLINO,
Storia di Torino antica (dalla
origine alla caduta dell'Impero),
in «Atti SPABA», Torino,
1930, vol. XII, pp. 268, 269, 270; del convento, del cimitero
e della chiesa di S. Binavasio (poi Santi Bino ed Evasio)
ancora oggi esistono tracce incorporate in un edificio indu-
striale. Nel 1831 il tempio della Gran Madre fu conclusa e
divenne parrocchia, cfr.
AA.VV.,
II tempio della Gran Ma-
dre,
Catalogo della Mostra, 1984.
(48) Si ricorda la presenza del cimitero limitrofo alla
chiesa a S. Vito, a Mongreno, a Cavoretto. Il tipo edilizio
generalizzato a tutte le parrocchie collinari (esclusa la Gran
Madre)
è
quello di edifici ad aula unica con tre altari gene-
ralmente in legno e poi dipinti e la presenza della fonte batte-
simale all'interno. Il Casalis scrive alla metà dell'Ottocento:
«I vignajuoli vi menano una vita misera anzi che no, e ne
attribuiscono la causa all'essere mal corrisposti dai loro pa-
droni: questi dal loro canto si mostrano mal soddisfatti di
avere sborsato cospicui capitali nell'acquisto quei terreni e di
quei casini, che loro nulla fruttano od assai poco». Cfr.
CASALIS,
1851,
ad vocem, «Torino.
(territorio di), p. 80.
(49) Il privilegiare l'affaccio verso la città pare riferirsi
già al discorso di riqualificazione tardo settecentesca in nu-
merose ville, si ricorda la facciata del Sordevolo ora Opera
Pia Viretti (Ignazio Galletti non datato). Nef primo novecento
furono rifatte le fronti della Villa Allason, di Villa Lombard
e della Villa d'Harcourt (1857).
(50) La variazione dai giardini a « parterres » con disegno
geometrico a vaste aree a prato con percorsi tortuosi si gene-
ralizza a tutte le vigne tanto che oggi a documentare il primo
impianto rimangono solamente le zone di artefatto piano.
L'antico ingombro dei giardini è rilevabile solamente nella
Mappa del Catasto Francese. In particolare per la Villa d'-
Harcourt si conservano due disegni a colori su carta traspa-
rente per la sistemazione delle aiuole di una parte del giardi-
no. Sui fogli il timbro « Marque Quignon Architecte Paysagi-
ste a Turin». Cfr. AST,
Archivio d'Harcourt,
Cassetta 81, n.
17. Uno del 1° aprile del 1867, e l'altro del 12 settembre del
1877.
(51) Cfr.
Carta topografica delta Caccia
[1762];
PLAN
GEOMÉTRIQUE l de la Commune de l TURIN [...],
1805 e
[Catasto RABBINI],
1866. Per la presenza di questi insediati
confronta relazione sui quartieri 21 e 22 nel volume. Sarà il
Grossi a precisare la descrizione di questi aggregati indican-
doli come case di vari proprietari (valle dei Forni) elenca
invece i Tetti Goffi, Badan, Tarditi, Lencia (questi ultimi
sono gli unici presenti nella Carta della Montagna, come case
Lenci), Tarditi, Bertoglio, Camera, nella valle di Reaglie e
Superga. Tetti Ronco nella valle di Cavoretto.
(
52
) Questo tipo edilizio, trova la sua preferenziale col-
locazione come elemento defilato rispetto alla strada precedu-
to da un piccolo giardino con aree ad orto ed è costante la
loro aggregazione in nuclei, si ricorda quello di Strada Sa-
baudia, di Viale Thovez, all'inizio di Strada Val Piana, Stra-
da Val S. Martino, Strada Val Salice.
Questi edifici unifamiliari di ridotte proporzioni gene-
ralmente sono assimilabili a quelli della parte piana della cit-
769


















