
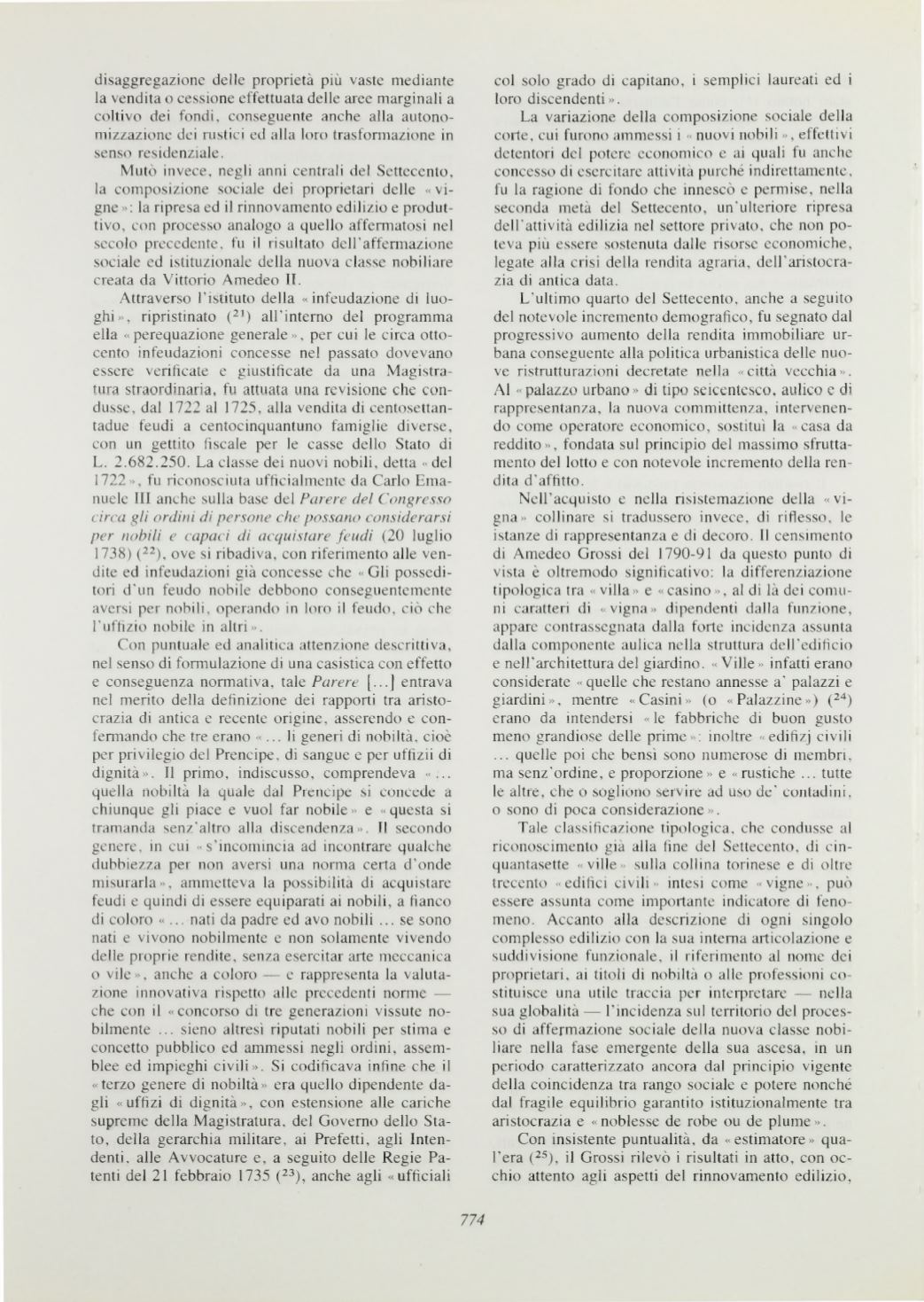
disaggregazione delle proprietà più vaste mediante
la vendita o cessione effettuata delle aree marginali a
coltivo dei fondi, conseguente anche alla autono-
mizzazione dei rustici ed alla loro trasformazione in
senso residenziale.
Mutò invece, negli anni centrali del Settecento,
la composizione sociale dei proprietari delle « vi-
gne »: la ripresa ed il rinnovamento edilizio e produt-
tivo, con processo analogo a quello affermatosi nel
secolo precedente, fu il risultato dell'affermazione
sociale ed istituzionale della nuova classe nobiliare
creata da Vittorio Amedeo II.
Attraverso l'istituto della «infeudazione di luo-
ghi», ripristinato (
21
) all'interno del programma
ella « perequazione generale», per cui le circa otto-
cento infeudazioni concesse nel passato dovevano
essere verificate e giustificate da una Magistra-
tura straordinaria, fu attuata una revisione che con-
dusse, dal 1722 al 1725, alla vendita di centosettan-
tadue feudi a centocinquantuno famiglie diverse,
con un gettito fiscale per le casse dello Stato di
L. 2.682.250. La classe dei nuovi nobili, detta « del
1722», fu riconosciuta ufficialmente da Carlo Ema-
nuele III anche sulla base del
Parere det Congresso
circa gti ordini di persone che possano considerarsi
per nobiti e capaci di acquistare feudi
(20 luglio
1738) (
22
), ove si ribadiva, con riferimento alle ven-
dite ed infeudazioni già concesse che « Gli possedi-
tori d'un feudo nobile debbono conseguentemente
aversi per nobili, operando in loro il feudo, ciò che
l'uffizio nobile in altri».
Con puntuale ed analitica attenzione descrittiva,
nel senso di formulazione di una casistica con effetto
e conseguenza normativa, tale
Parere [...]
entrava
nel merito della definizione dei rapporti tra aristo-
crazia di antica e recente origine, asserendo e con-
fermando che tre erano « ... li generi di nobiltà, cioè
per privilegio del Prencipe, di sangue e per uffizii di
dignità». Il primo, indiscusso, comprendeva
« ...
quella nobiltà la quale dal Prencipe si concede a
chiunque gli piace e vuol far nobile »
e «
questa si
tramanda senz'altro alla discendenza».
Il
secondo
genere, in cui « s'incomincia ad incontrare qualche
dubbiezza per non aversi una norma certa d'onde
misurarla», ammetteva la possibilità di acquistare
feudi e quindi di essere equiparati ai nobili, a fianco
di coloro « ... nati da padre ed avo nobili ... se sono
nati e vivono nobilmente e non solamente vivendo
delle proprie rendite, senza esercitar arte meccanica
o
vile»,
anche a coloro — e rappresenta la valuta-
zione innovativa rispetto alle precedenti norme
che con il «concorso di tre generazioni vissute no-
bilmente ... sieno altresì riputati nobili per stima e
concetto pubblico ed ammessi negli ordini, assem-
blee ed impieghi civili». Si codificava infine che il
terzo genere di nobiltà» era quello dipendente da-
gli « uffizi di dignità», con estensione alle cariche
supreme della Magistratura, del Governo dello Sta-
to, della gerarchia militare, ai Prefetti, agli Inten-
denti, alle Avvocature e, a seguito delle Regie Pa-
tenti del 21 febbraio 1735 (
23
), anche agli «ufficiali
col solo grado di capitano, i semplici laureati ed i
loro discendenti ».
La variazione della composizione sociale della
corte, cui furono ammessi i «nuovi nobili», effettivi
detentori del potere economico e ai quali fu anche
concesso di esercitare attività purché indirettamente,
fu la ragione di fondo che innescò e permise, nella
seconda metà del Settecento, un'ulteriore ripresa
dell'attività edilizia nel settore privato, che non po-
teva più essere sostenuta dalle risorse economiche,
legate alla crisi della rendita agraria, dell'aristocra-
zia di antica data.
L'ultimo quarto del Settecento, anche a seguito
del notevole incremento demografico, fu segnato dal
progressivo aumento della rendita immobiliare ur-
bana conseguente alla politica urbanistica delle nuo-
ve ristrutturazioni decretate nella « città vecchia».
Al «palazzo urbano» di tipo seicentesco, aulico e di
rappresentanza, la nuova committenza, intervenen-
do come operatore economico, sostituì la « casa da
reddito», fondata sul principio del massimo sfrutta-
mento del lotto e con notevole incremento della ren-
dita d'affitto.
Nell'acquisto e nella risistemazione della «vi-
gna» collinare si tradussero invece, di riflesso, le
istanze di rappresentanza e di decoro. Il censimento
di Amedeo Grossi del 1790-91 da questo punto di
vista è oltremodo significativo: la differenziazione
tipologica tra «villa» e «casino», al di là dei comu-
ni caratteri di «vigna» dipendenti dalla funzione,
appare contrassegnata dalla forte incidenza assunta
dalla componente aulica nella struttura dell'edificio
e nell'architettura del giardino. « Ville» infatti erano
considerate « quelle che restano annesse a' palazzi e
giardini», mentre « Casini» (o «Palazzine
») (24)
erano da intendersi « le fabbriche di buon gusto
meno grandiose delle prime »: inoltre « edifizj civili
... quelle poi che bensì sono numerose di membri,
ma senz'ordine, e proporzione » e « rustiche ... tutte
le altre, che o sogliono servire ad uso de' contadini,
o sono di poca considerazione».
Tale classificazione tipologica, che condusse al
riconoscimento già alla fine del Settecento, di cin-
quantasette «ville» sulla collina torinese e di oltre
trecento « edifici civili » intesi come « vigne», può
essere assunta come importante indicatore di feno-
meno. Accanto alla descrizione di ogni singolo
complesso edilizio con la sua interna articolazione e
suddivisione funzionale, il riferimento al nome dei
proprietari, ai titoli di nobiltà o alle professioni co-
stituisce una utile traccia per interpretare — nella
sua globalità l'incidenza sul territorio del proces-
so di affermazione sociale della nuova classe nobi-
liare nella fase emergente della sua ascesa, in un
periodo caratterizzato ancora dal principio vigente
della coincidenza tra rango sociale e potere nonché
dal fragile equilibrio garantito istituzionalmente tra
aristocrazia e « noblesse de robe ou de plume ».
Con insistente puntualità, da «estimatore» qua-
l'era (
25
), il Grossi rilevò
i
risultati in atto, con oc-
chio attento agli aspetti del rinnovamento edilizio,
774


















