
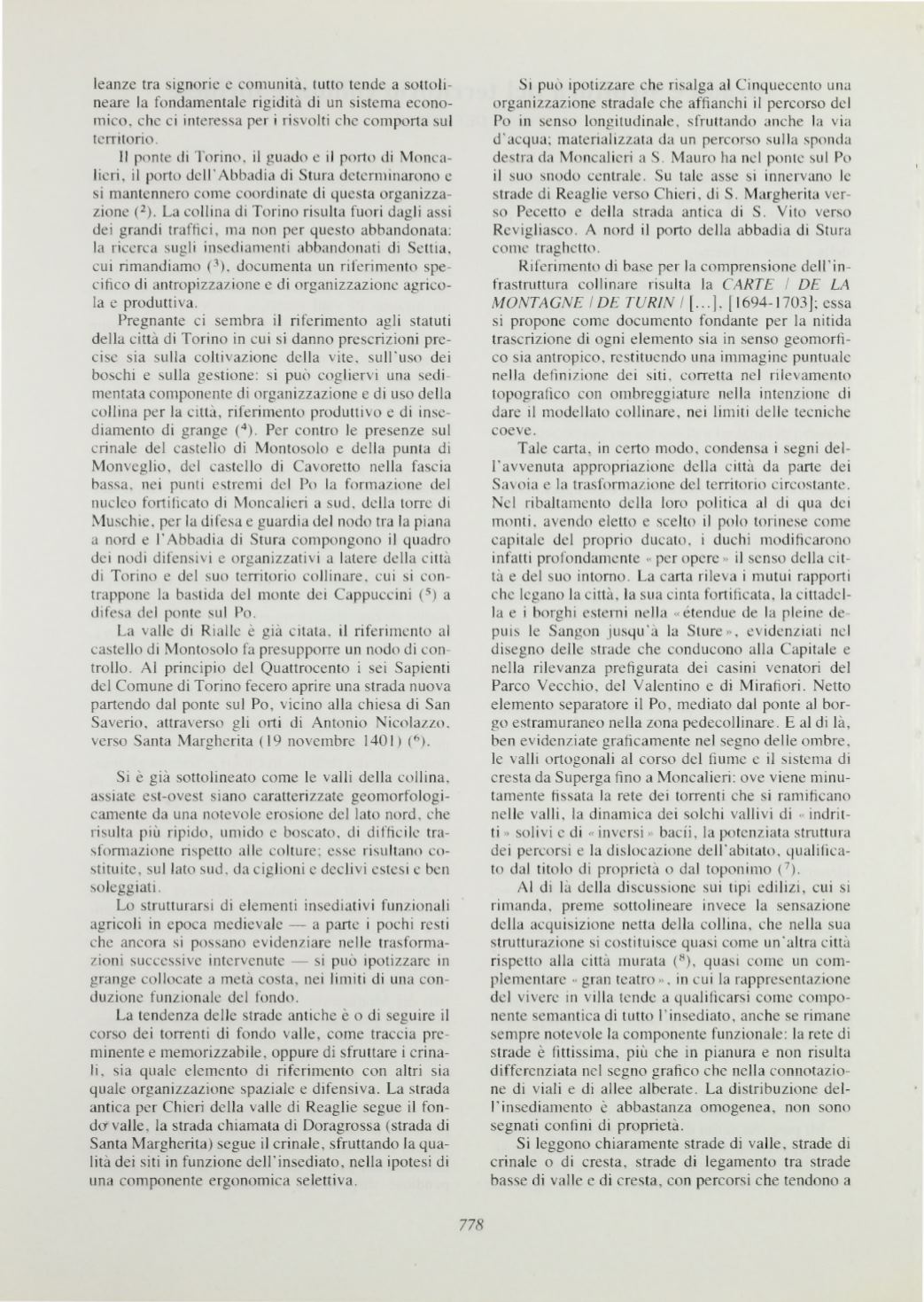
leanze tra signorie e comunità, tutto tende a sottoli-
neare la fondamentale rigidità di un sistema econo-
mico, che ci interessa per i risvolti che comporta sul
territorio.
Il ponte di Torino, il guado e il porto di Monca-
lieri, il porto dell'Abbadia di Stura determinarono e
si mantennero come coordinate di questa organizza-
zione (
2
). La collina di Torino risulta fuori dagli assi
dei grandi traffici, ma non per questo abbandonata:
la ricerca sugli insediamenti abbandonati di Settia,
cui rimandiamo (
3
), documenta un riferimento spe-
cifico di antropizzazione e di organizzazione agrico-
la e produttiva.
Pregnante ci sembra il riferimento agli statuti
della città di Torino in cui si danno prescrizioni pre-
cise sia sulla coltivazione della vite, sull'uso dei
boschi e sulla gestione: si può cogliervi una sedi-
mentata componente di organizzazione e di uso della
collina per la città, riferimento produttivo e di inse-
diamento di grange (
4
). Per contro le presenze sul
crinale del castello di Montosolo e della punta di
Monveglio, del castello di Cavoretto nella fascia
bassa, nei punti estremi del Po la formazione del
nucleo fortificato di Moncalieri a sud, della torre di
Muschie, per la difesa e guardia del nodo tra la piana
a nord e l'Abbadia di Stura compongono il quadro
dei nodi difensivi e organizzativi a latere della città
di Torino e del suo territorio collinare, cui si con-
trappone la bastida del monte dei Cappuccini (
5
) a
difesa del ponte sul Po.
La valle di Rialle è già citata, il riferimento al
castello di Montosolo fa presuppone un nodo
di
con-
trollo. Al principio del Quattrocento i sei Sapienti
del Comune di Torino fecero aprire una strada nuova
partendo dal ponte sul Po, vicino alla chiesa di San
Saverio, attraverso gli orti di Antonio Nicolazzo,
verso Santa Margherita (19 novembre 1401) (
6
).
Si è già sottolineato come le valli della collina,
assiate est-ovest siano caratterizzate geomorfologi-
camente da una notevole erosione del lato nord, che
risulta più ripido, umido e boscato, di difficile tra-
sformazione rispetto alle colture; esse risultano co-
stituite, sul lato sud, da ciglioni e declivi estesi e ben
soleggiati.
Lo strutturarsi di elementi insediativi funzionali
agricoli in epoca medievale — a parte i pochi resti
che ancora si possano evidenziare nelle trasforma-
zioni successive intervenute si può ipotizzare in
grange collocate a metà costa, nei limiti di una con-
duzione funzionale del fondo.
La tendenza delle strade antiche è o di seguire il
corso dei torrenti di fondo valle, come traccia pre-
minente e memorizzabile, oppure di sfruttare i crina-
li, sia quale elemento di riferimento con altri sia
quale organizzazione spaziale e difensiva. La strada
antica per Chieri della valle di Reaglie segue il fon-
da valle, la strada chiamata di Doragrossa (strada di
Santa Margherita) segue il crinale, sfruttando la qua-
lità dei siti in funzione dell'insediato, nella ipotesi di
una componente ergonomica selettiva.
Si può ipotizzare che risalga al Cinquecento una
organizzazione stradale che affianchi il percorso del
Po in senso longitudinale, sfruttando anche la via
d'acqua; materializzata da un percorso sulla sponda
destra da Moncalieri a S. Mauro ha nel ponte sul Po
il suo snodo centrale. Su tale asse si innervano le
strade di Reaglie verso Chieri, di S. Margherita ver-
so Pecetto e della strada antica di S. Vito verso
Revigliasco. A nord il porto della abbadia di Stura
come traghetto.
Riferimento di base per la comprensione dell'in-
frastruttura collinare risulta la
CARTE I DE LA
MONTAGNE I DE TURIN I [...], [ 1694-1703];
essa
si propone come documento fondante per la nitida
trascrizione di ogni elemento sia in senso geomorfi-
co sia antropico, restituendo una immagine puntuale
nella definizione dei siti, corretta nel rilevamento
topografico con ombreggiature nella intenzione di
dare il modellato collinare, nei limiti delle tecniche
coeve.
Tale carta, in certo modo, condensa i segni del-
l'avvenuta appropriazione della città da parte dei
Savoia e la trasformazione del territorio circostante.
Nel ribaltamento della loro politica al di qua dei
monti, avendo eletto e scelto il polo torinese come
capitale del proprio ducato, i duchi modificarono
infatti profondamente «per opere» il senso della cit-
tà e del suo intorno. La carta rileva i mutui rapporti
che legano la città, la sua cinta fortificata, la cittadel-
la e i borghi esterni nella «étendue de la pleine de-
puis le Sangon jusqu'à la Sture», evidenziati nel
disegno delle strade che conducono alla Capitale e
nella rilevanza prefigurata dei casini venatori del
Parco Vecchio, del Valentino e di Mirafiori. Netto
elemento separatore il Po, mediato dal ponte al bor-
go estramuraneo nella zona pedecollinare. E al di là,
ben evidenziate graficamente nel segno delle ombre,
le valli ortogonali al corso del fiume e il sistema di
cresta da Superga fino a Moncalieri: ove viene minu-
tamente fissata la rete dei torrenti che si ramificano
nelle valli, la dinamica dei solchi vallivi di « indrit-
ti » solivi e di « inversi » bacii, la potenziata struttura
dei percorsi e la dislocazione dell'abitato, qualifica-
to dal titolo di proprietà o dal toponimo (
7
).
Al di là della discussione sui tipi edilizi, cui si
rimanda, preme sottolineare invece la sensazione
della acquisizione netta della collina, che nella sua
strutturazione si costituisce quasi come un'altra città
rispetto alla città murata (
8
), quasi come un com-
plementare « gran teatro » , in cui la rappresentazione
del vivere in villa tende a qualificarsi come compo-
nente semantica di tutto l'insediato, anche se rimane
sempre notevole la componente funzionale: la rete di
strade è fittissima, più che in pianura e non risulta
differenziata nel segno grafico che nella connotazio-
ne di viali e di allee alberate. La distribuzione del-
l'insediamento è abbastanza omogenea, non sono
segnati confini di proprietà.
Si leggono chiaramente strade di valle, strade di
crinale o di cresta, strade di legamento tra strade
basse di valle e di cresta, con percorsi che tendono a
778


















