
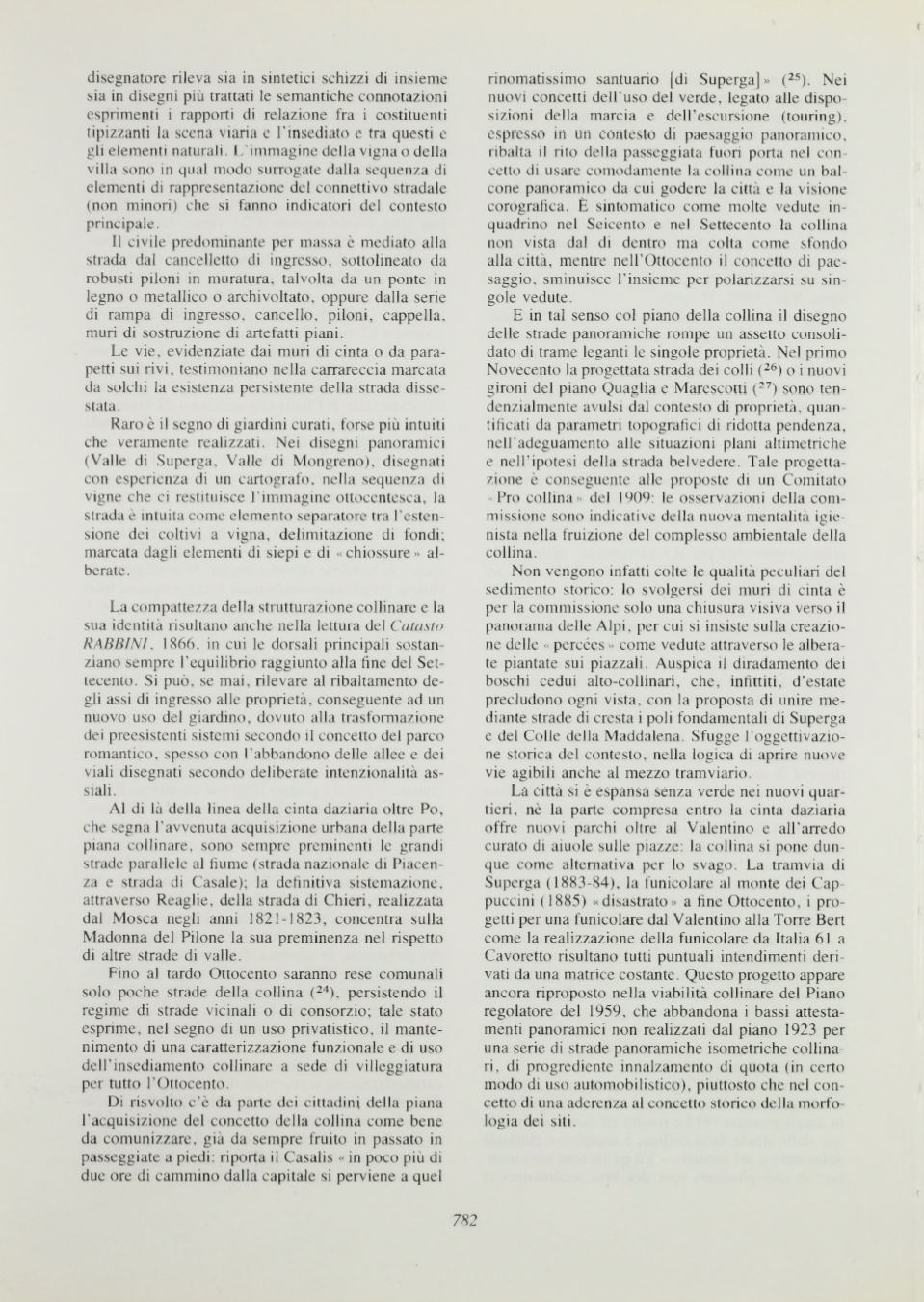
disegnatore rileva sia in sintetici schizzi di insieme
sia in disegni più trattati le semantiche connotazioni
esprimenti i rapporti di relazione fra i costituenti
tipizzanti la scena viaria e l'insediato e tra questi
e
gli elementi naturali. L'immagine della vigna o della
villa sono in qual modo surrogate dalla sequenza di
elementi di rappresentazione del connettivo stradale
(non minori) che si fanno indicatori del contesto
principale.
Il civile predominante per massa è mediato alla
strada dal cancelletto di ingresso, sottolineato da
robusti piloni in muratura, talvolta da un ponte in
legno o metallico o archivoltato, oppure dalla serie
di rampa di ingresso, cancello, piloni, cappella,
muri di costruzione di artefatti piani.
Le vie, evidenziate dai muri di cinta o da para-
petti sui rivi, testimoniano nella carrareccia marcata
da solchi la esistenza persistente della strada disse-
stata.
Raro è il segno di giardini curati, forse più intuiti
che veramente realizzati. Nei disegni panoramici
(Valle di Superga, Valle di Mongreno), disegnati
con esperienza di un cartografo, nella sequenza di
vigne che ci restituisce l'immagine ottocentesca, la
strada è intuita come elemento separatore tra l'esten-
sione dei coltivi a vigna, delimitazione di fondi;
marcata dagli elementi di siepi e di «chiossure» al-
berate.
La compattezza della strutturazione collinare e la
sua identità risultano anche nella lettura del
Catasto
RABBINI ,
1866, in cui le dorsali principali sostan-
ziano sempre l'equilibrio raggiunto alla fine del Set-
tecento. Si può, se mai, rilevare al ribaltamento de-
gli assi di ingresso alle proprietà, conseguente ad un
nuovo uso del giardino, dovuto alla trasformazione
dei preesistenti sistemi secondo il concetto del parco
romantico, spesso con l'abbandono delle allee e dei
viali disegnati secondo deliberate intenzionalità as-
siali.
Al di là della linea della cinta daziaria oltre Po,
che segna l'avvenuta acquisizione urbana della parte
piana collinare, sono sempre preminenti le grandi
strade parallele al fiume (strada nazionale di Piacen-
za e strada di Casale); la definitiva sistemazione,
attraverso Reaglie, della strada di Chieri, realizzata
dal Mosca negli anni 1821-1823, concentra sulla
Madonna del Pilone la sua preminenza nel rispetto
di altre strade di valle.
Fino al tardo Ottocento saranno rese comunali
solo poche strade della collina (
24
), persistendo il
regime di strade vicinali o di consorzio; tale stato
esprime, nel segno di un uso privatistico, il mante-
nimento di una caratterizzazione funzionale e di uso
dell'insediamento collinare a sede di villeggiatura
per tutto l'Ottocento.
Di risvolto c'è da parte dei cittadini della piana
l'acquisizione del concetto della collina come bene
da comunizzare, già da sempre fruito in passato in
passeggiate a piedi: riporta il Casalis «in poco più di
due ore di cammino dalla capitale si perviene a quel
rinomatissimo santuario [di Superga] » (
25
). Nei
nuovi concetti dell'uso del verde, legato alle dispo-
sizioni della marcia e dell'escursione (tou ring),
espresso in un contesto di paesaggio panoramico,
ribalta il rito della passeggiata fuori porta nel con-
cetto di usare comodamente la collina come un bal-
cone panoramico da cui godere la città e la visione
corografica. È sintomatico come molte vedute in-
quadrino nel Seicento e nel Settecento la collina
non vista dal di dentro ma colta come sfondo
alla città, mentre nell'Ottocento il concetto di pae-
saggio, sminuisce l'insieme per polarizzarsi su sin-
gole vedute.
E in tal senso col piano della collina il disegno
delle strade panoramiche rompe un assetto consoli-
dato di trame leganti le singole proprietà. Nel primo
Novecento la progettata strada dei colli (
26
) o i nuovi
gironi del piano Quaglia e Marescotti (
27
) sono ten-
denzialmente avulsi dal contesto di proprietà, quan-
tificati da parametri topografici di ridotta pendenza,
nell'adeguamento alle situazioni plani altimetriche
e nell'ipotesi della strada belvedere. Tale progetta-
zione è conseguente alle proposte di un Comitato
«Pro collina» del 1909: le osservazioni della com-
missione sono indicative della nuova mentalità igie-
nista nella fruizione del complesso ambientale della
collina.
Non vengono infatti colte le qualità peculiari del
sedimento storico: lo svolgersi dei muri di cinta è
per la commissione solo una chiusura visiva verso il
panorama delle Alpi, per cui si insiste sulla creazio-
ne delle « percées » come vedute attraverso le albera-
te piantate sui piazzali. Auspica il diradamento dei
boschi cedui alto-collinari, che, infittiti, d'estate
precludono ogni vista, con la proposta di unire me-
diante strade di cresta i poli fondamentali di Superga
e del Colle della Maddalena. Sfugge l'oggettivazio-
ne storica del contesto, nella logica di aprire nuove
vie agibili anche al mezzo tramviario.
La città si è espansa senza verde nei nuovi quar-
tieri, nè la parte compresa entro la cinta daziaria
offre nuovi parchi oltre al Valentino e all'arredo
curato di aiuole sulle piazze: la collina si pone dun-
que come alternativa per lo svago. La tramvia di
Superga (1883-84), la funicolare al monte dei Cap-
puccini (1885) «disastrato» a fine Ottocento, i pro-
getti per una funicolare dal Valentino alla Torre Bert
come la realizzazione della funicolare da Italia 61 a
Cavoretto risultano tutti puntuali intendimenti deri-
vati da una matrice costante. Questo progetto appare
ancora riproposto nella viabilità collinare del Piano
regolatore del 1959, che abbandona i bassi attesta-
menti panoramici non realizzati dal piano 1923 per
una serie di strade panoramiche isometriche collina-
ri, di progrediente innalzamento di quota (in certo
modo di uso automobilistico), piuttosto che nel con-
cetto di una aderenza al concetto storico della morfo-
logia dei siti.
782


















