
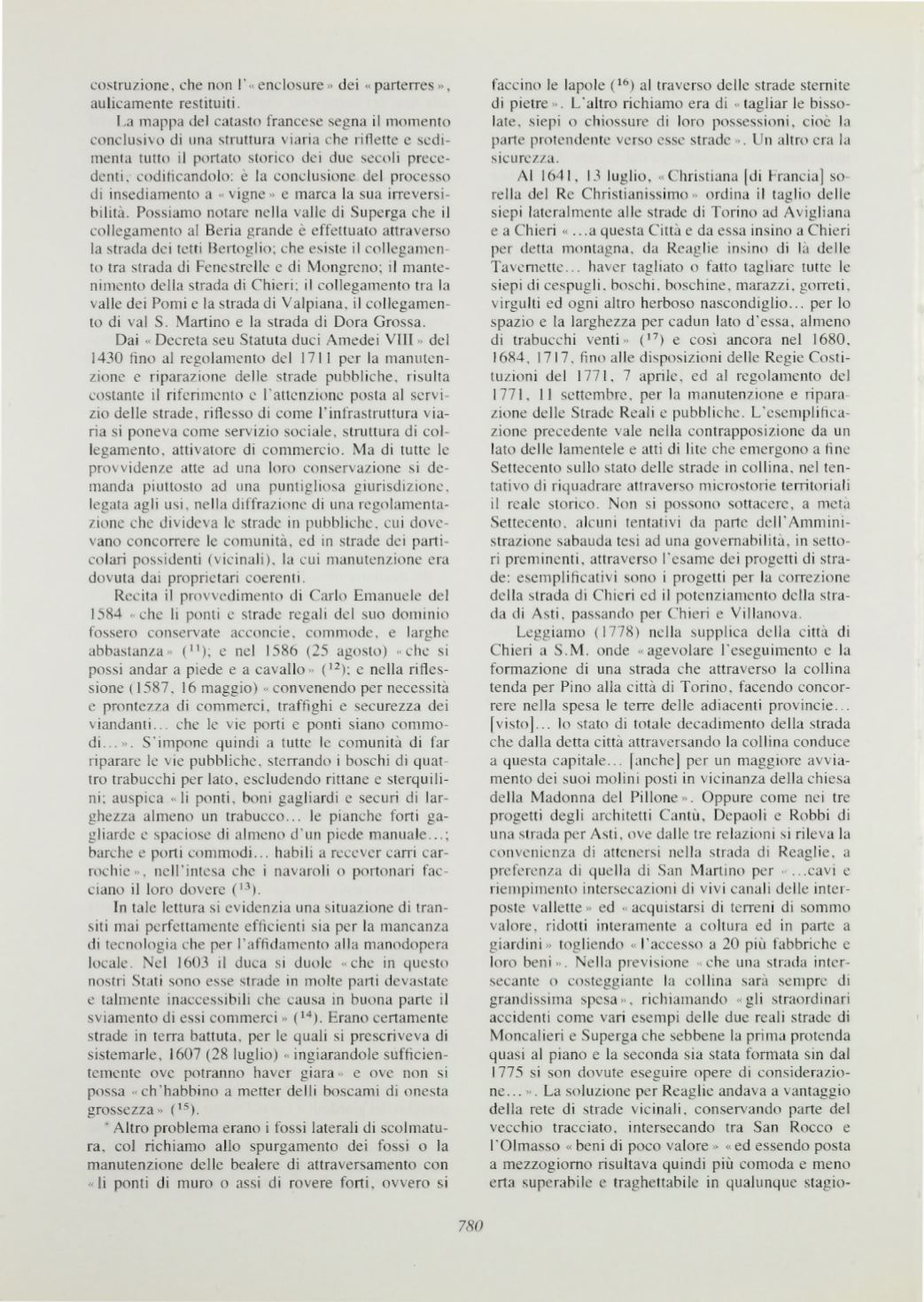
costruzione, che non 1' « enclosure » dei « parterres »,
aulicamente restituiti.
La mappa del catasto francese segna il momento
conclusivo di una struttura viaria che riflette e sedi-
menta tutto il portato storico dei due secoli prece-
denti, codificandolo: è la conclusione del processo
di insediamento a « vigne » e marca la sua irreversi-
bilità. Possiamo notare nella valle di Superga che il
collegamento al Beria grande è effettuato attraverso
la strada dei tetti Bertoglio; che esiste il collegamen-
to tra strada di Fenestrelle e di Mongreno; il mante-
nimento della strada di Chieri; il collegamento tra la
valle dei Pomi e la strada di Valpiana, il collegamen-
to di val S. Ma rtino e la strada di Dora Grossa.
Dai « Decreta seu Statuta duci Amedei VIII» del
1430 fino al regolamento del 1711 per la manuten-
zione e riparazione delle strade pubbliche, risulta
costante il riferimento e l'attenzione posta al servi-
zio delle strade, riflesso di come l'infrastruttura via-
ria si poneva come servizio sociale, struttura di col-
legamento, attivatore di commercio. Ma di tutte le
provvidenze atte ad una loro conservazione si de-
manda piuttosto ad una puntigliosa giurisdizione,
legata agli usi, nella diffrazione di una regolamenta-
zione che divideva le strade in pubbliche, cui dove-
vano concorrere le comunità, ed in strade dei parti-
colari possidenti (vicinali), la cui manutenzione era
dovuta dai proprietari coerenti.
Recita il provvedimento di Carlo Emanuele del
1584 « che li ponti e strade regali del suo dominio
fossero conservate acconcie, commode, e larghe
abbastanza» (
11
); e nel 1586 (25 agosto) «che si
possi andar a piede e a cavallo» (
12
); e nella rifles-
sione (1587, 16 maggio) «convenendo per necessità
e prontezza di commerci, traffighi e securezza dei
viandanti... che le vie porti e ponti siano commo-
di... ». S'impone quindi a tutte le comunità di far
riparare le vie pubbliche, sterrando i boschi di quat-
tro trabucchi per lato, escludendo rittane e sterquili-
ni; auspica « li ponti, boni gagliardi e securi di lar-
ghezza almeno un trabucco... le pianche forti ga-
gliarde e spaciose di almeno d'un piede manuale...;
barche e porti commodi... habili a recever carri car-
rochie », nell'intesa che i navaroli o portonari fac-
ciano il loro dovere (13)
In tale lettura si evidenzia una situazione di tran-
siti mai perfettamente efficienti sia per la mancanza
di tecnologia che per l'affidamento alla manodopera
locale. Nel 1603 il duca si duole « che in questo
nostri Stati sono esse strade in molte parti devastate
e talmente inaccessibili che causa in buona parte il
sviamento di essi commerci» (
14
). Erano certamente
strade in terra battuta, per le quali si prescriveva di
sistemarle, 1607 (28 luglio) « ingiarandole sufficien-
temente ove potranno haver giara » e ove non si
possa « ch'habbino a metter delli boscami di onesta
grossezza » (15)
' Altro problema erano i fossi laterali di scolmatu-
ra, col richiamo allo spurgamento dei fossi o la
manutenzione delle bealere di attraversamento con
«li ponti di muro o assi di rovere forti, ovvero si
faccino le lapole (
16
) al traverso delle strade sternite
di pietre ». L'altro richiamo era di « tagliar le bisso-
late, siepi o chiossure di loro possessioni, cioè la
parte protendente verso esse strade » . Un altro era la
sicurezza.
Al 1641, 13 luglio, « Christiana [di Francia] so-
rella del Re Christianissimo » ordina il taglio delle
siepi lateralmente alle strade di Torino ad Avigliana
e a Chieri « ...a questa Città e da essa insino a Chieri
per detta montagna, da Reaglie insino di là delle
Tavernette... haver tagliato o fatto tagliare tutte le
siepi di cespugli, boschi, boschine, marazzi, gorreti,
virgulti ed ogni altro herboso nascondiglio... per lo
spazio e la larghezza per cadun lato d'essa, almeno
di trabucchi venti» (
17
) e così ancora nel 1680,
1684, 1717, fino alle disposizioni delle Regie Costi-
tuzioni del 1771, 7 aprile, ed al regolamento del
1771, 11 settembre, per la manutenzione e ripara-
zione delle Strade Reali e pubbliche. L'esemplifica-
zione precedente vale nella contrapposizione da un
lato delle lamentele e atti di lite che emergono a fine
Settecento sullo stato delle strade in collina, nel ten-
tativo di riquadrare attraverso microstorie territoriali
il reale storico. Non si possono sottacere, a metà
Settecento, alcuni tentativi da parte dell'Ammini-
strazione sabauda tesi ad una governabilità, in setto-
ri preminenti, attraverso l'esame dei progetti di stra-
de: esemplificativi sono i progetti per la correzione
della strada di Chieri ed il potenziamento della stra-
da di Asti, passando per Chieri e Villanova.
Leggiamo (1778) nella supplica della città di
Chieri a S.M. onde «agevolare l'eseguimento e la
formazione di una strada che attraverso la collina
tenda per Pino alla città di Torino, facendo concor-
rere nella spesa le terre delle adiacenti provincie...
[visto]... lo stato di totale decadimento della strada
che dalla detta città attraversando la collina conduce
a questa capitale... [anche] per un maggiore avvia-
mento dei suoi molini posti in vicinanza della chiesa
della Madonna del Pillone ». Oppure come nei tre
progetti degli architetti Cantù, Depaoli e Robbi di
una strada per Asti, ove dalle tre relazioni si rileva la
convenienza di attenersi nella strada di Reaglie, a
preferenza di quella di San Martino per « ...cavi e
riempimento intersecazioni di vivi canali delle inter-
poste vallette » ed « acquistarsi di terreni di sommo
valore, ridotti interamente a coltura ed in parte a
giardini» togliendo «l'accesso a 20 più fabbriche e
loro beni ». Nella previsione « che una strada inter-
secante o costeggiante la collina sarà sempre di
grandissima spesa », richiamando « gli straordinari
accidenti come vari esempi delle due reali strade di
Moncalieri e Superga che sebbene la prima protenda
quasi al piano e la seconda sia stata formata sin dal
1775 si son dovute eseguire opere di considerazio-
ne... ». La soluzione per Reaglie andava a vantaggio
della rete di strade vicinali, conservando parte del
vecchio tracciato, intersecando tra San Rocco e
l'Olmasso « beni di poco valore » « ed essendo posta
a mezzogiorno risultava quindi più comoda e meno
erta superabile e traghettabile in qualunque stagio-
780


















