
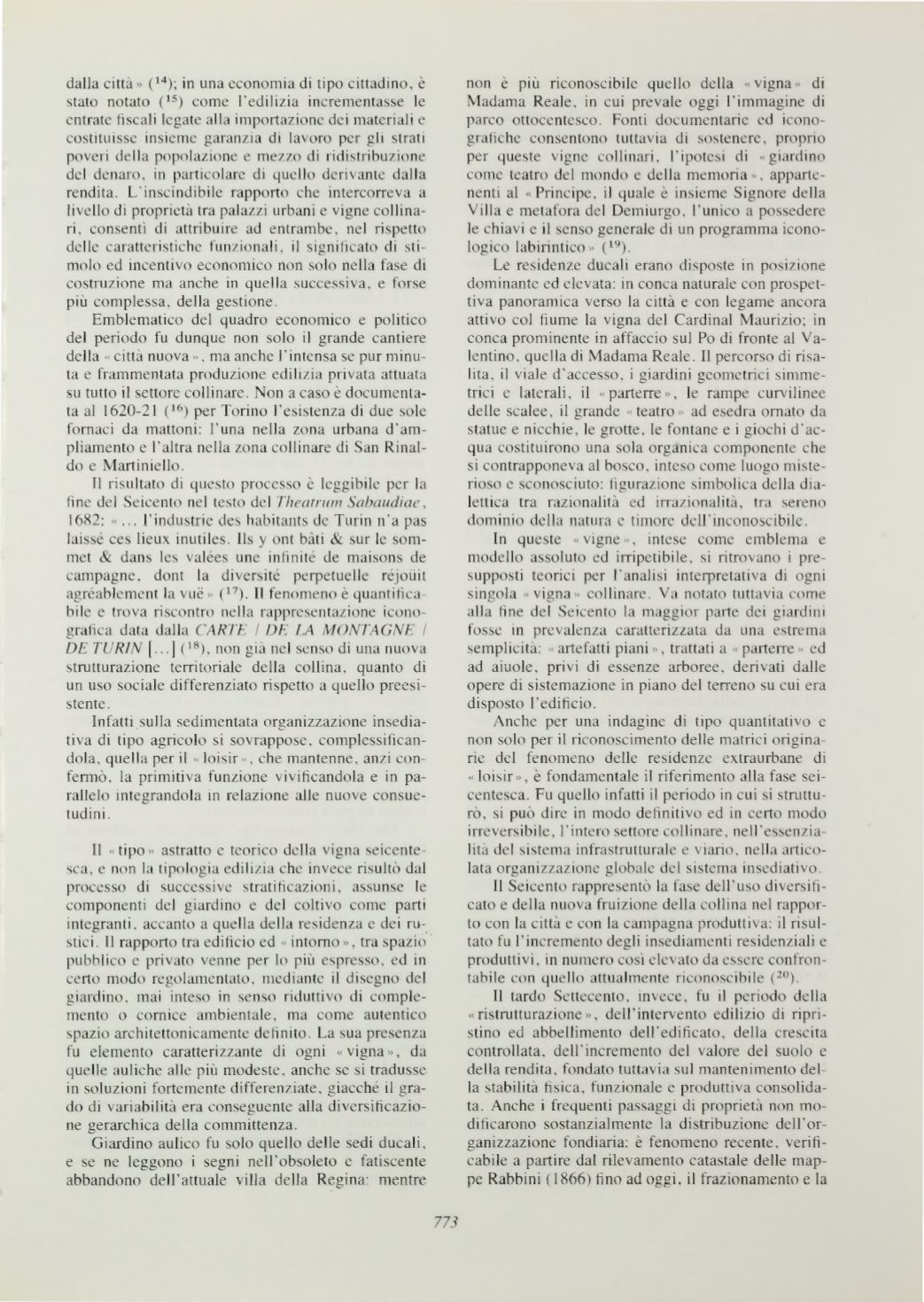
dalla città» (
14
); in una economia di tipo cittadino, è
stato notato (
15
) come l'edilizia incrementasse le
entrate fiscali legate alla importazione dei materiali e
costituisse insieme garanzia di lavoro per gli strati
poveri della popolazione e mezzo di ridistribuzione
del denaro, in particolare di quello derivante dalla
rendita. L'inscindibile rapporto che intercorreva a
livello di proprietà tra palazzi urbani e vigne collina-
ri, consentì di attribuire ad entrambe, nel rispetto
delle caratteristiche funzionali, il significato di sti-
molo ed incentivo economico non solo nella fase di
costruzione ma anche in quella successiva, e forse
più complessa, della gestione.
Emblematico del quadro economico e politico
del periodo fu dunque non solo il grande cantiere
della « città nuova » , ma anche l'intensa se pur minu-
ta e frammentata produzione edilizia privata attuata
su tutto il settore collinare. Non a caso è documenta-
ta al 1620-21 (
16
) per Torino l'esistenza di due sole
fornaci da mattoni: l'una nella zona urbana d'am-
pliamento e l'altra nella zona collinare di San Rinal-
do e Martiniello.
Il risultato di questo processo è leggibile per la
fine del Seicento nel testo del
Theatrum Sabaudiae,
1682: « ... l'industrie des habitants de Turin n'a pas
laissé ces lieux inutiles. Ils y ont bàti & sur le som-
met & dans les valées une infinité de maisons de
campagne, dont la diversité perpetuelle réjoiiit
agréablement la vué» (
17
). Il fenomeno è quantifica-
bile e trova riscontro nella rappresentazione icono-
grafica data dalla
CARTE I DE LA MONTAGNE I
DE TURIN [...]
(
18
), non già nel senso di una nuova
strutturazione territoriale della collina, quanto di
un uso sociale differenziato rispetto a quello preesi-
stente.
Infatti sulla sedimentata organizzazione insedia-
tiva di tipo agricolo si sovrappose, complessifican-
dola, quella per il « loisir», che mantenne, anzi con-
fermò, la primitiva funzione vivificandola e in pa-
rallelo integrandola in relazione alle nuove consue-
tudini.
Il « tipo» astratto e teorico della vigna seicente-
sca, e non la tipologia edilizia che invece risultò dal
processo di successive stratificazioni, assunse le
componenti del giardino e del coltivo come parti
integranti, accanto a quella della residenza e dei ru-
stici. Il rapporto tra edificio ed « intorno » , tra spazio
pubblico e privato venne per lo più espresso, ed in
certo modo regolamentato, mediante il disegno del
giardino, mai inteso in senso riduttivo di comple-
mento o cornice ambientale, ma come autentico
spazio architettonicamente definito. La sua presenza
fu elemento caratterizzante di ogni «vigna», da
quelle auliche alle più modeste, anche se si tradusse
in soluzioni fortemente differenziate, giacché il gra-
do di variabilità era conseguente alla diversificazio-
ne gerarchica della committenza.
Giardino aulico fu solo quello delle sedi ducali,
e se ne leggono i segni nell'obsoleto e fatiscente
abbandono dell'attuale villa della Regina: mentre
non è più riconoscibile quello della «vigna» di
Madama Reale, in cui prevale oggi l'immagine di
parco ottocentesco. Fonti documentarie ed icono-
grafiche consentono tuttavia di sostenere, proprio
per queste vigne collinari, l'ipotesi di « giardino
come teatro del mondo e della memoria», apparte-
nenti al « Principe, il quale è insieme Signore della
Villa e metafora del Demiurgo, l'unico a possedere
le chiavi e il senso generale di un programma icono-
logico labirintico» (19)
Le residenze ducali erano disposte in posizione
dominante ed elevata: in conca naturale con prospet-
tiva panoramica verso la città e con legame ancora
attivo col fiume la vigna del Cardinal Maurizio; in
conca prominente in affaccio sul Po di fronte al Va-
lentino, quella di Madama Reale. Il percorso di risa-
lita, il viale d'accesso, i giardini geometrici simme-
trici e laterali, il «parterre», le rampe curvilinee
delle scalee, il grande « teatro » ad esedra ornato da
statue e nicchie, le grotte, le fontane e i giochi d'ac-
qua costituirono una sola organica componente che
si contrapponeva al bosco, inteso come luogo miste-
rioso e sconosciuto: figurazione simbolica della dia-
lettica tra razionalità ed irrazionalità, tra sereno
dominio della natura e timore dell'inconoscibile.
In queste « vigne », intese come emblema e
modello assoluto ed irripetibile, si ritrovano i pre-
supposti teorici per l'analisi interpretativa di ogni
singola « vigna» collinare. Va notato tuttavia come
alla fine del Seicento la maggior parte dei giardini
fosse in prevalenza caratterizzata da una estrema
semplicità: « artefatti piani », trattati a « pa rterre » ed
ad aiuole, privi di essenze arboree, derivati dalle
opere di sistemazione in piano del terreno su cui era
disposto l'edificio.
Anche per una indagine di tipo quantitativo e
non solo per il riconoscimento delle matrici origina-
rie del fenomeno delle residenze extraurbane di
loisir», è fondamentale il riferimento alla fase sei-
centesca. Fu quello infatti il periodo in cui si struttu-
rò, si può dire in modo definitivo ed in certo modo
irreversibile, l'intero settore collinare, nell'essenzia-
lità del sistema infrastrutturale e viario, nella artico-
lata organizzazione globale del sistema insediativo.
Il Seicento rappresentò la fase dell'uso diversifi-
cato e della nuova fruizione della collina nel rappor-
to con la città e con la campagna produttiva: il risul-
tato fu l'incremento degli insediamenti residenziali e
produttivi, in numero così elevato da essere confron-
tabile con quello attualmente riconoscibile (
20
).
Il tardo Settecento, invece, fu il periodo della
ristrutturazione », dell'intervento edilizio di ripri-
stino ed abbellimento dell'edificato, della crescita
controllata, dell'incremento del valore del suolo e
della rendita, fondato tuttavia sul mantenimento del-
la stabilità fisica, funzionale e produttiva consolida-
ta. Anche i frequenti passaggi di proprietà non mo-
dificarono sostanzialmente la distribuzione dell'or-
ganizzazione fondiaria: è fenomeno recente, verifi-
cabile a partire dal rilevamento catastale delle map-
pe Rabbini (1866) fino ad oggi, il frazionamento e la
773


















