
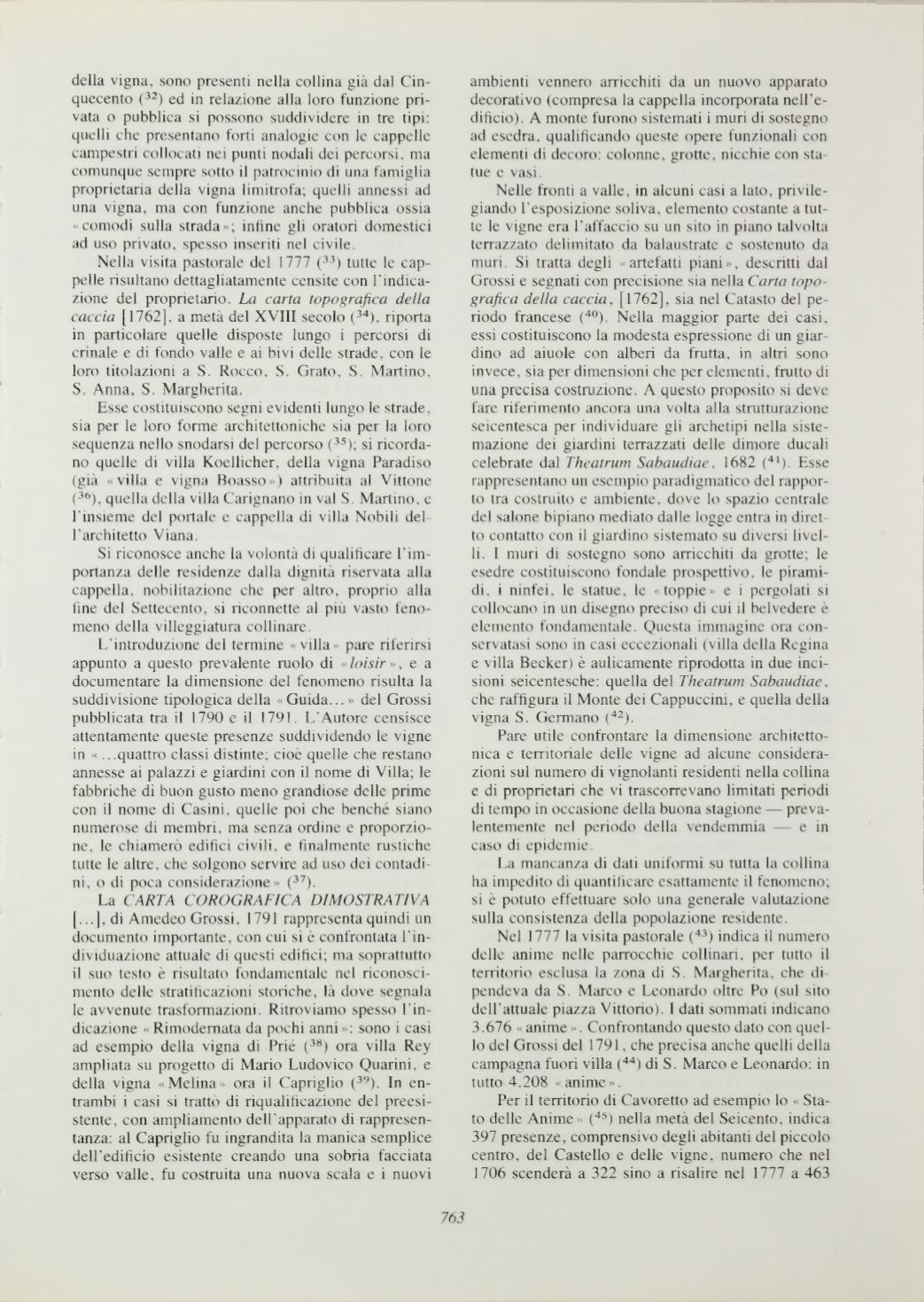
della vigna, sono presenti nella collina già dal Cin-
quecento (
32
) ed in relazione alla loro funzione pri-
vata o pubblica si possono suddividere in tre tipi:
quelli che presentano forti analogie con le cappelle
campestri collocati nei punti nodali dei percorsi, ma
comunque sempre sotto il patrocinio di una famiglia
proprietaria della vigna limitrofa; quelli annessi ad
una vigna, ma con funzione anche pubblica ossia
« comodi sulla strada»; infine gli oratori domestici
ad uso privato, spesso inseriti nel civile.
Nella visita pastorale del 1777 (
33
) tutte le cap-
pelle risultano dettagliatamente censite con l'indica-
zione del proprietario.
La carta topografica detla
caccia
[17621, a metà del XVIII secolo (
34
), riporta
in particolare quelle disposte lungo i percorsi di
crinale e di fondo valle e ai bivi delle strade, con le
loro titolazioni a S. Rocco, S. Grato, S. Ma
rt
ino,
S. Anna, S. Margherita.
Esse costituiscono segni evidenti lungo le strade,
sia per le loro forme architettoniche sia per la loro
sequenza nello snodarsi del percorso (
35
); si ricorda-
no quelle di villa Koellicher, della vigna Paradiso
(già « villa e vigna Boasso ») attribuita al Vittone
(
36
), quella della villa Carignano in val S. Ma
rt
ino, e
l'insieme del portale e cappella di villa Nobili del-
l'architetto Viana.
Si riconosce anche la volontà di qualificare l'im-
portanza delle residenze dalla dignità riservata alla
cappella, nobilitazione che per altro, proprio alla
fine del Settecento, si riconnette al più vasto feno-
meno della villeggiatura collinare.
L'introduzione del termine «villa» pare riferirsi
appunto a questo prevalente ruolo di «
toisir» ,
e a
documentare la dimensione del fenomeno risulta la
suddivisione tipologica della « Guida... » del Grossi
pubblicata tra il 1790 e il 1791. L'Autore censisce
attentamente queste presenze suddividendo le vigne
in « ...quattro classi distinte; cioè quelle che restano
annesse ai palazzi e giardini con il nome di Villa; le
fabbriche di buon gusto meno grandiose delle prime
con il nome di Casini, quelle poi che benché siano
numerose di membri, ma senza ordine e proporzio-
ne, le chiamerò edifici civili, e finalmente rustiche
tutte le altre, che solgono servire ad uso dei contadi-
ni, o di poca considerazione» (
37
).
La
CARTA COROGRAFICA DIMOSTRATIVA
[...], di Amedeo Grossi, 1791 rappresenta quindi un
documento importante, con cui si è confrontata l'in-
dividuazione attuale di questi edifici; ma soprattutto
il suo testo è risultato fondamentale nel riconosci-
mento delle stratificazioni storiche, là dove segnala
le avvenute trasformazioni. Ritroviamo spesso l'in-
dicazione « Rimodernata da pochi anni »: sono i casi
ad esempio della vigna di Prié (
38
) ora villa Rey
ampliata su progetto di Mario Ludovico Quarini, e
della vigna « Melina » ora il Capriglio (
39
). In en-
trambi i casi si trattò di riqualificazione del preesi-
stente, con ampliamento dell'apparato di rappresen-
tanza: al Capriglio fu ingrandita la manica semplice
dell'edificio esistente creando una sobria facciata
verso valle, fu costruita una nuova scala e i nuovi
ambienti vennero arricchiti da un nuovo apparato
decorativo (compresa la cappella incorporata nell'e-
dificio). A monte furono sistemati i muri di sostegno
ad esedra, qualificando queste opere funzionali con
elementi di decoro: colonne, grotte, nicchie con sta-
tue e vasi.
Nelle fronti a valle, in alcuni casi a lato, privile-
giando l'esposizione soliva, elemento costante a tut-
te le vigne era l'affaccio su un sito in piano talvolta
terrazzato delimitato da balaustrate e sostenuto da
muri. Si tratta degli « artefatti piani», descritti dal
Grossi e segnati con precisione sia nella
Carta topo-
grafica detta caccia,
[1762], sia nel Catasto del pe-
riodo francese (
40
). Nella maggior parte dei casi,
essi costituiscono la modesta espressione di un giar-
dino ad aiuole con alberi da frutta, in altri sono
invece, sia per dimensioni che per elementi, frutto di
una precisa costruzione. A questo proposito si deve
fare riferimento ancora una volta alla strutturazione
seicentesca per individuare gli archetipi nella siste-
mazione dei giardini terrazzati delle dimore ducali
celebrate dal
Theatrum Sabaudiae,
1682 (
41
). Esse
rappresentano un esempio paradigmatico del rappor-
to tra costruito e ambiente, dove lo spazio centrale
del salone bipiano mediato dalle logge entra in diret-
to contatto con il giardino sistemato su diversi livel-
li. I muri di sostegno sono arricchiti da grotte; le
esedre costituiscono fondale prospettivo, le pirami-
di, i ninfei, le statue, le «toppie» e i pergolati si
collocano in un disegno preciso di cui il belvedere è
elemento fondamentale. Questa immagine ora con-
servatasi sono in casi eccezionali (villa della Regina
e villa Becker) è aulicamente riprodotta in due inci-
sioni seicentesche: quella del
Theatrum Sabaudiae,
che raffigura il Monte dei Cappuccini, e quella della
vigna S. Germano (
42
).
Pare utile confrontare la dimensione architetto-
nica e territoriale delle vigne ad alcune considera-
zioni sul numero di vignolanti residenti nella collina
e di proprietari che vi trascorrevano limitati periodi
di tempo in occasione della buona stagione — preva-
lentemente nel periodo della vendemmia e in
caso di epidemie.
La mancanza di dati uniformi su tutta la collina
ha impedito di quantificare esattamente il fenomeno;
si è potuto effettuare solo una generale valutazione
sulla consistenza della popolazione residente.
Nel 1777 la visita pastorale (
43
) indica il numero
delle anime nelle parrocchie collinari, per tutto il
territorio esclusa la zona di S. Margherita, che di-
pendeva da S. Marco e Leonardo oltre Po (sul sito
dell'attuale piazza Vittorio). I dati sommati indicano
3.676 «anime». Confrontando questo dato con quel-
lo del Grossi del 1791, che precisa anche quelli della
campagna fuori villa (
44
) di S. Marco e Leonardo: in
tutto 4.208 « anime » .
Per il territorio di Cavoretto ad esempio lo « Sta-
to delle Anime » (
45
) nella metà del Seicento, indica
397 presenze, comprensivo degli abitanti del piccolo
centro, del Castello e delle vigne, numero che nel
1706 scenderà a 322 sino a risalire nel I777 a 463
763


















