
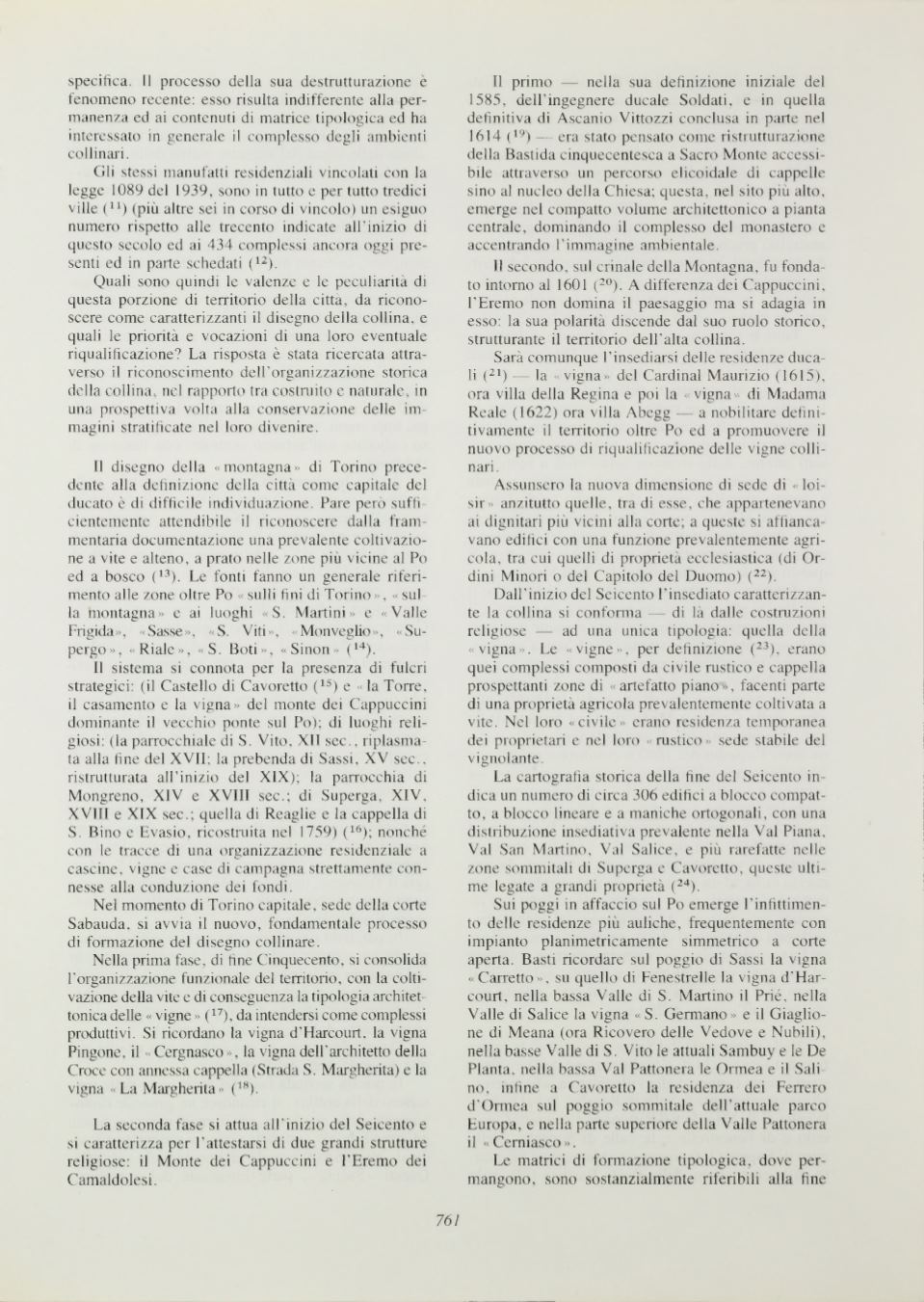
specifica. 11 processo della sua destrutturazione è
fenomeno recente: esso risulta indifferente alla per-
manenza ed ai contenuti di matrice tipologica ed ha
interessato in generale il complesso degli ambienti
collinari.
Gli stessi manufatti residenziali vincolati con la
legge 1089 del 1939, sono in tutto e per tutto tredici
ville
(11)
(più altre sei in corso di vincolo) un esiguo
numero rispetto alle trecento indicate all'inizio di
questo secolo ed ai 434 complessi ancora oggi pre-
senti ed in parte schedati (
12
).
Quali sono quindi le valenze e le peculiarità di
questa porzione di territorio della città, da ricono-
scere come caratterizzanti il disegno della collina, e
quali le priorità e vocazioni di una loro eventuale
riqualificazione? La risposta è stata ricercata attra-
verso il riconoscimento dell'organizzazione storica
della collina, nel rapporto tra costruito e naturale, in
una prospettiva volta alla conservazione delle im-
magini stratificate nel loro divenire.
Il disegno della « montagna» di Torino prece-
dente alla definizione della città come capitale del
ducato è di difficile individuazione. Pare però suffi-
cientemente attendibile il riconoscere dalla fram-
mentaria documentazione una prevalente coltivazio-
ne a vite e alteno, a prato nelle zone più vicine al Po
ed a bosco (
13
). Le fonti fanno un generale riferi-
mento alle zone oltre Po « sulli fini di Torino », « sul-
la montagna» e ai luoghi « S. Martini » e « Valle
Frigida», «Sasse», «S. Viti», «Monveglio», «Su-
pergo», « Riale»
,
«S. Boti », «Sinon» (14).
Il sistema si connota per la presenza di fulcri
strategici: (il Castello di Cavoretto (
15
) e «la Torre,
il casamento e la vigna» del monte dei Cappuccini
dominante il vecchio ponte sul Po); di luoghi reli-
giosi: (la parrocchiale di S. Vito, XII sec., riplasma-
ta alla fine del XVII; la prebenda di Sassi, XV sec.,
ristrutturata all'inizio del XIX); la parrocchia di
Mongreno, XIV e XVIII sec.; di Superga, XIV,
XVIII e XIX sec.; quella di Reaglie e la cappella di
S. Bino e Evasio, ricostruita nel 1759) (
16
); nonché
con le tracce di una organizzazione residenziale a
cascine, vigne e case di campagna strettamente con-
nesse alla conduzione dei fondi.
Nel momento di Torino capitale, sede della corte
Sabauda, si avvia il nuovo, fondamentale processo
di formazione del disegno collinare.
Nella prima fase, di fine Cinquecento, si consolida
l'organizzazione funzionale del territorio, con la colti-
vazione della vite e di conseguenza la tipologia architet-
tonica delle « vigne » (
17
), da intendersi come complessi
produttivi. Si ricordano la vigna d'Harcourt, la vigna
Pingone, il « Cergnasco », la vigna dell'architetto della
Croce con annessa cappella (Strada S. Margherita) e la
vigna « La Margherita» (
18
).
La seconda fase si attua all'inizio del Seicento e
si caratterizza per l'attestarsi di due grandi strutture
religiose: il Monte dei Cappuccini e l'Eremo dei
Camaldolesi.
Il primo nella sua definizione iniziale del
1585, dell'ingegnere ducale Soldati, e in quella
definitiva di Ascanio Vittozzi conclusa in parte nel
1614 (
19
) — era stato pensato come ristrutturazione
della Bastida cinquecentesca a Sacro Monte accessi-
bile attraverso un percorso elicoidale di cappelle
sino al nucleo della Chiesa; questa, nel sito più alto,
emerge nel compatto volume architettonico a pianta
centrale, dominando il complesso del monastero e
accentrando l'immagine ambientale.
Il secondo, sul crinale della Montagna, fu fonda-
to intorno al 1601 (
20
). A differenza dei Cappuccini,
l'Eremo non domina il paesaggio ma si adagia in
esso: la sua polarità discende dal suo ruolo storico,
strutturante il territorio dell'alta collina.
Sarà comunque l'insediarsi delle residenze duca-
li (
21
) la « vigna» del Cardinal Maurizio (1615),
ora villa della Regina e poi la «vigna» di Madama
Reale (1622) ora villa Abegg a nobilitare defini-
tivamente il territorio oltre Po ed a promuovere il
nuovo processo di riqualificazione delle vigne colli-
nari.
Assunsero la nuova dimensione di sede di « loi-
sir» anzitutto quelle, tra di esse, che appartenevano
ai dignitari più vicini alla corte; a queste si affianca-
vano edifici con una funzione prevalentemente agri-
cola, tra cui quelli di proprietà ecclesiastica (di Or-
dini Minori o del Capitolo del Duomo) (22).
Dall'inizio del Seicento l'insediato caratterizzan-
te la collina si conforma di là dalle costruzioni
religiose ad una unica tipologia: quella della
« vigna >>. Le « vigne » , per definizione (
23
), erano
quei complessi composti da civile rustico e cappella
prospettanti zone di « artefatto
piano»,
facenti parte
di una proprietà agricola prevalentemente coltivata a
vite. Nel loro « civile » erano residenza temporanea
dei proprietari e nel loro « rustico » sede stabile del
vignolante.
La cartografia storica della fine del Seicento in-
dica un numero di circa 306 edifici a blocco compat-
to, a blocco lineare e a maniche ortogonali, con una
distribuzione insediativa prevalente nella Val Piana,
Val San Ma
rt
ino, Val Salice, e più rarefatte nelle
zone sommitali di Superga e Cavoretto, queste ulti-
me legate a grandi proprietà (
24
).
Sui poggi in affaccio sul Po emerge l'infittimen-
to delle residenze più auliche, frequentemente con
impianto planimetricamente simmetrico a corte
aperta. Basti ricordare sul poggio di Sassi la vigna
Carretto » , su quello di Fenestrelle la vigna d'Har-
court, nella bassa Valle di S. Ma
rt
ino il Prié, nella
Valle di Salice la vigna S. Germano» e il Giaglio-
ne di Meana (ora Ricovero delle Vedove e Nubili),
nella basse Valle di S. Vito le attuali Sambuy e le De
Pianta, nella bassa Val Pattonera le Ormea e il Sali-
no, infine a Cavoretto la residenza dei Ferrero
d'Ormea sul poggio sommitale dell'attuale parco
Europa, e nella parte superiore della Valle Pattonera
il « Cerniasco ».
Le matrici di formazione tipologica, dove per-
mangono, sono sostanzialmente riferibili alla fine
761


















