
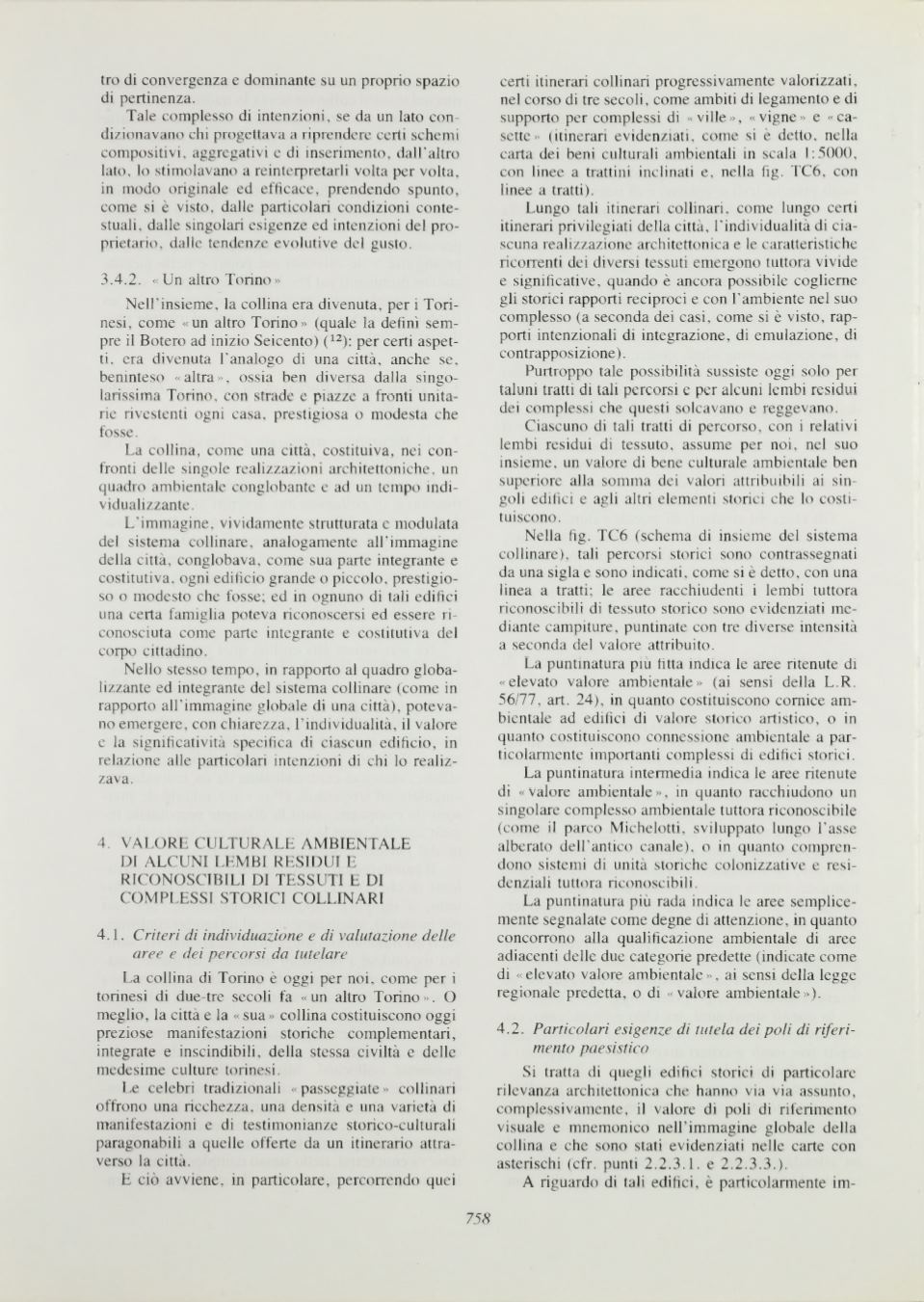
tro di convergenza e dominante su un proprio spazio
di pertinenza.
Tale complesso di intenzioni, se da un lato con-
dizionavano chi progettava a riprendere certi schemi
componitivi, aggregativi e di inserimento, dall'altro
lato, lo stimolavano a reinterpretarli volta per volta,
in modo originale ed efficace, prendendo spunto,
come si è visto, dalle particolari condizioni conte-
stuali, dalle singolari esigenze ed intenzioni del pro-
prietario, dalle tendenze evolutive del gusto.
3.4.2. « Un altro Torino »
Nell'insieme, la collina era divenuta, per i Tori-
nesi, come « un altro Torino » (quale la definì sem-
pre il Botero ad inizio Seicento) (
12
): per certi aspet-
ti, era divenuta l'analogo di una città, anche se,
beninteso « altra» , ossia ben diversa dalla singo-
larissima Torino, con strade e piazze a fronti unita-
rie rivestenti ogni casa, prestigiosa o modesta che
fosse.
La collina, come una città, costituiva, nei con-
fronti delle singole realizzazioni architettoniche, un
quadro ambientale conglobante e ad un tempo indi-
vidualizzante.
L'immagine, vividamente strutturata e modulata
del sistema collinare, analogamente all'immagine
della città, conglobava, come sua parte integrante e
costitutiva, ogni edificio grande o piccolo, prestigio-
so o modesto che fosse; ed in ognuno di tali edifici
una certa famiglia poteva riconoscersi ed essere ri-
conosciuta come parte integrante e costitutiva del
corpo cittadino.
Nello stesso tempo, in rapporto al quadro globa-
lizzante ed integrante del sistema collinare (come in
rapporto all'immagine globale di una città), poteva-
no emergere, con chiarezza, l'individualità, il valore
e la significatività specifica di ciascun edificio, in
relazione alle particolari intenzioni di chi lo realiz-
zava.
4. VALORE CULTURALE AMBIENTALE
DI ALCUNI LEMBI RESIDUI E
RICONOSCIBILI DI TESSUTI E DI
COMPLESSI STORICI COLLINARI
4.1.
Criteri di individuazione e di valutazione delle
aree e dei percorsi da tutetare
La collina di Torino è oggi per noi, come per i
torinesi di due-tre secoli fa « un altro Torino » . O
meglio, la città e la « sua » collina costituiscono oggi
preziose manifestazioni storiche complementari,
integrate e inscindibili, della stessa civiltà e delle
medesime culture torinesi.
Le celebri tradizionali « passeggiate » collinari
offrono una ricchezza, una densità e una varietà di
manifestazioni e di testimonianze storico-culturali
paragonabili a quelle offerte da un itinerario attra-
verso la città.
E ciò avviene, in particolare, percorrendo quei
certi itinerari collinari progressivamente valorizzati,
nel corso di tre secoli, come ambiti di legamento e di
supporto per complessi di « ville », « vigne » e « ca-
sette » (itinerari evidenziati, come si è detto, nella
carta dei beni culturali ambientali in scala 1:5000,
con linee a trattini inclinati e, nella fig. TC6, con
linee a tratti).
Lungo tali itinerari collinari, come lungo certi
itinerari privilegiati della città, l'individualità di cia-
scuna realizzazione architettonica e le caratteristiche
ricorrenti dei diversi tessuti emergono tuttora vivide
e significative, quando è ancora possibile coglierne
gli storici rapporti reciproci e con l'ambiente nel suo
complesso (a seconda dei casi, come si è visto, rap-
porti intenzionali di integrazione, di emulazione, di
contrapposizione).
Purtroppo tale possibilità sussiste oggi solo per
taluni tratti di tali percorsi e per alcuni lembi residui
dei complessi che questi solcavano e reggevano.
Ciascuno di tali tratti di percorso, con i relativi
lembi residui di tessuto, assume per noi, nel suo
insieme, un valore di bene culturale ambientale ben
superiore alla somma dei valori attribuibili ai sin-
goli edifici e agli altri elementi storici che lo costi-
tuiscono.
Nella fig. TC6 (schema di insieme del sistema
collinare), tali percorsi storici sono contrassegnati
da una sigla e sono indicati, come si è detto, con una
linea a tratti; le aree racchiudenti i lembi tuttora
riconoscibili di tessuto storico sono evidenziati me-
diante campiture, puntinate con tre diverse intensità
a seconda del valore attribuito.
La puntinatura più fitta indica le aree ritenute di
elevato valore ambientale » (ai sensi della L.R.
56/77, art. 24), in quanto costituiscono cornice am-
bientale ad edifici di valore storico artistico, o in
quanto costituiscono connessione ambientale a par-
ticolarmente importanti complessi di edifici storici.
La puntinatura intermedia indica le aree ritenute
di «valore ambientale», in quanto racchiudono un
singolare complesso ambientale tuttora riconoscibile
(come il parco Michelotti, sviluppato lungo l'asse
alberato dell'antico canale), o in quanto compren-
dono sistemi di unità storiche colonizzative e resi-
denziali tuttora riconoscibili.
La puntinatura più rada indica
le
aree semplice-
mente segnalate come degne di attenzione, in quanto
concorrono alla qualificazione ambientale di aree
adiacenti delle due categorie predette (indicate come
di « elevato valore ambientale», ai sensi della legge
regionale predetta, o di « valore ambientale »).
4.2.
Particotari esigenze di tutela dei poli di riferi-
mento paesistico
Si tratta di quegli edifici storici di particolare
rilevanza architettonica che hanno via via assunto,
complessivamente, il valore di poli di riferimento
visuale e mnemonico nell'immagine globale della
collina e che sono stati evidenziati nelle carte con
asterischi (cfr. punti 2.2.3.1. e 2.2.3.3.).
A riguardo di tali edifici, è particolarmente im-
758


















