
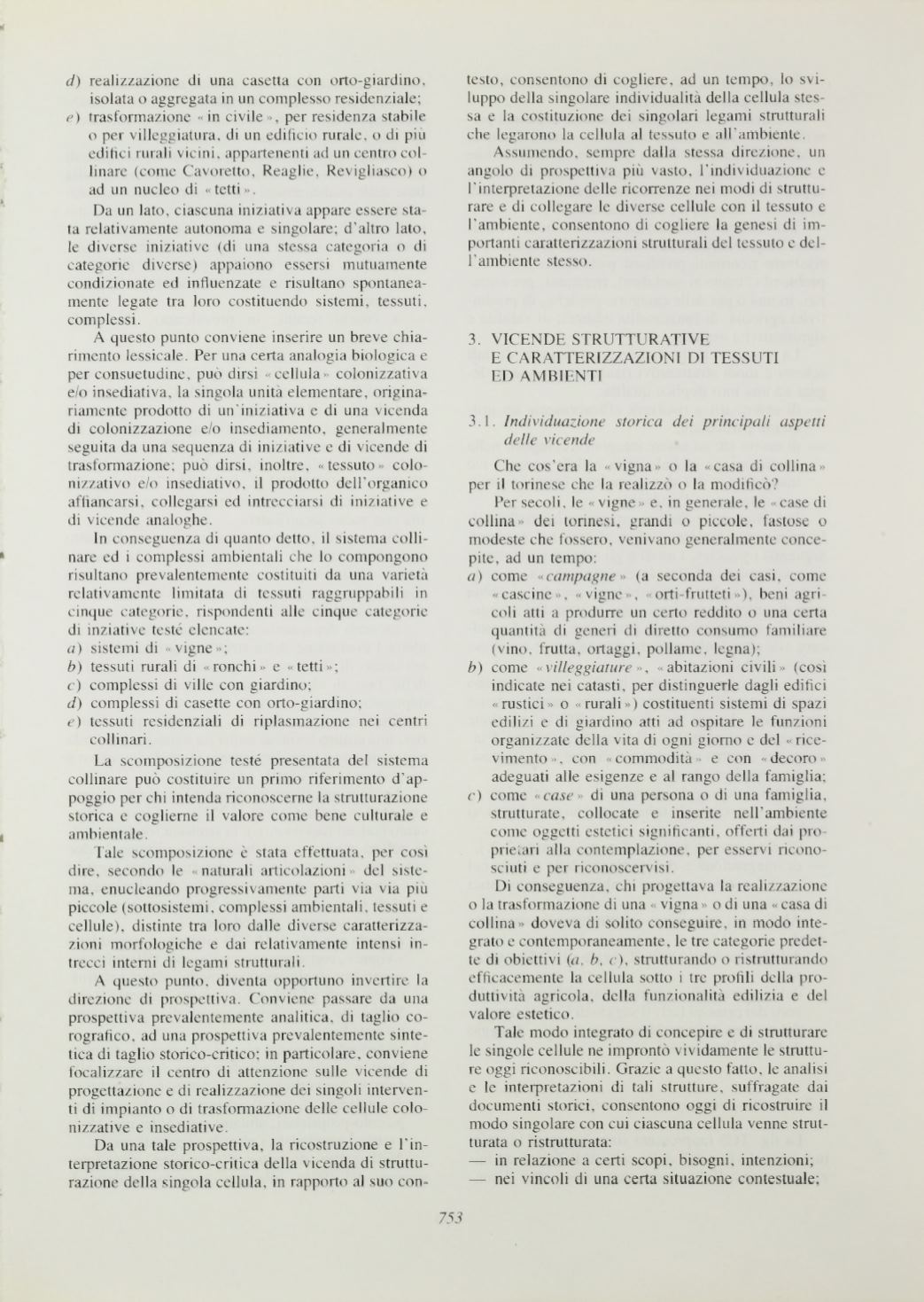
d) realizzazione di una casetta con orto-giardino,
isolata o aggregata in un complesso residenziale;
e) trasformazione « in civile», per residenza stabile
o per villeggiatura, di un edificio rurale, o di più
edifici rurali vicini, appartenenti ad un centro col-
linare (come Cavoretto, Reaglie, Revigliasco) o
ad un nucleo di «tetti» .
Da un lato, ciascuna iniziativa appare essere sta-
ta relativamente autonoma e singolare; d'altro lato,
le diverse iniziative (di una stessa categoria o di
categorie diverse) appaiono essersi mutuamente
condizionate ed influenzate e risultano spontanea-
mente legate tra loro costituendo sistemi, tessuti,
complessi.
A questo punto conviene inserire un breve chia-
rimento lessicale. Per una certa analogia biologica e
per consuetudine, può dirsi «cellula» colonizzativa
e/o insediativa, la singola unità elementare, origina-
riamente prodotto di un'iniziativa e di una vicenda
di colonizzazione e/o insediamento, generalmente
seguita da una sequenza di iniziative e di vicende di
trasformazione; può dirsi, inoltre, « tessuto » colo-
nizzativo e/o insediativo, il prodotto dell'organico
affiancarsi, collegarsi ed intrecciarsi di iniziative e
di vicende analoghe.
In conseguenza di quanto detto, il sistema colli-
nare ed i complessi ambientali che lo compongono
risultano prevalentemente costituiti da una varietà
relativamente limitata di tessuti raggruppabili
in
cinque categorie, rispondenti alle cinque categorie
di inziative testé elencate:
a) sistemi di «vigne«;
b) tessuti rurali di «ronchi» e «tetti» ;
c) complessi di ville con giardino;
d) complessi di casette con orto-giardino;
e)
tessuti residenziali di riplasmazione nei centri
collinari.
La scomposizione testé presentata del sistema
collinare può costituire un primo riferimento d'ap-
poggio per chi intenda riconoscerne la strutturazione
storica e coglierne il valore come bene culturale e
ambientale.
Tale scomposizione è stata effettuata, per così
dire, secondo le « naturali articolazioni » del siste-
ma, enucleando progressivamente parti via via più
piccole (sottosistemi, complessi ambientali, tessuti e
cellule), distinte tra loro dalle diverse caratterizza-
zioni morfologiche e dai relativamente intensi in-
trecci interni di legami strutturali.
A questo punto, diventa opportuno invertire la
direzione di prospettiva. Conviene passare da una
prospettiva prevalentemente analitica, di taglio co-
rografico, ad una prospettiva prevalentemente sinte-
tica di taglio storico-critico; in particolare, conviene
focalizzare il centro di attenzione sulle vicende di
progettazione e di realizzazione dei singoli interven-
ti di impianto o di trasformazione delle cellule colo-
nizzative e insediative.
Da una tale prospettiva, la ricostruzione e l'in-
terpretazione storico-critica della vicenda di struttu-
razione della singola cellula, in rapporto al suo con-
testo, consentono di cogliere, ad un tempo, lo svi-
luppo della singolare individualità della cellula stes-
sa e la costituzione dei singolari legami strutturali
che legarono la cellula al tessuto e all'ambiente.
Assumendo, sempre dalla stessa direzione, un
angolo di prospettiva più vasto, l'individuazione e
l'interpretazione delle ricorrenze nei modi di struttu-
rare e di collegare le diverse cellule con il tessuto e
l'ambiente, consentono di cogliere la genesi di im-
portanti caratterizzazioni strutturali del tessuto e del-
l'ambiente stesso.
3. VICENDE STRUTTURATIVE
E CARATTERIZZAZIONI DI TESSUTI
ED AMBIENTI
3.1.
Individuazione storica dei principati aspetti
dette vicende
Che cos'era la «vigna» o la «casa di collina»
per il torinese che la realizzò o la modificò?
Per secoli, le « vigne » e, in generale, le « case di
collina» dei torinesi, grandi o piccole, fastose o
modeste che fossero, venivano generalmente conce-
pite, ad un tempo:
a) come
«campagne »
(a seconda dei casi, come
cascine »
,
« vigne », « orti-frutteti »), beni agri-
coli atti a produrre un certo reddito o una certa
quantità di generi di diretto consumo familiare
(vino, frutta, ortaggi, pollame, legna);
b) come «
vitteggiature », «abitazioni
civili » (così
indicate nei catasti, per distinguerle dagli edifici
« rustici » o « rurali ») costituenti sistemi di spazi
edilizi e di giardino atti ad ospitare le funzioni
organizzate della vita di ogni giorno e del «rice-
vimento » , con « commodità » e con « decoro »
adeguati alle esigenze e al rango della famiglia;
c)
come «
case»
di una persona o di una famiglia,
strutturate, collocate e inserite nell'ambiente
come oggetti estetici significanti, offerti dai pro-
pric,ari alla contemplazione, per esservi ricono-
sciuti e per riconoscervisi.
Di conseguenza, chi progettava la realizzazione
o la trasformazione di una « vigna» o di una « casa di
collina» doveva di solito conseguire, in modo inte-
grato e contemporaneamente, le tre categorie predet-
te di obiettivi
(a, b, e),
strutturando o ristrutturando
efficacemente la cellula sotto
i
tre profili della pro-
duttività agricola, della funzionalità edilizia e del
valore estetico.
Tale modo integrato di concepire e di strutturare
le singole cellule ne improntò vividamente le struttu-
re oggi riconoscibili. Grazie a questo fatto, le analisi
e le interpretazioni di tali strutture, suffragate dai
documenti storici, consentono oggi di ricostruire il
modo singolare con cui ciascuna cellula venne strut-
turata o ristrutturata:
- in relazione
a
certi scopi, bisogni, intenzioni;
- nei vincoli di una certa situazione contestuale;
753


















