
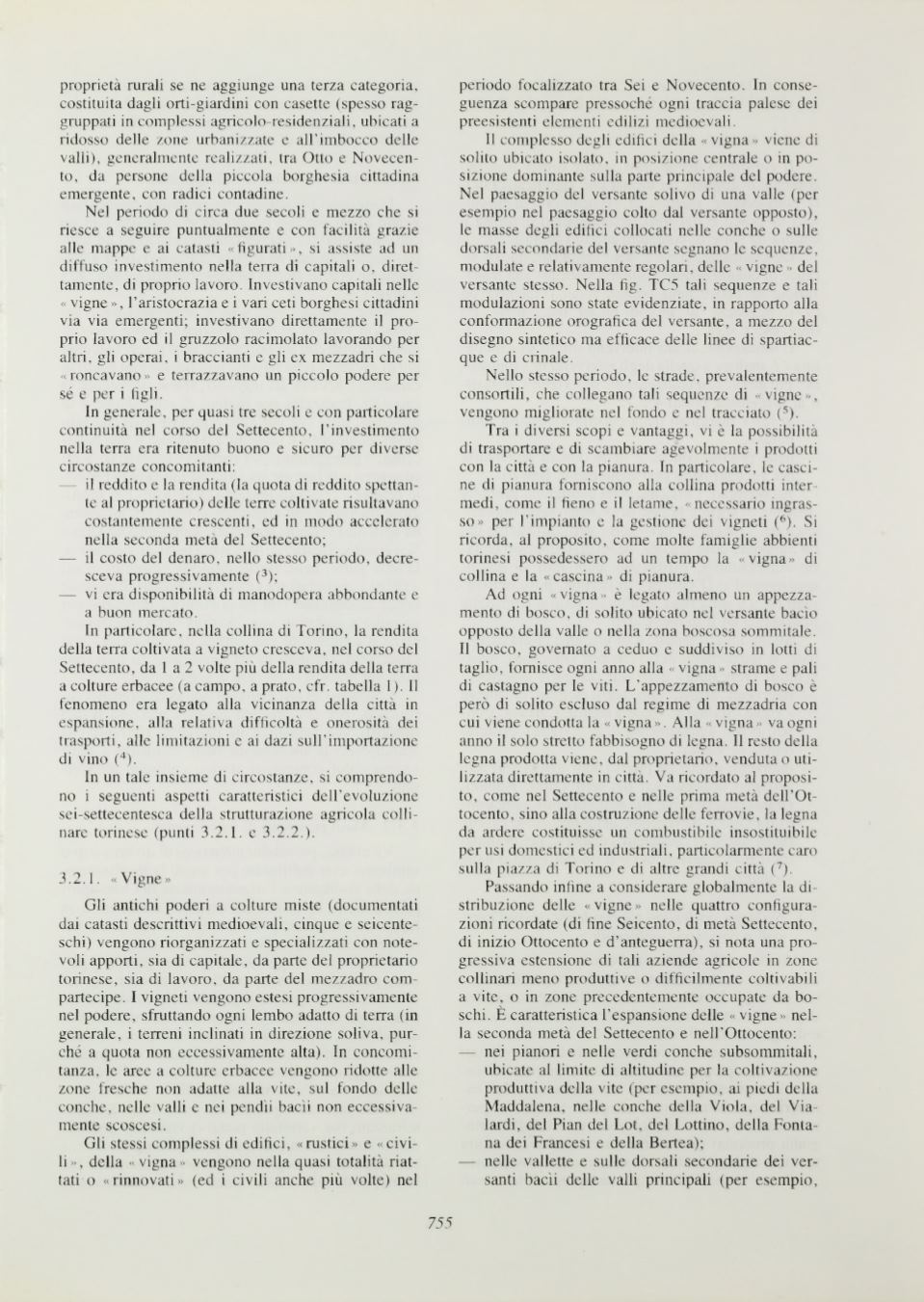
proprietà rurali se ne aggiunge una terza categoria,
costituita dagli orti-giardini con casette (spesso rag-
gruppati in complessi agricolo-residenziali, ubicati a
ridosso delle zone urbanizzate e all'imbocco delle
valli), generalmente realizzati, tra Otto e Novecen-
to, da persone della piccola borghesia cittadina
emergente, con radici contadine.
Nel periodo di circa due secoli e mezzo che si
riesce a seguire puntualmente e con facilità grazie
alle mappe e ai catasti « figurati », si assiste ad un
diffuso investimento nella terra di capitali o, diret-
tamente, di proprio lavoro. Investivano capitali nelle
« vigne», l'aristocrazia e i vari ceti borghesi cittadini
via via emergenti; investivano direttamente il pro-
prio lavoro ed il gruzzolo racimolato lavorando per
altri, gli operai, i braccianti e gli ex mezzadri che si
« roncavano » e terrazzavano un piccolo podere per
sé e per i figli.
In generale, per quasi tre secoli e con particolare
continuità nel corso del Settecento, l'investimento
nella terra era ritenuto buono e sicuro per diverse
circostanze concomitanti:
- il reddito e la rendita (la quota di reddito spettan-
te al proprietario) delle terre coltivate risultavano
costantemente crescenti, ed in modo accelerato
nella seconda metà del Settecento;
— il costo del denaro, nello stesso periodo, decre-
sceva progressivamente (
3
);
- vi era disponibilità di manodopera abbondante e
a buon mercato.
In particolare, nella collina di Torino, la rendita
della terra coltivata a vigneto cresceva, nel corso del
Settecento, da 1 a 2 volte più della rendita della terra
a colture erbacee (a campo, a prato, cfr. tabella 1). Il
fenomeno era legato alla vicinanza della città in
espansione, alla relativa difficoltà e onerosità dei
trasporti, alle limitazioni e ai dazi sull'importazione
di vino (
4
).
In un tale insieme di circostanze, si comprendo-
no i seguenti aspetti caratteristici dell'evoluzione
sei-settecentesca della strutturazione agricola colli-
nare torinese (punti 3.2.1. e 3.2.2.).
3.2.1. «Vigne»
Gli antichi poderi a colture miste (documentati
dai catasti descrittivi medioevali, cinque e seicente-
schi) vengono riorganizzati e specializzati con note-
voli apporti, sia di capitale, da parte del proprietario
torinese, sia di lavoro, da parte del mezzadro corn-
partecipe. I vigneti vengono estesi progressivamente
nel podere, sfruttando ogni lembo adatto di terra (in
generale, i terreni inclinati in direzione soliva, pur-
ché a quota non eccessivamente alta). In concomi
tanza, le aree a colture erbacee vengono ridotte alle
zone fresche non adatte alla vite, sul fondo delle
conche, nelle valli e nei pendii bacii non eccessiva-
mente scoscesi.
Gli stessi complessi di edifici, «rustici» e «civi-
li», della «vigna» vengono nella quasi totalità riat-
tati o « rinnovati » (ed i civili anche più volte) nel
periodo focalizzato tra Sei e Novecento. In conse-
guenza scompare pressoché ogni traccia palese dei
preesistenti elementi edilizi medioevali.
Il complesso degli edifici della «vigna» viene di
solito ubicato isolato, in posizione centrale o in po-
sizione dominante sulla parte principale del podere.
Nel paesaggio del versante solivo di una valle (per
esempio nel paesaggio colto dal versante opposto),
le masse degli edifici collocati nelle conche o sulle
dorsali secondarie del versante segnano le sequenze,
modulate e relativamente regolari, delle « vigne » del
versante stesso. Nella fig. TC5 tali sequenze e tali
modulazioni sono state evidenziate, in rapporto alla
conformazione orografica del versante, a mezzo del
disegno sintetico ma efficace delle linee di spartiac-
que e di crinale.
Nello stesso periodo, le strade, prevalentemente
consortili, che collegano tali sequenze di « vigne »,
vengono migliorate nel fondo e nel tracciato (
5
).
Tra i diversi scopi e vantaggi, vi è la possibilità
di trasportare e di scambiare agevolmente i prodotti
con la città e con la pianura. In particolare, le casci-
ne di pianura forniscono alla collina prodotti inter-
medi, come il fieno e il letame, «necessario ingras-
so» per l'impianto e la gestione dei vigneti (
6
). Si
ricorda, al proposito, come molte famiglie abbienti
torinesi possedessero ad un tempo la «vigna» di
collina e la « cascina » di pianura.
Ad ogni « vigna » è legato almeno un appezza-
mento di bosco, di solito ubicato nel versante bacio
opposto della valle o nella zona boscosa sommitale.
Il bosco, governato a ceduo e suddiviso in lotti di
taglio, fornisce ogni anno alla «vigna» strame e pali
di castagno per le viti. L'appezzamento di bosco è
però di solito escluso dal regime di mezzadria con
cui viene condotta la «vigna». Alla «vigna» va ogni
anno il solo stretto fabbisogno di legna. Il resto della
legna prodotta viene, dal proprietario, venduta o uti-
lizzata direttamente in città. Va ricordato al proposi-
to, come nel Settecento e nelle prima metà dell'Ot-
tocento, sino alla costruzione delle ferrovie, la legna
da ardere costituisse un combustibile insostituibile
per usi domestici ed industriali, particolarmente caro
sulla piazza di Torino e di altre grandi città (
7
).
Passando infine a considerare globalmente la di-
stribuzione delle «vigne» nelle quattro configura-
zioni ricordate (di fine Seicento, di metà Settecento,
di inizio Ottocento e d'anteguerra), si nota una pro-
gressiva estensione di tali aziende agricole in zone
collinari meno produttive o difficilmente coltivabili
a vite, o in zone precedentemente occupate da bo-
schi. È caratteristica l'espansione delle « vigne» nel-
la seconda metà del Settecento e nell'Ottocento:
- nei pianori e nelle verdi conche subsommitali,
ubicate al limite di altitudine per la coltivazione
produttiva della vite (per esempio, ai piedi della
Maddalena, nelle conche della Viola, del Via-
lardi, del Pian del Lot, del Lottino, della Fonta-
na dei Francesi e della Bertea);
— nelle vallette e sulle dorsali secondarie dei ver-
santi bacii delle valli principali (per esempio,
755


















