
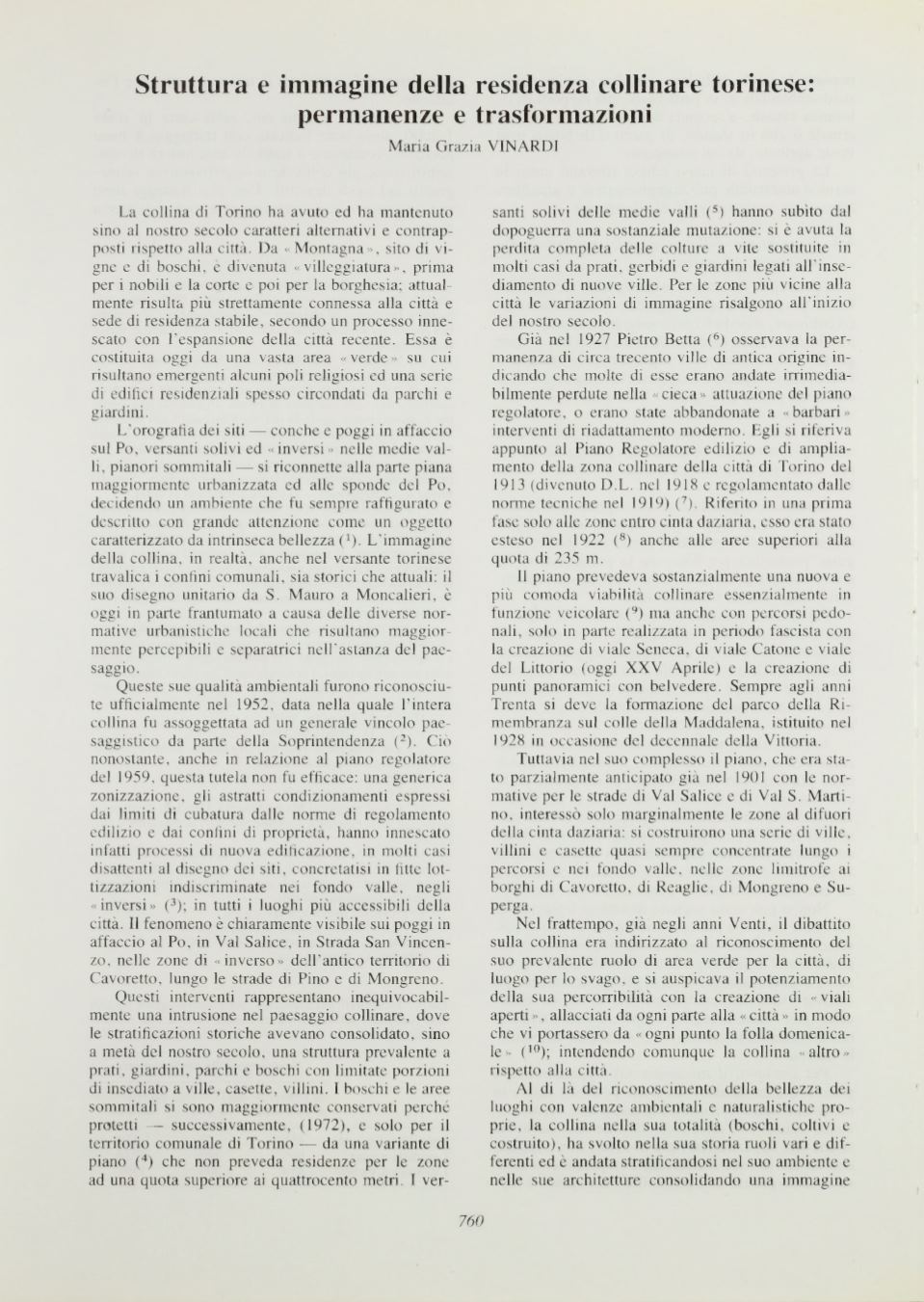
Struttura e immagine della residenza collinare torinese:
permanenze e trasformazioni
Maria Grazia VINARDI
La collina di Torino ha avuto ed ha mantenuto
sino al nostro secolo caratteri alternativi e contrap-
posti rispetto alla città. Da «Montagna», sito di vi-
gne e di boschi, è divenuta «villeggiatura», prima
per i nobili e la corte e poi per la borghesia; attual-
mente risulta più strettamente connessa alla città e
sede di residenza stabile, secondo un processo inne-
scato con l'espansione della città recente. Essa è
costituita oggi da una vasta area « verde » su cui
risultano emergenti alcuni poli religiosi ed una serie
di edifici residenziali spesso circondati da parchi e
giardini.
L'orografia dei siti conche e poggi in affaccio
sul Po, versanti solivi ed « inversi » nelle medie val-
li, pianori sommitali si riconnette alla parte piana
maggiormente urbanizzata ed alle sponde del Po,
decidendo un ambiente che fu sempre raffigurato e
descritto con grande attenzione come un oggetto
caratterizzato da intrinseca bellezza (
1
). L'immagine
della collina, in realtà, anche nel versante torinese
travalica i confini comunali, sia storici che attuali: il
suo disegno unitario da S. Mauro a Moncalieri, è
oggi in parte frantumato a causa delle diverse nor-
mative urbanistiche locali che risultano maggior-
mente percepibili e separatrici nell'astanza del pae-
saggio.
Queste sue qualità ambientali furono riconosciu-
te ufficialmente nel 1952, data nella quale l'intera
collina fu assoggettata ad un generale vincolo pae-
saggistico da parte della Soprintendenza (
2
). Ciò
nonostante, anche in relazione al piano regolatore
del 1959, questa tutela non fu efficace: una generica
zonizzazione, gli astratti condizionamenti espressi
dai limiti di cubatura dalle norme di regolamento
edilizio e dai confini di proprietà, hanno innescato
infatti processi di nuova edificazione, in molti casi
disattenti al disegno dei siti, concretatisi in fitte lot-
tizzazioni indiscriminate nei fondo valle, negli
«inversi» (
3
); in tutti i luoghi più accessibili della
città. Il fenomeno è chiaramente visibile sui poggi in
affaccio al Po, in Val Salice, in Strada San Vincen-
zo, nelle zone di «inverso» dell'antico territorio di
Cavoretto, lungo le strade di Pino e di Mongreno.
Questi interventi rappresentano inequivocabil-
mente una intrusione nel paesaggio collinare, dove
le stratificazioni storiche avevano consolidato, sino
a metà del nostro secolo, una struttura prevalente a
prati, giardini, parchi e boschi con limitate porzioni
di insediato a ville, casette, villini. I boschi e le aree
sommitali si sono maggiormente conservati perché
protetti — successivamente, (1972), e solo per il
territorio comunale di Torino — da una variante di
piano (
4
) che non preveda residenze per le zone
ad una quota superiore ai quattrocento metri. I ver-
santi solivi delle medie valli (
5
) hanno subito dal
dopoguerra una sostanziale mutazione: si è avuta la
perdita completa delle colture a vite sostituite in
molti casi da prati, gerbidi e giardini legati all'inse-
diamento di nuove ville. Per le zone più vicine alla
città le variazioni
di
immagine risalgono all'inizio
del nostro secolo.
Già nel 1927 Pietro Betta (
6
) osservava la per-
manenza di circa trecento ville di antica origine in-
dicando che molte di esse erano andate irrimedia-
bilmente perdute nella «cieca» attuazione del piano
regolatore, o erano state abbandonate a « barbari
interventi di riadattamento moderno. Egli si riferiva
appunto al Piano Regolatore edilizio e di amplia-
mento della zona collinare della città di Torino del
1913 (divenuto D.L. nel 1918 e regolamentato dalle
norme tecniche nel 1919) (
7
). Riferito in una prima
fase solo alle zone entro cinta daziaria, esso era stato
esteso nel 1922 (
8
) anche alle aree superiori alla
quota di 235 m.
Il piano prevedeva sostanzialmente una nuova e
più comoda viabilità collinare essenzialmente in
funzione veicolare (
9
) ma anche con percorsi pedo-
nali, solo in parte realizzata in periodo fascista con
la creazione di viale Seneca, di viale Catone e viale
del Littorio (oggi XXV Aprile) e la creazione di
punti panoramici con belvedere. Sempre agli anni
Trenta si deve la formazione del parco della Ri-
membranza sul colle della Maddalena, istituito nel
1928 in occasione del decennale della Vittoria.
Tuttavia nel suo complesso il piano, che era sta-
to parzialmente anticipato già nel 1901 con le nor-
mative per le strade di Val Salice e di Val S. Marti-
no, interessò solo marginalmente le zone al difuori
della cinta daziaria: si costruirono una serie di ville,
villini e casette quasi sempre concentrate lungo i
percorsi e nei fondo valle, nelle zone limitrofe ai
borghi di Cavoretto, di Reaglie, di Mongreno e Su-
perga.
Nel frattempo, già negli anni Venti, il dibattito
sulla collina era indirizzato al riconoscimento del
suo prevalente ruolo di area verde per la città, di
luogo per lo svago, e si auspicava il potenziamento
della sua percorribilità con la creazione di « viali
aperti », allacciati da ogni parte alla « città» in modo
che vi portassero da « ogni punto la folla domenica-
le » (
10
); intendendo comunque la collina « altro
rispetto alla città.
Al di là del riconoscimento della bellezza dei
luoghi con valenze ambientali e naturalistiche pro-
prie, la collina nella sua totalità (boschi, coltivi e
costruito), ha svolto nella sua storia ruoli vari e dif-
ferenti ed è andata stratificandosi nel suo ambiente e
nelle sue architetture consolidando una immagine
760


















