
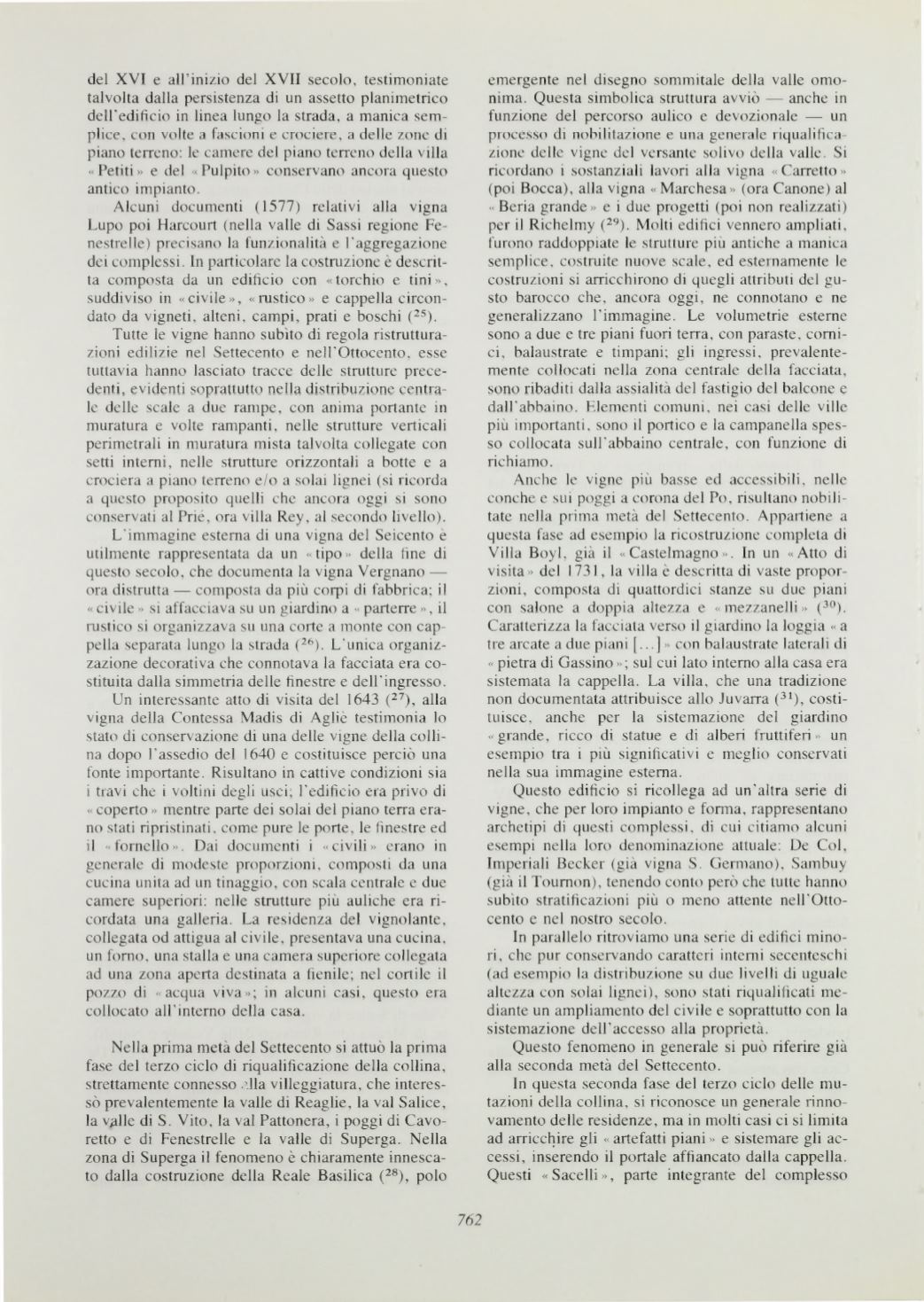
del XVI e all'inizio del XVII secolo, testimoniate
talvolta dalla persistenza di un assetto planimetrico
dell'edificio in linea lungo la strada, a manica sem-
plice, con volte a fascioni e crociere, a delle zone di
piano terreno: le camere del piano terreno della villa
Petiti » e del « Pulpito » conservano ancora questo
antico impianto.
Alcuni documenti (1577) relativi alla vigna
Lupo poi Harcourt (nella valle di Sassi regione Fe-
nestrelle) precisano la funzionalità e l'aggregazione
dei complessi. In particolare la costruzione è descrit-
ta composta da un edificio con «torchio e tini»,
suddiviso in «civile», «rustico» e cappella circon-
dato da vigneti, alteni, campi, prati e boschi (
25
).
Tutte le vigne hanno subito di regola ristruttura-
zioni edilizie nel Settecento e nell'Ottocento, esse
tuttavia hanno lasciato tracce delle strutture prece-
denti, evidenti soprattutto nella distribuzione centra-
le delle scale a due rampe, con anima portante in
muratura e volte rampanti, nelle strutture verticali
perimetrali in muratura mista talvolta collegate con
setti interni, nelle strutture orizzontali a botte e a
crociera a piano terreno e/o a solai lignei (si ricorda
a questo proposito quelli che ancora oggi si sono
conservati al Prié, ora villa Rey, al secondo livello).
L'immagine esterna di una vigna del Seicento è
utilmente rappresentata da un « tipo » della fine di
questo secolo, che documenta la vigna Vergnano —
ora distrutta — composta da più corpi di fabbrica; il
« civile » si affacciava su un giardino a « parterre », il
rustico si organizzava su una corte a monte con cap-
pella separata lungo la strada (
26
). L'unica organiz-
zazione decorativa che connotava la facciata era co-
stituita dalla simmetria delle finestre e dell'ingresso.
Un interessante atto di visita del 1643 (
27
), alla
vigna della Contessa Madis di Agliè testimonia lo
stato di conservazione di una delle vigne della colli-
na dopo l'assedio del 1640 e costituisce perciò una
fonte importante. Risultano in cattive condizioni sia
i travi che i voltini degli usci; l'edificio era privo di
« coperto » mentre parte dei solai del piano terra era-
no stati ripristinati, come pure le porte, le finestre ed
il « fornello» . Dai documenti i «civili » erano in
generale di modeste proporzioni, composti da una
cucina unita ad un tinaggio, con scala centrale e due
camere superiori: nelle strutture più auliche era ri-
cordata una galleria. La residenza del vignolante,
collegata od attigua al civile, presentava una cucina,
un forno, una stalla e una camera superiore collegata
ad una zona aperta destinata a fienile; nel cortile il
pozzo di «acqua viva»; in alcuni casi, questo era
collocato all'interno della casa.
Nella prima metà del Settecento si attuò la prima
fase del terzo ciclo di riqualificazione della collina,
strettamente connesso Alla villeggiatura, che interes-
sò prevalentemente la valle di Reaglie, la val Salice,
la valle di S. Vito, la val Pattonera, i poggi di Cavo-
retto e di Fenestrelle e la valle di Superga. Nella
zona di Superga il fenomeno è chiaramente innesca-
to dalla costruzione della Reale Basilica (
28
), polo
emergente nel disegno sommitale della valle omo-
nima. Questa simbolica struttura avviò anche in
funzione del percorso aulico e devozionale un
processo di nobilitazione e una generale riqualifica-
zione delle vigne del versante solivo della valle. Si
ricordano i sostanziali lavori alla vigna « Carretto
(poi Bocca), alla vigna «Marchesa» (ora Canone) al
«
Beria grande » e i due progetti (poi non realizzati)
per il Richelmy (
29
). Molti edifici vennero ampliati,
furono raddoppiate le strutture più antiche a manica
semplice, costruite nuove scale, ed esternamente le
costruzioni si arricchirono di quegli attributi del gu-
sto barocco che, ancora oggi, ne connotano e ne
generalizzano l'immagine. Le volumetrie esterne
sono a due e tre piani fuori terra, con paraste, corni-
ci, balaustrate e timpani; gli ingressi, prevalente-
mente collocati nella zona centrale della facciata,
sono ribaditi dalla assialità del fastigio del balcone e
dall'abbaino. Elementi comuni, nei casi delle ville
più importanti, sono il portico e la campanella spes-
so collocata sull'abbaino centrale, con funzione di
richiamo.
Anche le vigne più basse ed accessibili, nelle
conche e sui poggi a corona del Po, risultano nobili-
tate nella prima metà del Settecento. Appartiene a
questa fase ad esempio la ricostruzione completa di
Villa Boyl. già il « Castelmagno ». In un «Atto di
visita» del 1731, la villa è descritta di vaste propor-
zioni, composta di quattordici stanze su due piani
con salone a doppia altezza e « mezzanelli » (30)
Caratterizza la facciata verso il giardino la loggia « a
tre arcate a due piani [...]» con balaustrate laterali di
pietra di Gassino»; sul cui lato interno alla casa era
sistemata la cappella. La villa, che una tradizione
non documentata attribuisce allo Juvarra (
31
), costi-
tuisce, anche per la sistemazione del giardino
« grande, ricco di statue e di alberi fruttiferi » un
esempio tra i più significativi e meglio conservati
nella sua immagine esterna.
Questo edificio si ricollega ad un'altra serie di
vigne, che per loro impianto e forma, rappresentano
archetipi di questi complessi, di cui citiamo alcuni
esempi nella loro denominazione attuale: De Col,
Imperiali Becker (già vigna S. Germano), Sambuy
(già il Tournon), tenendo conto però che tutte hanno
subito stratificazioni più o meno attente nell'Otto-
cento e nel nostro secolo.
In parallelo ritroviamo una serie di edifici mino-
ri, che pur conservando caratteri interni secenteschi
(ad esempio la distribuzione su due livelli di uguale
altezza con solai lignei), sono stati riqualificati me-
diante un ampliamento del civile e soprattutto con la
sistemazione dell'accesso alla proprietà.
Questo fenomeno in generale si può riferire già
alla seconda metà del Settecento.
In questa seconda fase del terzo ciclo delle mu-
tazioni della collina, si riconosce un generale rinno-
vamento delle residenze, ma in molti casi ci si limita
ad arricchire gli « artefatti piani » e sistemare gli ac-
cessi, inserendo il portale affiancato dalla cappella.
Questi « Sacelli », parte integrante del complesso
762


















