
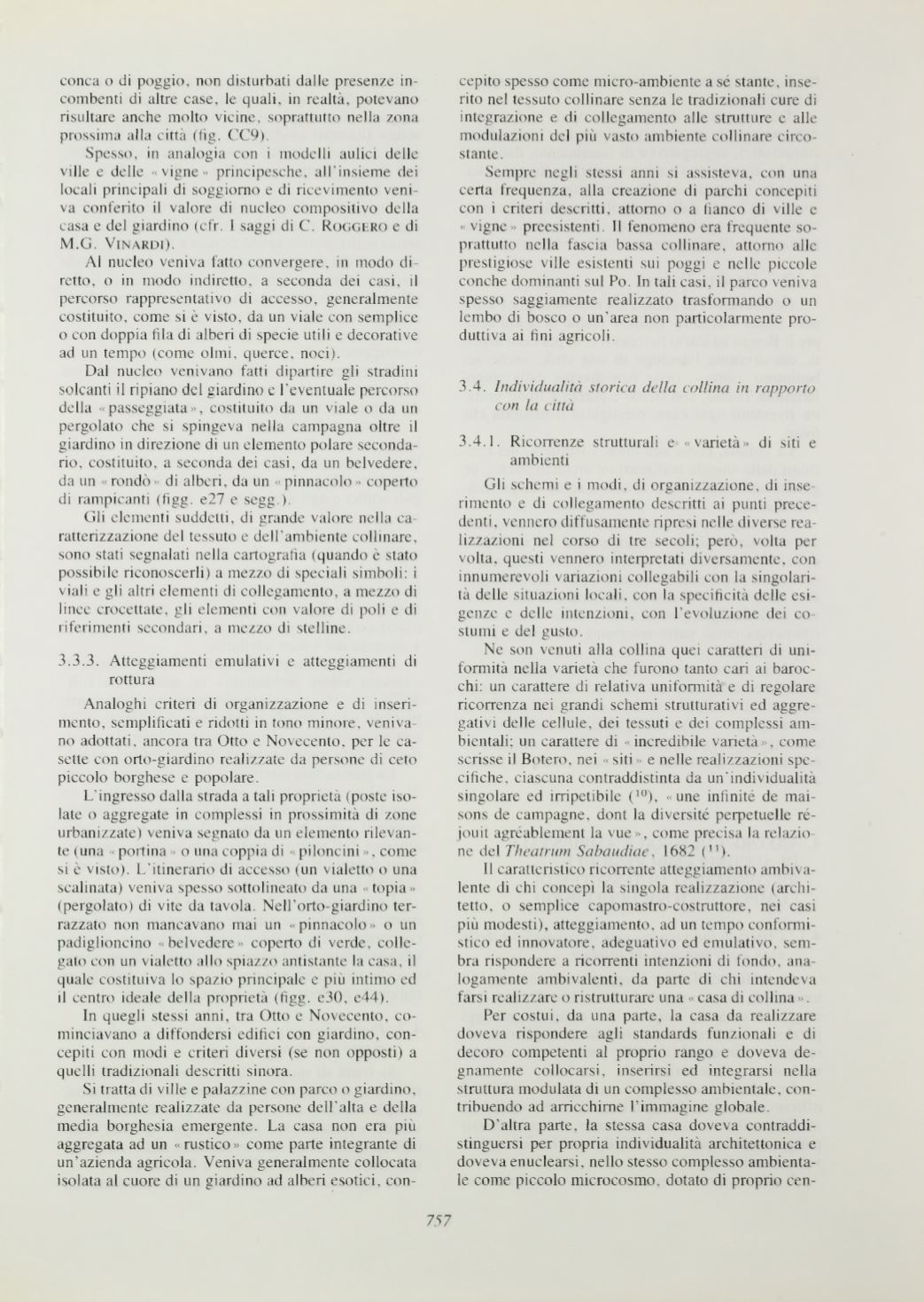
conca o di poggio, non disturbati dalle presenze in-
combenti di altre case, le quali, in realtà, potevano
risultare anche molto vicine, soprattutto nella zona
prossima alla città (fig. CC9).
Spesso, in analogia con i modelli aulici delle
ville e delle « vigne » principesche, all'insieme dei
locali principali di soggiorno e di ricevimento veni-
va conferito il valore di nucleo compositivo della
casa e del giardino (cfr. I saggi di C. ROGGERO e di
M.G. VINARDI).
Al nucleo veniva fatto convergere, in modo di-
retto, o in modo indiretto, a seconda dei casi, il
percorso rappresentativo di accesso, generalmente
costituito, come si è visto, da un viale con semplice
o con doppia fila di alberi di specie utili e decorative
ad un tempo (come olmi, querce, noci).
Dal nucleo venivano fatti dipartire gli stradini
solcanti il ripiano del giardino e l'eventuale percorso
della «passeggiata», costituito da un viale o da un
pergolato che si spingeva nella campagna oltre il
giardino in direzione di un elemento polare seconda-
rio, costituito, a seconda dei casi, da un belvedere,
da un «rondò» di alberi, da un «pinnacolo» coperto
di rampicanti (figg. e27 e segg.).
Gli elementi suddetti, di grande valore nella ca-
ratterizzazione del tessuto e dell'ambiente collinare,
sono stati segnalati nella cartografia (quando è stato
possibile riconoscerli) a mezzo di speciali simboli: i
viali e gli altri elementi di collegamento, a mezzo di
linee crocettate, gli elementi con valore di poli e di
riferimenti secondari, a mezzo di stelline.
3.3.3. Atteggiamenti emulativi e atteggiamenti di
rottura
Analoghi criteri di organizzazione e di inseri-
mento, semplificati e ridotti in tono minore, veniva-
no adottati, ancora tra Otto e Novecento, per le ca-
sette con orto-giardino realizzate da persone di ceto
piccolo borghese e popolare.
L'ingresso dalla strada a tali proprietà (poste iso-
late o aggregate in complessi in prossimità di zone
urbanizzate) veniva segnato da un elemento rilevan-
te (una « portina » o una coppia di « piloncini », come
si è visto). L'itinerario di accesso (un vialetto o una
scalinata) veniva spesso sottolineato da una « topia
(pergolato) di vite da tavola. Nell'orto-giardino ter-
razzato non mancavano mai un «pinnacolo» o un
padiglioncino «belvedere» coperto di verde, colle-
gato con un vialetto allo spiazzo antistante la casa, il
quale costituiva lo spazio principale e più intimo ed
il centro ideale della proprietà (figg. e30, e44).
In quegli stessi anni, tra Otto e Novecento, co-
minciavano a diffondersi edifici con giardino, con-
cepiti con modi e criteri diversi (se non opposti) a
quelli tradizionali descritti sinora.
Si tratta di ville e palazzine con parco o giardino,
generalmente realizzate da persone dell'alta e della
media borghesia emergente. La casa non era più
aggregata ad un « rustico » come parte integrante di
un'azienda agricola. Veniva generalmente collocata
isolata al cuore di un giardino ad alberi esotici, con-
cepito spesso come micro-ambiente a sé stante, inse-
rito nel tessuto collinare senza le tradizionali cure di
integrazione e di collegamento alle strutture e alle
modulazioni del più vasto ambiente collinare circo-
stante.
Sempre negli stessi anni si assisteva, con una
certa frequenza, alla creazione di parchi concepiti
con i criteri descritti, attorno o a fianco di ville e
«
vigne» preesistenti. Il fenomeno era frequente so-
prattutto nella fascia bassa collinare, attorno alle
prestigiose ville esistenti sui poggi e nelle piccole
conche dominanti sul Po. In tali casi, il parco veniva
spesso saggiamente realizzato trasformando o un
lembo di bosco o un'area non particolarmente pro-
duttiva ai fini agricoli.
3.4.
Individuatità storica detta cotlina in rapporto
con la città
3.4.1. Ricorrenze strutturali e «varietà» di siti e
ambienti
Gli schemi e i modi, di organizzazione, di inse-
rimento e di collegamento descritti ai punti prece-
denti, vennero diffusamente ripresi nelle diverse rea-
lizzazioni nel corso di tre secoli; però, volta per
volta, questi vennero interpretati diversamente, con
innumerevoli variazioni collegabili con la singolari-
tà delle situazioni locali, con la specificità delle esi-
genze e delle intenzioni, con l'evoluzione dei co-
stumi e del gusto.
Ne son venuti alla collina quei caratteri di uni-
formità nella varietà che furono tanto cari ai baroc-
chi: un carattere di relativa uniformità e di regolare
ricorrenza nei grandi schemi strutturativi ed aggre-
gativi delle cellule, dei tessuti e dei complessi am-
bientali; un carattere di «incredibile varietà», come
scrisse il Botero, nei « siti » e nelle realizzazioni spe-
cifiche, ciascuna contraddistinta da un'individualità
singolare ed irripetibile (
10
), « une infinite de mai-
sons de campagne, dont la diversité perpetuelle ré-
jouit agréablement la vue», come precisa la relazio-
ne del
Theatrum Sabaudiae,
1682 (
11
)
.
Il caratteristico ricorrente atteggiamento ambiva-
lente di chi concepì la singola realizzazione (archi-
tetto, o semplice capomastro-costruttore, nei casi
più modesti), atteggiamento, ad un tempo conformi-
stico ed innovatore, adeguativo ed emulativo, sem-
bra rispondere a ricorrenti intenzioni di fondo, ana-
logamente ambivalenti, da parte di chi intendeva
farsi realizzare o ristrutturare una « casa di collina ».
Per costui, da una parte, la casa da realizzare
doveva rispondere agli standards funzionali e di
decoro competenti al proprio rango e doveva de-
gnamente collocarsi, inserirsi ed integrarsi nella
struttura modulata di un complesso ambientale, con-
tribuendo ad arricchirne l'immagine globale.
D'altra parte, la stessa casa doveva contraddi-
stinguersi per propria individualità architettonica e
doveva enuclearsi, nello stesso complesso ambienta-
le come piccolo microcosmo, dotato di proprio cen-
757


















