
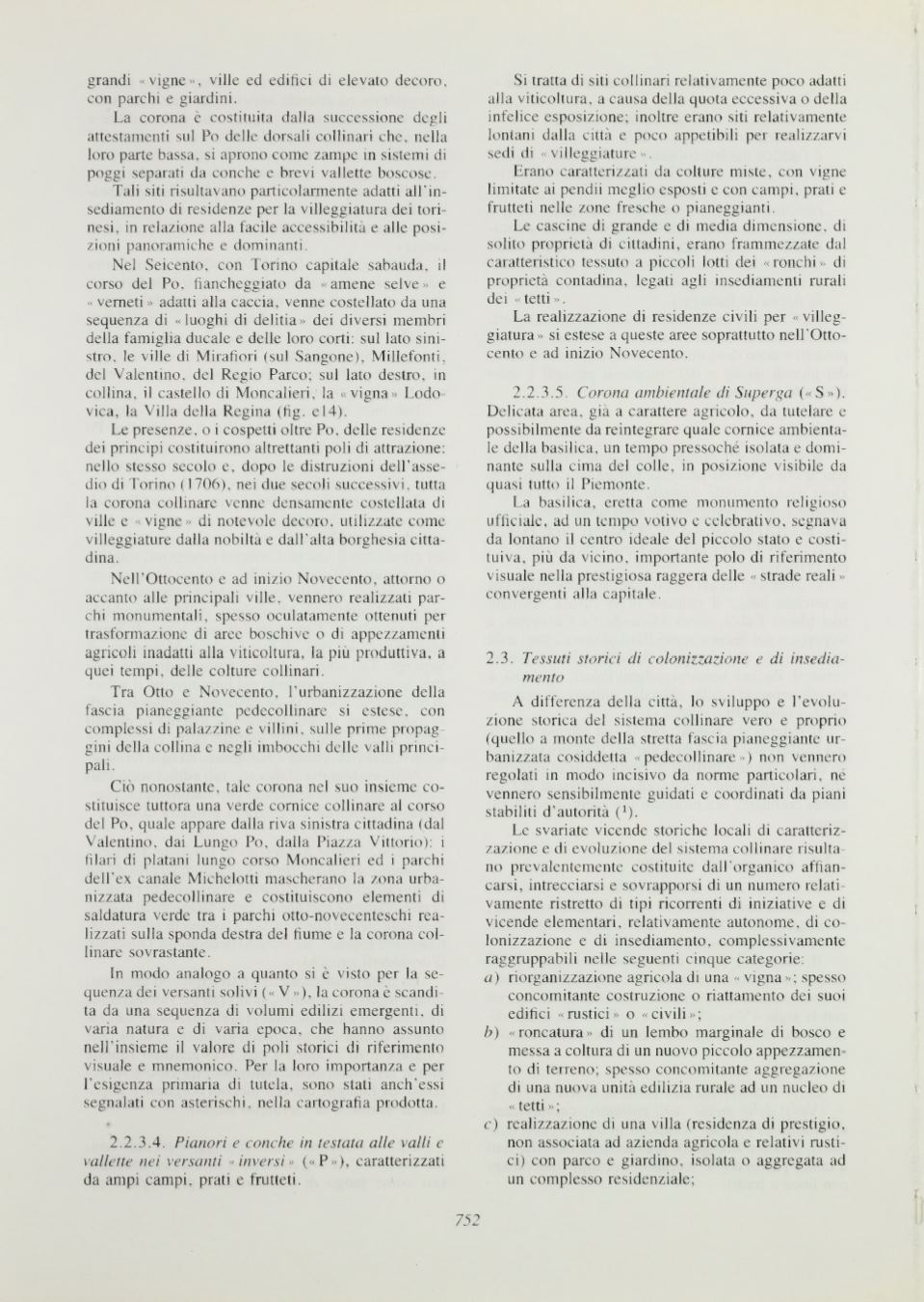
grandi «vigne», ville ed edifici di elevato decoro,
con parchi e giardini.
La corona è costituita dalla successione degli
attestamenti sul Po delle dorsali collinari che, nella
loro parte bassa, si aprono come zampe in sistemi di
poggi separati da conche e brevi vallette boscose.
Tali siti risultavano particolarmente adatti all'in-
sediamento di residenze per la villeggiatura dei tori-
nesi, in relazione alla facile accessibilità e alle posi-
zioni panoramiche e dominanti.
Nel Seicento, con Torino capitale sabauda, il
corso del Po, fiancheggiato da « amene selve » e
verneti » adatti alla caccia, venne costellato da una
sequenza di «luoghi di delitia» dei diversi membri
della famiglia ducale e delle loro corti: sul lato sini-
stro, le ville di Mirafiori (sul Sangone), Millefonti.
del Valentino, del Regio Parco; sul lato destro, in
collina, il castello di Moncalieri, la «vigna» Lodo-
vica, la Villa della Regina (fig. e14).
Le presenze, o i cospetti oltre Po, delle residenze
dei principi costituirono altrettanti poli di attrazione:
nello stesso secolo e, dopo le distruzioni dell'asse-
dio di Torino (1706), nei due secoli successivi, tutta
la corona collinare venne densamente costellata di
ville e «vigne» di notevole decoro, utilizzate come
villeggiature dalla nobiltà e dall'alta borghesia citta-
dina.
Nell'Ottocento e ad inizio Novecento, attorno o
accanto alle principali ville, vennero realizzati par-
chi monumentali, spesso oculatamente ottenuti per
trasformazione di aree boschive o di appezzamenti
agricoli inadatti alla viticoltura, la più produttiva, a
quei tempi, delle colture collinari.
Tra Otto e Novecento, l'urbanizzazione della
fascia pianeggiante pedecollinare si estese, con
complessi di palazzine e villini, sulle prime propag-
gini della collina e negli imbocchi delle valli princi-
pali.
Ciò nonostante, tale corona nel suo insieme co-
stituisce tuttora una verde cornice collinare al corso
del Po, quale appare dalla riva sinistra cittadina (dal
Valentino, dai Lungo Po, dalla Piazza Vittorio): i
filari di platani lungo corso Moncalieri ed i parchi
dell'ex canale Michelotti mascherano la zona urba-
nizzata pedecollinare e costituiscono elementi di
saldatura verde tra i parchi otto-novecenteschi rea-
lizzati sulla sponda destra del fiume e la corona col-
linare sovrastante.
In modo analogo a quanto si è visto per la se-
quenza dei versanti solivi (« V »), la corona è scandi-
ta da una sequenza di volumi edilizi emergenti, di
varia natura e di varia epoca, che hanno assunto
nell'insieme il valore di poli storici di riferimento
visuale e mnemonico. Per la loro importanza e per
l'esigenza primaria di tutela, sono stati anch'essi
segnalati con asterischi, nella cartografia prodotta.
2.2.3.4.
Pianori e conche in testata alle valti e
vallette nei versanti « inversi » («
P» ), caratterizzati
da ampi campi, prati e frutteti.
Si tratta di siti collinari relativamente poco adatti
alla viticoltura, a causa della quota eccessiva o della
infelice esposizione; inoltre erano siti relativamente
lontani dalla città e poco appetibili per realizzarvi
sedi di « villeggiature » .
Erano caratterizzati da colture miste, con vigne
limitate ai pendii meglio esposti e con campi, prati e
frutteti nelle zone fresche o pianeggianti.
Le cascine di grande e di media dimensione, di
solito proprietà di cittadini, erano frammezzate dal
caratteristico tessuto a piccoli lotti dei «ronchi» di
proprietà contadina, legati agli insediamenti rurali
dei « tetti » .
La realizzazione di residenze civili per « villeg-
giatura» si estese a queste aree soprattutto nell'Otto-
cento e ad inizio Novecento.
2.2.3.5.
Corona ambientale di Superga (
,
S»).
Delicata area, già a carattere agricolo, da tutelare e
possibilmente da reintegrare quale cornice ambienta-
le della basilica, un tempo pressoché isolata e domi-
nante sulla cima del colle, in posizione visibile da
quasi tutto il Piemonte.
La basilica, eretta come monumento religioso
ufficiale, ad un tempo votivo e celebrativo, segnava
da lontano il centro ideale del piccolo stato e costi-
tuiva, più da vicino, importante polo di riferimento
visuale nella prestigiosa raggera delle « strade reali»
convergenti alla capitale.
2.3.
Tessuti storici di colonizzazione e di insedia-
mento
A differenza della città, lo sviluppo e l'evolu-
zione storica del sistema collinare vero e proprio
(quello a monte della stretta fascia pianeggiante ur-
banizzata cosiddetta « pedecollinare ») non vennero
regolati in modo incisivo da norme particolari, né
vennero sensibilmente guidati e coordinati da piani
stabiliti d'autorità (
1
).
Le svariate vicende storiche locali di caratteriz-
zazione e di evoluzione del sistema collinare risulta-
no prevalentemente costituite dall'organico affian-
carsi, intrecciarsi e sovrapporsi di un numero relati-
vamente ristretto di tipi ricorrenti di iniziative e di
vicende elementari, relativamente autonome, di co-
lonizzazione e di insediamento, complessivamente
raggruppabili nelle seguenti cinque categorie:
a) riorganizzazione agricola di una « vigna »; spesso
concomitante costruzione o riattamento dei suoi
edifici « rustici » o « civili » ;
b) «roncatura» di un lembo marginale di bosco e
messa a coltura di un nuovo piccolo appezzamen-
to di terreno; spesso concomitante aggregazione
di una nuova unità edilizia rurale ad un nucleo di
« tetti »;
c)
realizzazione di una villa (residenza di prestigio,
non associata ad azienda agricola e relativi rusti-
ci) con parco e giardino, isolata o aggregata ad
un complesso residenziale;
1
752


















