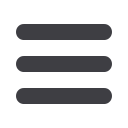
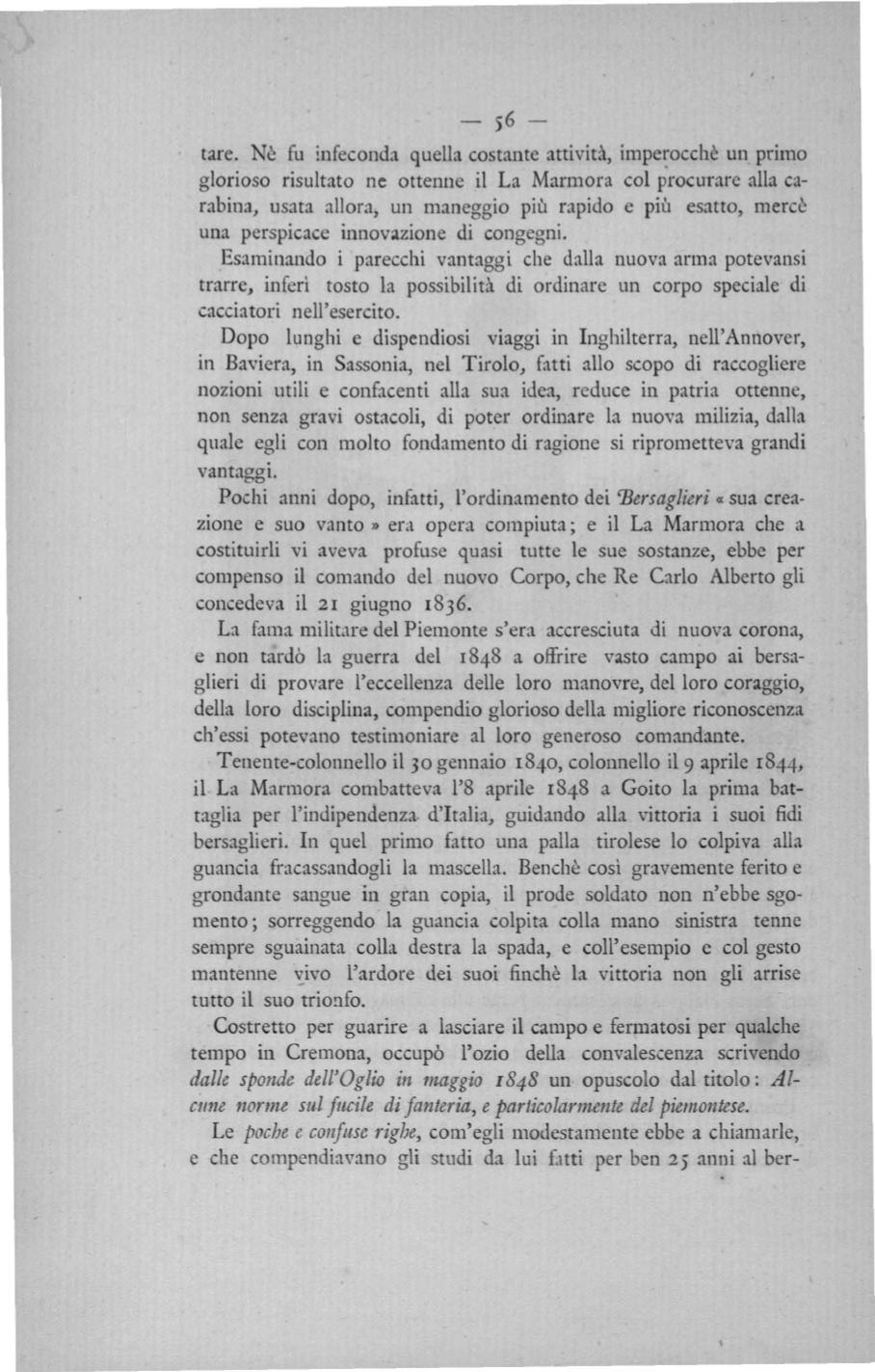
- 56 -
rare.
Nè
fu infeconda quella costante attività, imperocchè un primo
glorioso risultato ne ottenne il La Marmora col procurare alla ca–
rabina, usata allora, un man eggio più rapido e più esatto, merc è
una perspicace inno vazion e di congegni.
Esaminando i parecchi vantaggi che dalla nuova arma potevansi
trarre, inferi tosto la possibilità di ordina re un corpo speciale di
cacciatori nell 'esercito.
Dopo lunghi e dispendiosi viaggi in Inghilterra, nell'Annover,
in Baviera, in Sassonia, nel Tirolo, fatti allo scopo di raccogliere
nozioni utili e con facenti alla sua idea, reduce in patria ottenne,
non senza gravi ostacoli, di poter ordinare la nuova milizia, dalla
quale egli con molto fondamento di ragione si riprometteva grandi
vantaggi.
Pochi anni dopo, infatti, l'o rdinamento dei
'Bersaglieri
«
sua crea–
zione e suo vanto » era opera compiuta; e il La Marmora che a
cost ituirli vi aveva pro fuse quasi tutte le sue sostanze, ebbe per
comp enso il comando del nuovo Corpo, che Re Carlo Alberto gli
concedeva il
21
giugno
1836.
La fama militare del Piemonte s'era accresciuta di nuova corona,
e non tard ò la guerr a del
1848
a offrire vasto campo ai bersa–
glieri di provare l'eccellenza delle loro manovre, dclloro coraggio,
della loro disciplina, compendio glorioso della migliore riconoscenza
ch'essi potevano testimoniare al loro generoso comandante.
Tenente-colonnello il
30
gennaio
1840,
colonnello il9 aprile
1844,
il
La Marmora combatteva 1'8 aprile
1848
a Goito la prima bat–
taglia per l'indipendenza d'Italia, gu idando alla vittoria i suoi fidi
bersaglieri. In quel primo fatto una palla tirolese lo colpiva alla
guancia fracassandogli la mascella.
Benchè
così gravemente ferito e
gro ndante sangue in g ran copi a, il prode soldato non n'ebbe sgo –
mento; sorreggendo la guancia colpita colla mano sinistra tenne
sempre sguainata colla destra la spada, e coll' esempio e col gesto
mantenne vivo l'ardore dei suoi
finch è
la
vittoria non gli arris e
tutto il suo tri onfo.
Costr etto per guarire a lasciare il campo e fermatosi per qualche
tempo in Cremona, occupò l'ozio della convalescenza scrivendo
dalle sponde dell'Oglio
iII
maggio
1848
un opu scolo dal titolo:
A l–
Cime norme sul fucile di fanteria , e particolarmente del piemontese.
Le
poche e confuse righe,
com'egli mod estamente ebbe a chiamarle,
e che compendiava no gli studi da lui fatti per ben
25
anni al ber-


















