
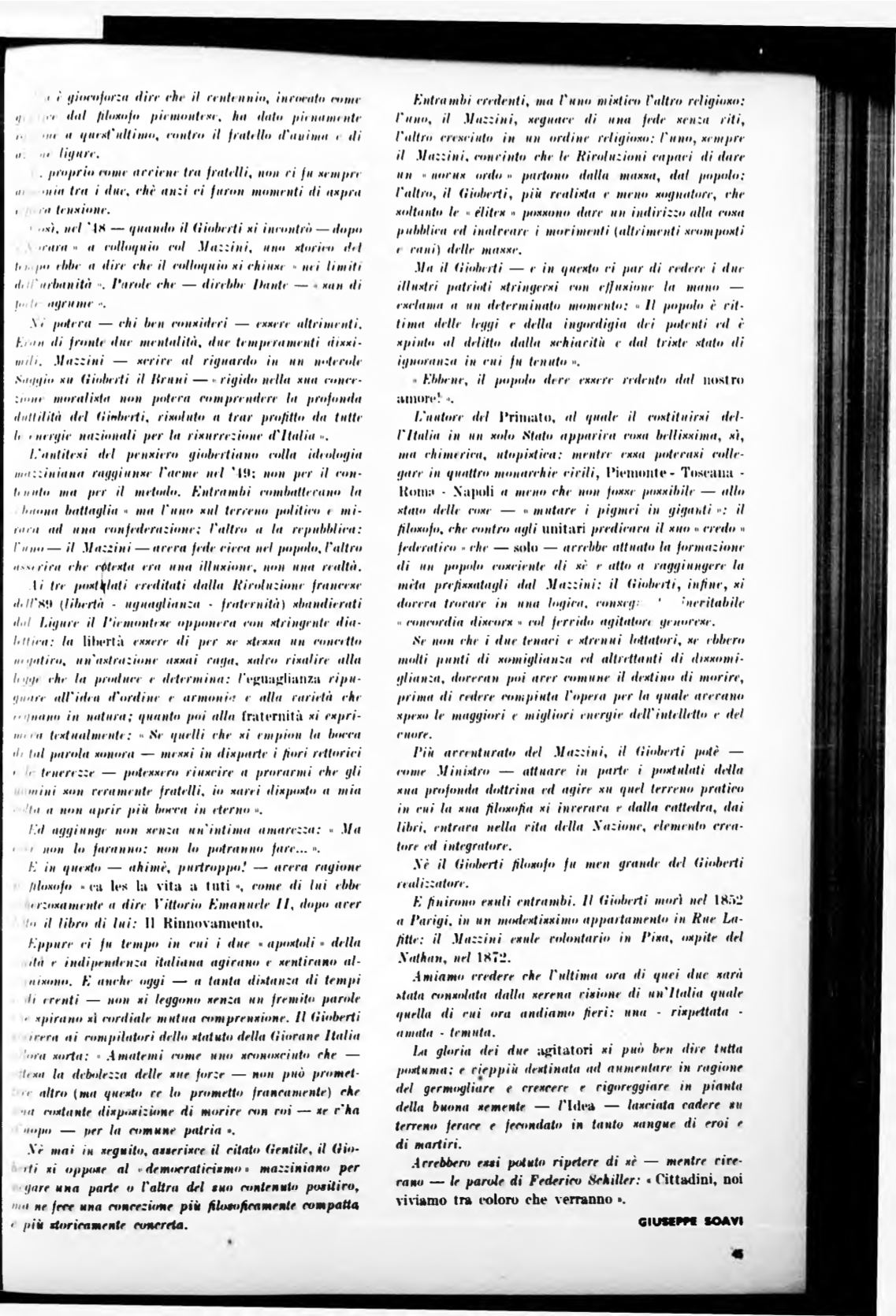
i i giocoforza ilire ehi il miti ini in, inriunii) inme
il
ri ilnl filosofo /iiimuntesi■, hit ilntn /ihmunente
/. »in
ii
quest'ultimo, enntm il fratello il'mi inni i ili
n: ’ii liijure.
. proprio tome tirriene tra fratelli, non ri fu seni/ne
tf min tra i due, ehè anzi ri furon momenti ili aspra
i . ra tensione.
' "s), nel *1S — quando il Gioberti si ineontrò — dopo
"rara » a colloquio col Mazzini, mio storilo dtl
hi, fin ebbe a dire che il colloquio si chiuse » nei limiti
ihil'urbanità ». Paride che — direbbe Ibiute — ■ san ili
finii agrume ».
Sé finterà — chi ben consitleri — essere altrimenti.
Kmn ili fronti due mentalità, ilue temperamenti dissi
mili. Mazzini — serire al riguarda in un nnterole
Saggio
sii
Gioberti il tinnii — «rigido nella sua conce
zioni moralista non poterà comprendere la profonda
ilnllilita del Giubati, risoluto a trar profitto ila tutte
h energie nazionali per la risurrezione d'Italia ».
I.'antitesi ilei pensiero giobertiano colla ideologia
mazziniana raggiunse l'acme nel ' 4!»: non per il con
tili ntn
ma per il mettalo. Entrambi combatterano la
Ininna battaglia » ma l'uno sul terreno politico i mi
nini ai! una confederazione: l'altro a la repubblica:
l'a un— il Mazzini — areni fede cieca nel popolo, l'altro
asserirti che intesta era una illusione, non una realtà.
.1/ tre postulati ereditati dalla Riroluzione francese
di II'AH (libertà - uguaglianza - fraternità) sbandierati
ilnl Ligure il Piemontese opponera con stringente dia-
Uttica: la libertà essere ili per se stessa un concetto
in liutini, un'astrazione assai ruga, salrtt risalire alla
h>/</» che la prniluce e ileterinina: /'eguaglianza ripu
gnare all'idea d'ordine e armonia e alla rarietà che
r>limino in natura; quanta poi alla fraternità si espri
mila testaalmente: » Se quelli che si empiuti la bacca
ili tal parola sonora — messi in ilisparte i fiori rettorici
• le tenerezze — potessero riuscire a provarmi che gli
mini son renimente fratelli, io sarei ilispasto a mia
<•"Ita a non aprir più btx'ca in eterno ».
Etl aggiunge non senza un'intima amarezza: « Ma
•■»/ inni lo faranno: non lo potranno fare...".
E in questo — ahimè, purtroppo! — areni ragione
filosofo « ra les lu vita a tuti % come di lui ebbe
trzosamente a dire Vittorio Emanuele I I , dopo arer
■ to il libro di lui: II Rinnovamento.
Eppure ci fu tempo in cui i due « apostoli » della
ita e indipendenza italiana agirano e sentirono al
tiisono. E anche oggi — a tanta distanza di tempi
li trenti — non si leggono senza un fremito parole
• spirano si cordiale mutua comprensione. Il Gioberti
itera ai compilatori dello statuto della Giurane Italia
'••ra sorta: « Amatemi come uno sconosciuto che —
lisa la debolezza delle sue forze — non può promet
ee altro (ma questo re lo prometUt francamente) che
’ta costante disposizione di morire con roi — se v'ha
uopo — fier la comune patria ».
Xè
mai
in
seguito, asserisce il citato Gentile, il Gio
iti si
oppose al
<•
democraticismo
«
mazziniano per
• gare
una parte o l'altra del suo
contenuto
positivo,
»mnefere una concezione più filosoficamente rompati
a
>più
stornamente concreta.
Entrambi credenti, ma l'uno mistico l'altro religioso:
l'uno, il Mazzini, seguace ili una fede senza riti,
l'altro discinto in un ortiine religioso: l'uno, sempre
il Mazzini, conrinto che le Rivoluzioni capaci di tiare
un " iiorus orilo » partono titilla massa, dal popolo;
l'altro, il Gioberti, più realista e meno sognatore, che
soltanto le »élites » possono tiare un indirizzo alla cosa
pubblica ed inalveavi' i mol imi itti (altrimenti scomposti
t ratti) delle masse.
Ma il Gioberti — e in questo ci par ili ridere i due
illustri patrioti stringersi con effusione la mano —
esclama a nn determinato liminentn: « Il ftopoln è fit
timit delle leggi e della ingordigia ilei potenti etl è
spinto al delitto dalla schiaritii e dal triste stato ili
ignoranza in cui fu tenuto ».
■
Ebbene, il po/mlo dire essere redento dal nostro
amore! ■>.
L'autore del Primato, al quale il costituirsi del
l'Italia in un solo Stato apparirti cosa bellissima, sì,
ma chimirica, utopistica: mentre essa poterasi colle-
gare in quattro monarchie cirili, Piemonte* Toscana -
Roma - Napoli a meno che non fosse possibile — allo
staio delle cose — « mutare i pigmei in giganti »: il
filosofo, che contro agli unitari predicarti il suo « credo »
federatiro . che — solo — avrebbe attuato la formazione
tli un popolo cosciente ili sè e atto a raggiungere la
mèta prefissatagli dal Mazzini: il Gioberti, infine, si
dorerà trorarc in una logica, conscgr • ;imitabile
» concordia discors » col fervido agitatori getmrese.
Se non che i due tenaci e strenui lottatori, se ebbero
molti fiunti di somiglianza ed altrettanti di dissomi
glianza, dorerait poi arer comune il destino ili morire,
prima di ridere compiuta l'opera per la quale arenino
speso le maggiori e migliori energie dell'intelletto e del
cuore.
Più arri attirato del Mazzini, il Gioberti potè —
come Ministro — attuare in parte i postulati della
sua profonda dottrina ed agire su quel terreno pratico
in cui la sua filosofia si inverava e dalla cattedra, dai
libri, entrava nella vita della Xazionc, elemento crea
tore ed integratore.
Xè il Gioberti filosofo fu men grande del Gioberti
realizzatore.
E finirono esuli entrambi. Il Gioberti morì nrl 1852
a Parigi, in un modestissimo appartamento in Rite La
fitte: il Mazzini esule volontario in Pisa, ospite del
Xathan, nel 1872.
Amiamo credere che l'ultima ora tli quei due sarà
stata consolata dalla serena visione di un'Italia quale
quella di cui ora andiamo fieri: una • rispettata •
amata - temuta.
L i gloria dei due agitatori si può ben dire tutta
postuma; e vieppiù destinata ad aumentare in ragione
del germogliare e crescere e vigoreggiare in pianta
della buona semente — /'Idea — lasciata cadere sii
terreno ferace e fecondato in tanto sangue di eroi e
di martiri.
Avrebbero essi potuto ripetere di sè — mentre rire-
vano — le parole di Fetirriro Srkiller: «
Cittadini, noi
viviamo tra eoloro che verranno ».
GIUSEPPE SOAVI


















