
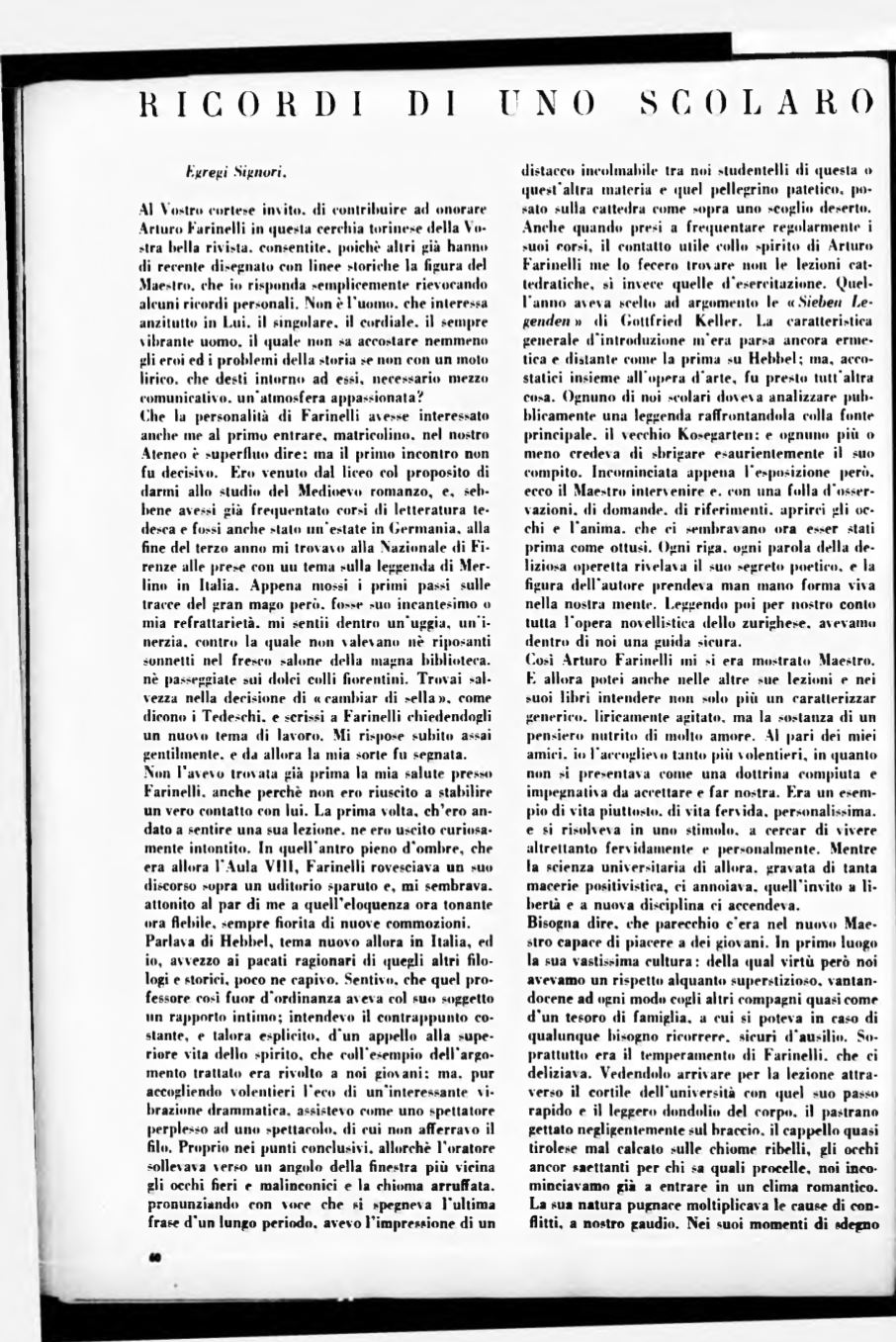
R I C O R D I
D I
U N O
S C O L A R O
Efirepi Signo ri,
Al Vostri» cortese invito, di contribuire ad onorare
Arturo Farinelli in questa cerchia torinese «Iella Vo
stra bella rivista, consentite, poiché altri già hanno
di recente disegnato con linee storiche la figura del
Maestro, che io risponda semplicemente rievocando
alcuni ricordi personali. Non è l'uomo, che interessa
anzitutto in Lui. il singolare, il cordiale, il sempre
vibrante uomo, il quale non sa accostare nemmeno
gli eroi ed i problemi della storia se non con un moto
lirico, che desti intorno ad essi, necessario mezzo
comunicativo, un'atmosfera appassionata?
Che la personalità di Farinelli avesse interessato
anche me al primo entrare, matricolino, nel nostro
Ateneo è superfluo dire: ma il primo incontro non
fu decisivo. Ero venuto dal liceo col proposito di
darmi allo studio del Medioevo romanzo, e, seb
bene avessi già frequentato corsi di letteratura te
desca e fossi anche stato
1111
‘estate in Germania, alla
fine del terzo anno mi trovavo alla Nazionale di Fi
renze alle prese con uu tema sulla leggenda di Mer
lino in Italia. Appena mossi i primi passi sulle
tracce del gran mago però, fosse silo incantesimo o
mia refrattarietà, mi sentii dentro un‘uggia, un'i
nerzia. contro la quale non valevano uè riposanti
sonnetti nel fresco salone della magna biblioteca,
nè passeggiate sui dolci colli fiorentini. Trovai sal
vezza nella decisione di « cambiar di sella ». come
dicono i Tedeschi, e scrissi a Farinelli chiedendogli
un nuovo tema di lavoro. Mi rispose subito assai
gentilmente, e da allora la mia sorte fu segnata.
Non l'avevo trovata già prima la mia salute presso
Farinelli, anche perchè non ero riuscito a stabilire
un vero contatto con lui. La prima volta, ch'ero an
dato a sentire una sua lezione, ne ero uscito curiosa
mente intontito. In quell'antro pieno d'ombre, che
era allora l'Aula Vili, Farinelli rovesciava un suo
discorso sopra un uditorio sparuto e, mi sembrava,
attonito al par di me a quell'eloquenza ora tonante
ora flebile, sempre fiorita di nuove commozioni.
Parlava di Hebbel, tema nuovo allora in Italia, ed
io, avvezzo ai pacati ragionari di quegli altri filo
logi e storici, poco ne capivo. Sentivo, che quel pro
fessore così fuor d'ordinanza aveva col suo soggetto
un rapporto intimo; intendevo il contrappunto co
stante, e talora esplicito, d'un appello alla supe
riore vita dello spirito, che coll'esempio dell'argo
mento trattato era rivolto a noi giovani; ma. pur
accogliendo volentieri l'eco di un'interessante vi
brazione drammatica, assistevo come uno spettatore
perplesso ad uno spettacolo, di cui non afferravo il
filo. Proprio nei punti conclusivi, allorché l'oratore
sollevava verso un angolo della finestra più vicina
gli occhi fieri e malinconici e la chioma arruffata,
pronunziando con voce che si spegneva l'ultima
frase d'un lungo periodo, avevo l'impressione di un
distacco incolmabile tra noi studenteUi di questa o
quest'altra materia e quel pellegrino patetico, po
sato sulla cattedra come sopra uno scoglio deserto.
Anche quando presi a frequentare regolarmente i
suoi corsi, il contatto utile collo spirito di Arturo
Farinelli me lo fecero trovare non le lezioni cat
tedratiche, si invece quelle d'esercitazione. Quel
l'anno aveva scelto ad argomento le «
Sieben Le-
genden
» ili Gottfried Keller. La caratteristica
generale d'introduzione m'era parsa ancora erme
tica e distante come la prima su Hebbel; ma, acco
statici insieme all'opera d'arte, fu presto tutt'altra
cosa. Ognuno di noi scolari doveva analizzare pub
blicamente una leggenda raffrontandola colla fonte
principale, il vecchio Kosegarteu; e ognuno più o
meno credeva di sbrigare esaurientemente il suo
compito. Incominciata appena l'esposizione però,
ecco il Maestro intervenire e. con una folla d'osser
vazioni. di domande, di riferimenti, aprirci gli oc
chi e l'anima, che ci sembravano ora esser stati
prima come ottusi. Ogni riga, ogni parola della de
liziosa operetta rivelava il suo segreto poetico, e la
figura dell'autore prendeva man mano forma viva
nella nostra mente. Leggendo poi per nostro conto
tutta l'opera novellistica dello zurighese, avevamo
dentro di noi una guida sicura.
Così Arturo Farinelli mi si era mostrato Maestro.
E allora potei anche nelle altre sue lezioni e nei
suoi libri intendere
11011
solo più un caratterizzar
generico, liricamente agitato, ma la sostanza di un
pensiero nutrito di molto amore. Al pari dei miei
amici, io raccoglievo tanto più volentieri, in quanto
non si presentava come una dottrina compiuta e
impegnativa da accettare e far nostra. Era un esem
pio di vita piuttosto, di vita fervida, personalissima,
e si risolveva in uno stimolo, a cercar di vivere
altrettanto fervidamente e personalmente. Mentre
la scienza universitaria di allora, gravata di tanta
macerie positivistica, ci annoiava, quell'invito a li
bertà e a nuova disciplina ci accendeva.
Bisogna dire, che parecchio c’era nel nuovo Mae
stro capace di piacere a dei giovani. In primo luogo
la sua vastissima cultura : della (piai virtù però noi
avevamo un rispetto alquanto superstizioso, vantan
docene ad ogni modo cogli altri compagni quasi come
d'un tesoro di famiglia, a cui si poteva in caso di
qualunque bisogno ricorrere, sicuri d'ausilio. So
prattutto era il temperamento di Farinelli, che ci
deliziava. Vedendolo arrivare per la lezione attra
verso il cortile dell'università con quel suo passo
rapido e il leggero dondolio del corpo, il pastrano
gettato negligentemente sul braccio, il cappello quasi
tirolese mal calcato sulle chiome ribelli, gli occhi
ancor saettanti per chi sa quali procelle, noi inco
minciavamo già a entrare in un clima romantico.
La sua natura pugnare moltiplicava le cause di con
flitti, a nostro gaudio. Nei suoi momenti di sdegno


















