
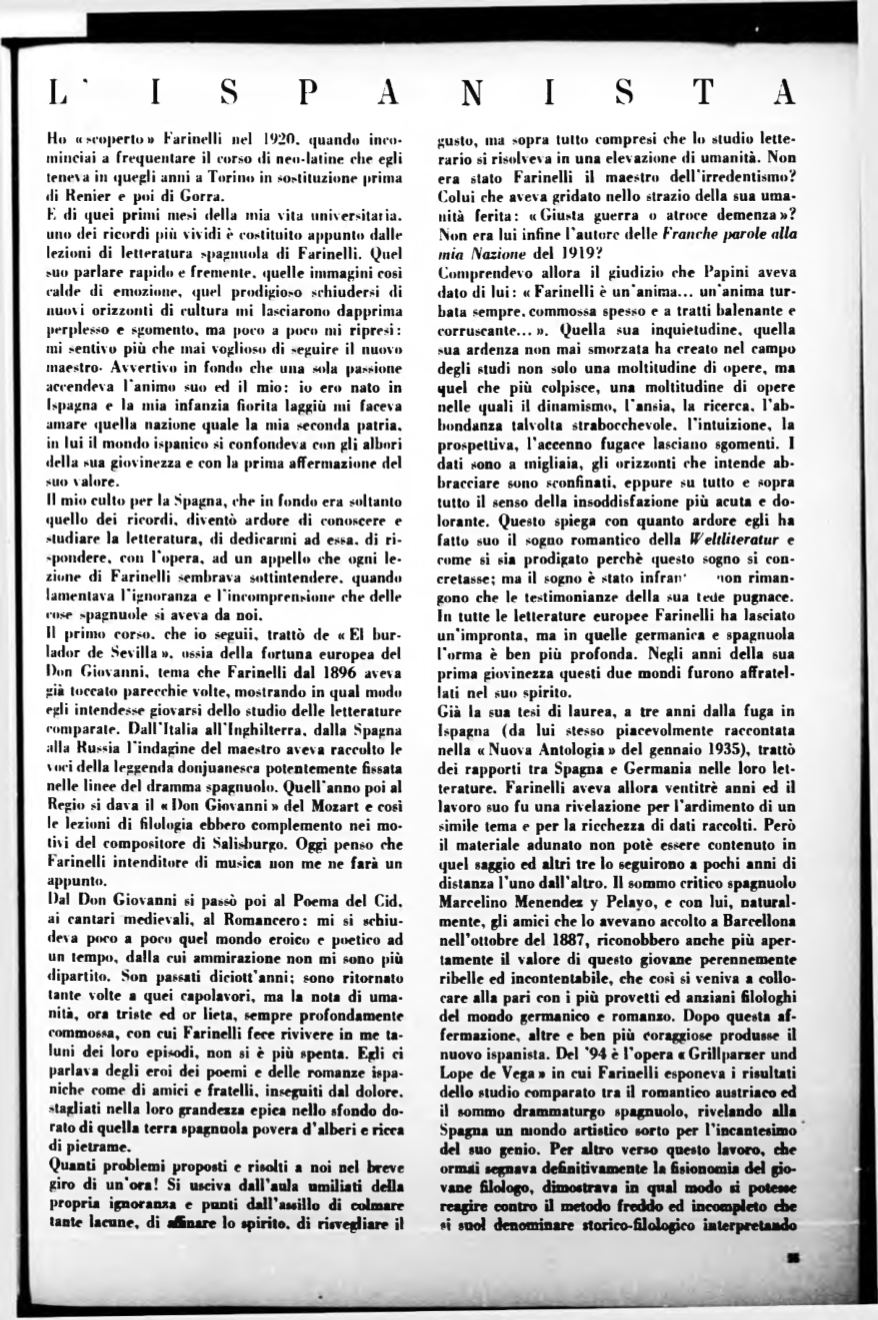
L '
I
S
P
A
N
I
S
T
A
Ho « scoperto» Farinelli nel
1920.
quando inco
minciai a frequentare il corso di neo-latine che egli
teneva in quegli anni a Torino in sostituzione prima
ili Kenier e poi di Gorra.
F. di quei primi me.«i della mia vita universitaria,
uno dei ricordi più vividi è costituito appunto dalle
lezioni di letteratura spaglinola di Farinelli. Quel
suo parlare rapido e fremente, quelle immagini così
calde di emozione, quel prodigioso schiudersi di
nuovi orizzonti di cultura mi lasciarono dapprima
perplesso e sgomento, ma poco a poco mi ripresi:
mi mentivo più che mai voglioso di seguire il nuovo
maestro- Avvertivo in fondo che una sola passione
accendeva l'animo suo ed il mio: io ero nato in
ispagna e la mia infanzia fiorita laggiù mi faceva
amare quella nazione quale la mia seconda patria,
iu lui il mondo ispanico si confondeva con gli albori
della sua giovinezza e con la prima affermazione del
suo valore.
Il mio culto per la Spagna, che in fondo era soltanto
quello dei ricordi, diventò ardore di conoscere e
studiare la letteratura, di dedicarmi ad essa, di ri
spondere. con l'opera, ad un appello che ogni le
zione di Farinelli sembrava sottintendere, quando
lamentava l'ignoranza e l'incomprensione che delle
rose spagnuole si aveva da noi.
Il primo corso, che io seguii, trattò de « FI bur-
lador de Sevilla ». ossia della fortuna europea del
Don Giovanni, tema che Farinelli dal 1896 aveva
già toccato parecchie volte, mostrando in qual mode»
egli intendesse giovarsi dello studio delle letterature
comparate. Dall’Italia all'Inghilterra, dalla Spagna
alla Kussia l'indagine del maestro aveva raccolto le
voci della leggenda donjuanesca potentemente fissata
nelle linee del dramma spagnuolo. Quell'anno poi al
Regio si dava il «Don Giovanni » del Mozart e così
le lezioni di filologia ebbero complemento nei mo
tivi del compositore di Salisburgo. Oggi penso che
Farinelli intenditore di musica non me ne farà un
appunto.
Dal Don Giovanni si passò poi al Poema del Cid.
ai cantari medievali, al Romancero: mi si schiu
deva poco a poco quel mondo eroico e poetico ad
un tempo, dalla cui ammirazione non mi sono più
dipartito. Son passati diciott'anni; sono ritornato
tante volte a quei capolavori, ma la nota di uma
nità, ora triste ed or lieta, sempre profondamente
commossa, con cui Farinelli fece rivivere in me ta
luni dei loro episodi, non si è più spenta. Egli ci
parlava degli eroi dei poemi e delle romanze ispa
niche come di amici e fratelli, inseguiti dal dolore,
stagliati nella loro grandezza epica nello sfondo do
rato di quella terra spagnuola povera d'alberi e ricca
di pietrame.
Quanti problemi proposti e risolti a noi nel breve
giro di un'ora! Si usciva dall'aula umiliati della
propria ignoranza e ponti dall'assillo di colmare
tante lacune, di affinare lo spirito, di risvegliare il
gusto, ma sopra tutto compresi che lo studio lette
rario si risolvev a in una elevazione di umanità. Non
era stato Farinelli il maestro dell'irredentismo?
Colui che aveva gridato nello strazio della sua uma
nità ferita: «Giusta guerra o atroce demenza»?
Non era lui infine l'autore delle
Franche
/tarole alla
mia Nazione
del 1919?
Comprendevo allora il giudizio che Papini aveva
dato di lui: « Farinelli è un'anima... un'anima tur
bata sempre, commossa spesso e a tratti balenante e
corruscante... ». Quella sua inquietudine, quella
>ua ardenza non mai smorzata ha creato nel campo
degli studi non solo una moltitudine di opere, ma
quel che più colpisce, una moltitudine di opere
nelle quali il dinamismo, l'ansia, la ricerca, l'ab
bondanza talvolta strabocchevole, l'intuizione, la
prospettiva, l'accenno fugace lasciano sgomenti. I
dati sono a migliaia, gli orizzonti che intende ab
bracciare sono sconfinati, eppure su tutto e sopra
tutto il senso della insoddisfazione più acuta e do
lorante. Questo spiega con quanto ardore egli ha
fatto suo il sogno romantico della
Weltliteratur
e
come si sia prodigato perchè questo sogno si con
cretasse; ma il sogno è stato infrair
*ion riman
gono che le testimonianze della sua tede pugnace.
In tutte le letterature europee Farinelli ha lasciato
un'impronta, ma in quelle germanica e spagnuola
l'orma è ben più profonda. Negli anni della sua
prima giovinezza questi due mondi furono affratel
lati nel suo spirito.
Già la sua tesi di laurea, a tre anni dalla fuga in
Ispagna (da lui stesso piacevolmente raccontata
nella « Nuova Antologia » del gennaio 1935), trattò
dei rapporti tra Spagna e Germania nelle loro let
terature. Farinelli aveva allora ventitré anni ed il
lavoro suo fu una rivelazione per l'ardimento di un
simile tema e per la ricchezza di dati raccolti. Però
il materiale adunato non potè essere contenuto in
quel saggio ed altri tre lo seguirono a pochi anni di
distanza l'uno dall'altro. Il sommo critico spagnuolo
Marcelino Menendez y Pelavo, e con lui, natural
mente, gli amici che lo avevano accolto a Barcellona
neirottobre del 1887, riconobbero anche più aper
tamente il valore di questo giovane perennemente
ribelle ed incontentabile, che così si veniva a collo
care alla pari con i più provetti ed anziani filoioghi
del mondo germanico e romanzo. Dopo questa af
fermazione, altre e ben più Coraggiose produsse il
nuovo ispanista. Del '94 è l'opera c Grillparzer und
Lope de Vega » in cui Farinelli esponeva i risultati
dello studio comparato tra il romantico austriaco ed
il sommo drammaturgo spagnuolo, rivelando alla
Spagna un mondo artistico sorto per l'incantesimo
del suo genio. Per altro verso questo lavoro, die
ormai segnava definitivamente la fisionomia del gio
vane filologo, dimostrava in qnal modo si potesse
reagire contro il metodo freddo ed incompleto che
si suoi denominare storico-filologico interpretando


















