
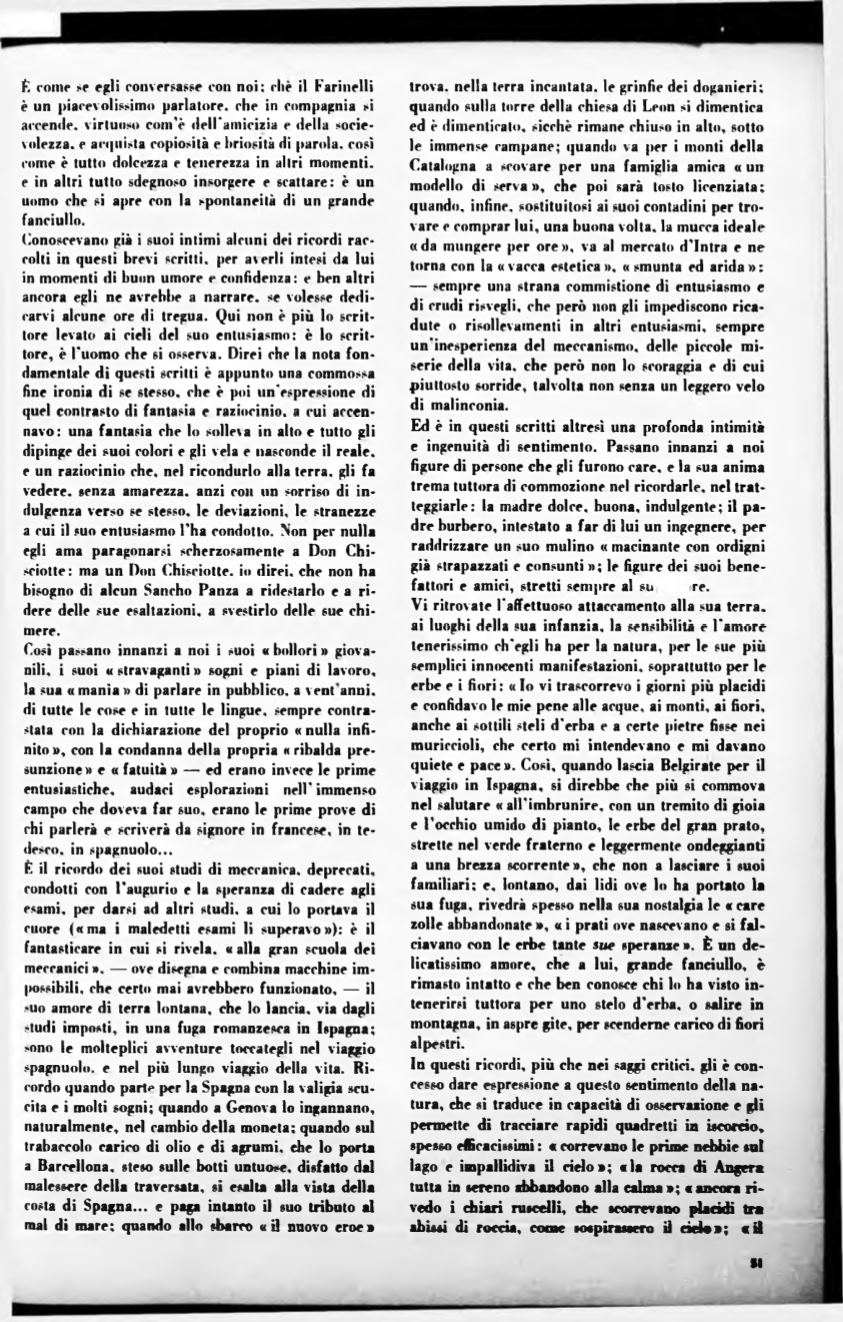
È come se egli conversasse con noi: che il Farinelli
è un piacevolissimo parlatore, che in compagnia si
accende, virtuoso com’è dell'amicizia e della socie
volezza. e acquista copiosità e briosità di parola, così
come è tutto dolcezza e tenerezza in altri momenti,
e in altri tutto sdegnoso insorgere e scattare: è un
uomo che si apre con la spontaneità di un grande
fanciullo.
Conoscevano già i suoi intimi alcuni dei ricordi rac
colti in questi brevi scritti, per averli intesi da lui
in momenti di buon umore e confidenza : e ben altri
ancora egli ne avrebbe a narrare, se volesse dedi
carvi alcune ore di tregua. Qui non è più lo scrit
tore levato ai cieli del suo entusiasmo: è lo scrit
tore, è l'uomo che si osserva. Direi che la nota fon
damentale di questi scritti è appunto una commossa
fine ironia di se stesso, che è poi un'espressione di
quel contrasto di fantasia e raziocinio, a cui accen
navo: una fantasia che lo solleva in alto e tutto gli
dipinge dei suoi colori e gli vela e nasconde il reale,
e un raziocinio che, nel ricondurlo alla terra, gli fa
vedere, senza amarezza, anzi con un sorriso di in
dulgenza verso se stesso, le deviazioni, le stranezze
a cui il suo entusiasmo l'ha condotto. Non per nulla
egli ama paragonarsi scherzosamente a Don Chi
sciotte : ma un Don Chisciotte, io direi, che non ha
bisogno di alcun Sancho Panza a ridestarlo e a ri
dere delle sue esaltazioni, a svestirlo delle sue chi
mere.
Così passano innanzi a noi i suoi « bollori » giova
nili, i suoi « stravaganti » sogni e piani di lavoro,
la sua «manìa» di parlare in pubblico, a vent anni,
di tutte le cose e in tutte le lingue, sempre contra
stata con la dichiarazione del proprio «nulla infi
nito », con la condanna della propria « ribalda pre
sunzione » e « fatuità » — ed erano invece le prime
entusiastiche, audaci esplorazioni nell'immenso
campo che doveva far suo, erano le prime prove di
chi parlerà e scriverà da signore in francese, in te
desco. in spagnuolo...
È il ricordo dei suoi studi di meccanica, deprecati,
condotti con l'augurio c la speranza di cadere agli
esami, per darsi ad altri studi, a cui lo portava il
cuore («ma i maledetti esami li superavo»): è il
fantasticare in cui si rivela. « alla gran scuola dei
meccanici ». — ove disegna e combina macchine im
possibili, che certo mai avrebbero funzionato, — il
suo amore di terra lontana, che lo lancia, via dagli
studi imposti, in una fuga romanzesca in Ispagna;
sono le molteplici avventure toccategli nel viaggio
spagnuolo. e nel più lungo viaggio della vita. Ri
cordo quando part*» per la Spagna con la valigia scu
cita e i molti sogni; quando a Genova lo ingannano,
naturalmente, nel cambio della moneta; quando sul
trabaccolo carico di olio e di agrumi, che lo porta
a Barcellona, steso sulle botti untuose, disfatto dal
malessere della traversata, si esalta alla vista della
costa di Spagna... e paga intanto il suo tributo al
mal di mare; quando allo sbarco «il nuovo eroe»
trova, nella terra incantata, le grinfie dei doganieri;
quando sulla torre della chiesa di Leon si dimentica
ed è dimenticato, sicché rimane chiuso in alto, sotto
le immense campane; quando va per i monti della
Catalogna a scovare per una famiglia amica « un
modello di serva», che poi sarà tosto licenziata;
quando, infine, sostituitosi ai suoi contadini per tro
vare e comprar lui, una buona volta, la mucca ideale
«da mungere per ore», va al mercato d'Intra e ne
torna con la «vacca estetica », « smunta ed arida » :
— sempre una strana commistione di entusiasmo e
di crudi risvegli, che però non gli impediscono rica
dute o risollevamenti in altri entusiasmi, sempre
un'inesperienza del meccanismo, delle piccole mi
serie della vita, che però non lo scoraggia e di cui
piuttosto sorride, talvolta non senza un leggero velo
di malinconia.
Ed è in questi scritti altresì una profonda intimità
e ingenuità di sentimento. Passano innanzi a noi
figure di persone che gli furono care, e la sua anima
trema tuttora di commozione nel ricordarle, nel trat
teggiarle: la madre dolce, buona, indulgente; il pa
dre burbero, intestato a far di lui un ingegnere, per
raddrizzare un suo mulino «macinante con ordigni
già strapazzati e consunti »; le figure dei suoi bene
fattori e amici, stretti sempre al su
re.
Vi ritrovate l'affettuoso attaccamento alla sua terra,
ai luoghi della sua infanzia, la sensibilità e l'amore
tenerissimo ch'egli ha per la natura, per le sue più
semplici innocenti manifestazioni, soprattutto per le
erbe e i fiori : « Io vi trascorrevo i giorni più placidi
e confidavo le mie pene alle acque, ai monti, ai fiori,
anche ai sottili steli d'erba e a certe pietre fisse nei
muriccioli, che certo mi intendevano e mi davano
quiete e pace ». Così, quando lascia Beigirate per il
viaggio in Ispagna, si direbbe che più si commova
nel salutare « all'imbrunire, con un tremito di gioia
e l'occhio umido di pianto, le erbe del gran prato,
strette nel verde fraterno e leggermente ondeggianti
a una brezza scorrente», che non a lasciare i suoi
familiari; e, lontano, dai lidi ove lo ha portato la
sua fuga, rivedrà spesso nella sua nostalgia le « care
zolle abbandonate », « i prati ove nascevano e si fal
ciavano con le erbe tante
sue
speranze ». È un de
licatissimo amore, che a lui, grande fanciullo, è
rimasto intatto e che ben conosce chi lo ha visto in
tenerirsi tuttora per uno stelo d'erba, o salire in
montagna, in aspre gite, per scenderne carico di fiori
alpestri.
In questi ricordi, più che nei saggi critici, gli è con
cesso dare espressione a questo sentimento della na
tura, che si traduce in capacità di osservazione e gli
permette di tracciare rapidi quadretti in bcorcio,
spesso efficacissimi : c correvano le prime nebbie sul
lago e impallidiva il cielo»; «la rocca di Angera
tutta in sereno abbandono alla calma»; «ancora ri
vedo i chiarì ruscelli, che scorrevano placidi tra
abissi di roccia, come sospirassero il d d* » ; « il
II


















