
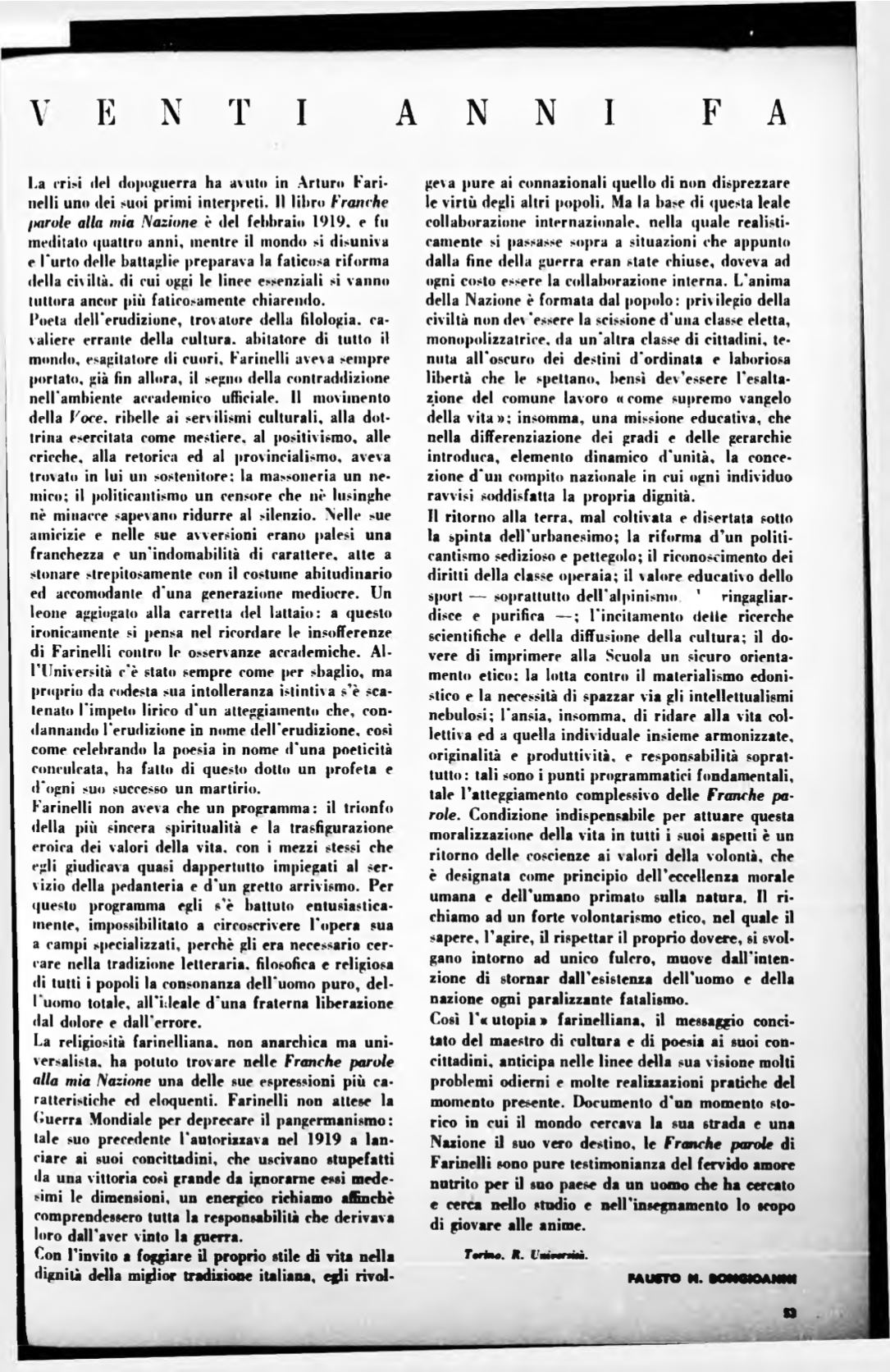
V
E
N
T
I
A N N I
F A
La crisi del dopoguerra ha avuto in Arturo Fari
nelli uno «lei suoi primi interpreti. Il lihro
Franche
Itarale alla mia Nazione
è «lei febbraio 1919. e fu
ineditato quattro anni, mentre il mondo si disuniva
e l'urto delle battaglie preparava la faticosa riforma
della civiltà, di eui oggi le linee etsenziali si vanno
tuttora ancor più faticosamente chiarendo.
Poeta dell'erudizione, trovatore della filologia, ca
valiere errante della cultura, abitatore di tutto il
mondo, esagitatore di cuori, Farinelli aveva sempre
p«»rtato, già fin allora, il segno della contraddizione
nell'ambiente accademico ufficiale. Il movimento
della
Voce,
ribelle ai servilismi culturali, alla dot
trina esercitata come mestiere, al positivismo, alle
cricche, alla retorica ed al provincialismo, aveva
trovato in lui un sostenitore: la massoneria un ne
mico; il politicantismo un censore che nè lusinghe
nè minacce sapevano ridurre al silenzio. Nelle sue
amicizie e nelle sue avversioni erano palesi una
franchezza e un'indomabilità di carattere, atte a
stonare >trepitosamente con il costume abitudinario
ed accomodante d'una generazione mediocre. Un
leone aggiogato alla carretta del lattaio: a questo
ironicamente si pensa nel ricordare le insofferenze
di Farinelli contro le o.«servanze accademiche. Al
l'Università c'è stato sempre come per sbaglio, ma
prtqirio da codesta sua intolleranza istintiva s’è sca
tenato l'impeto lirico d'un atteggiamento che, con
dannando l'erudizione in nome dell'erudizione, così
come celebrando la poesia in nome d'una poeticità
conculcata, ha fatto di questo dotto un profeta e
d'ogni suo successo un martirio.
Farinelli non aveva che un programma: il trionfo
della più sincera spiritualità e la trasfigurazione
eroica dei valori della vita, con i mezzi stessi che
egli giudicava quasi dappertutto impiegati al ser
vizio della pedanteria e d'un gretto arrivismo. Per
questo programma egli s’è battuto entusiastica
mente, impossibilitato a circoscrivere l'opera sua
a campi specializzati, perchè gli era necessario cer
care nella tradizione letteraria, filosofica e religiosa
di tutti i popoli la consonanza dell'uomo puro, del-
I uomo totale, all'ideale d'una fraterna liberazione
dal dolore e dall'errore.
La religiosità farinelliana. non anarchica ma uni
versalista. ha potuto trovare nelle
Franche parole
alla mia Nazione
una delle sue espressioni più ca
ratteristiche ed eloquenti. Farinelli non attese la
Guerra Mondiale per deprecare il pangermanismo:
tale suo precedente l'autorizzava nel 1919 a lan
ciare ai suoi concittadini, che uscivano stupefatti
da u a vittoria così grande da ignorarne essi mede
simi le dimensioni, un energico richiamo affinchè
comprendessero tutta la responsabilità che derivava
loro dall'aver vinto la guerra.
Con l'invito a foggiare il proprio stile di vita nella
dignità della miglior tradizione italiana, egli rivol
geva pure ai connazionali quello di non disprezzare
le virtù degli altri popoli. Ma la base di <|uesta leale
collaborazione internazionale, nella quale realisti
camente si passasse sopra a situazioni che appunto
dalla fine della guerra eran state chiuse, doveva ad
ogni costo essere la c«dlab«»razione interna. L'anima
della Nazione è formata dal popolo: privilegio della
civiltà non dev 'essere la scissione d'una classe eletta,
monopolizzatrice. da un'altra classe di cittadini, te
nuta all'oscuro dei destini d'ordinata e laboriosa
libertà che le spettano, bensì dev’essere l'esalta-
z.ione del comune lavoro « come supremo vangelo
della vita»; insomma, una missione educativa, che
nella differenziazione dei gradi e delle gerarchie
introdiH'a, elemento dinamico d'unità, la conce
zione d'un compito nazionale in cui ogni individuo
ravvisi soddisfatta la propria dignità.
Il ritorno alla terra, mal coltivata e disertata sotto
la spinta dell'urbanesimo; la riforma d’un politi
cantismo sedizioso e pettegolo; il riconoscimento dei
diritti della classe operaia; il valore educativo dello
sport — soprattutto dell'alpinismo
'
ringagliar
disce e purifica —; l'incitamento delle ricerche
scientifiche e della diffusione della cultura; il do
vere di imprimere alla Scuola un sicuro orienta
mento etico: la lotta contro il materialismo edoni
stico e la necessità di spazzar via gli intellettualismi
nebulosi; l'ansia, insomma, di ridare alla vita col
lettiva ed a quella indiv iduale insieme armonizzate,
originalità e produttività, e responsabilità soprat
tutto: tali sono i punti programmatici fondamentali,
tale l’atteggiamento complessivo delle
Franche pa
role.
Condizione indispensabile per attuare questa
moralizzazione della vita in tutti i suoi aspetti è un
ritorno delle coscienze ai valori della volontà, che
è designata come principio dell’eccellenza morale
umana e dell'umano primato sulla natura. Il ri
chiamo ad un forte volontarismo etico, nel quale il
sapere, l’agire, il rispettar il proprio dovere, si svol
gano intorno ad unico fulcro, muove dall'inten
zione di stornar dall’esistenza dell'uomo e della
nazione ogni paralizzante fatalismo.
Così l'« utopia » farinelliana, il messaggio conci
tato del maestro di cultura e di poesia ai suoi con
cittadini, anticipa nelle linee della sua visione molti
problemi odierni e molte realizzazioni pratiche del
momento presente. Documento d'un momento sto
rico in cui il mondo rcrcava la sua strada e una
Nazione il suo vero destino, le
Franche parole
di
Farinelli sono pure testimonianza del fervido amore
nutrito per il suo paese da un uomo che ha cercato
e cerca nello studio e nell'insegnamento lo scopo
di giovare alle anime.
Tmrimo.
Jt. (.jufwnàtà.
FAUSTO N. M m W M —
n


















