
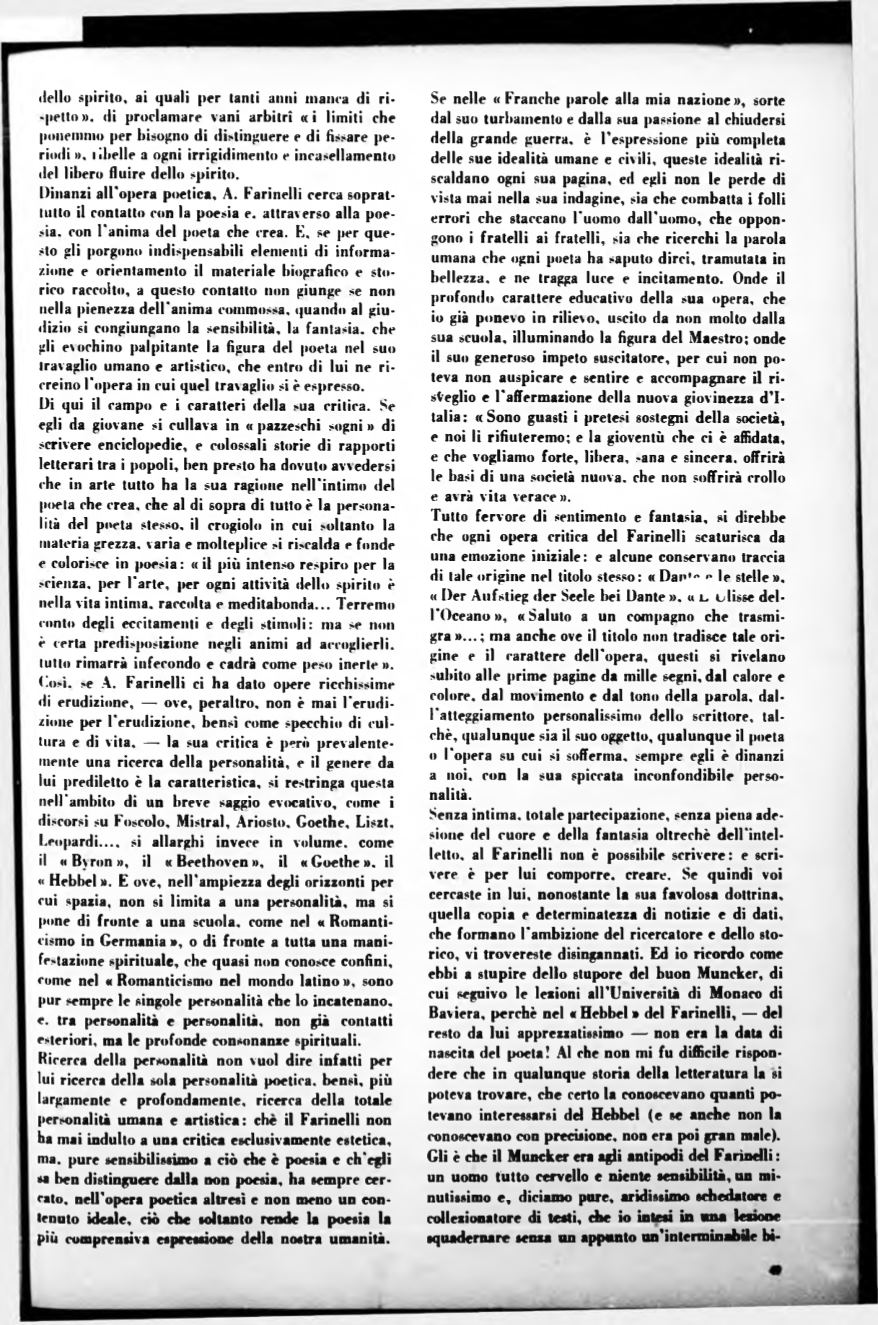
dello spirito, ai quali per tanti anni manca di ri
spetto». di proclamare vani arbitri « i limiti che
ponemmo per bisogno di distinguere e di fissare pe
riodi ». idielle a ogni irrigidimento e incasellamene
del libero fluire dello spirito.
Dinanzi all'opera poetica, A. Farinelli cerca soprat
tutto il contatto con la poesia e. attraverso alla poe
sia. con l'anima del poeta che crea. E, se per que
sto gli porgono indispensabili elementi di informa
zione e orientamento il materiale biografico e sto
rico raccolto, a questo contatto non giunge se non
nella pienezza dell'anima commossa, quando al giu
dizio si congiungano la sensibilità, la fantasia, che
gli evochino palpitante la figura del poeta nel suo
travaglio umano e artistico, che entro di lui ne ri
creino l'opera in cui quel travaglio si è espresso.
Di qui il campo e i caratteri della sua critica. Se
egli da giovane si cullava in « pazzeschi sogni » di
scrivere enciclopedie, e colossali storie di rapporti
letterari tra i popoli, ben presto ha dovuto avvedersi
che in arte tutto ha la sua ragione nell'intimo del
poeta che crea, che al di sopra di tutto è la persona
lità del poeta stesso, il crogiolo in cui soltanto la
materia grezza, varia e molteplice si riscalda e fonde
e colorisce in poesia: « il più intenso respiro per la
scienza. per l'arte, per ogni attività dello spirito è
nella vita intima, raccolta e meditabonda... Terremo
conto degli eccitamenti e degli stimoli: ma se non
è certa predisposizione negli animi ad accoglierli,
lutto rimarrà infecondo e cadrà come peso inerte ».
dosi. >e A. Farinelli ci ha dato opere ricchissime
di erudizione, — ove, peraltro, non è mai l'erudi
zione per l'erudizione, bensì come specchio di cul
tura e di vita, — la sua critica è però prevalente
mente una ricerca della personalità, e il genere da
lui prediletto è la caratteristica, si restringa questa
ncU'ambito di un breve saggio evocativo, come i
discorsi su Foscolo, Mistral, Ariosto, Goethe, Liszt.
Leopardi..., si allarghi invece in volume, come
il « Bvron », il « Beethoven », il «Goethe ». il
« Hebbel ». E ove, nell'ampiezza degli orizzonti per
cui spazia, non si limita a una personalità, ma si
pone di fronte a una scuola, come nel « Romanti
cismo in Germania », o di fronte a tutta una mani
festazione spirituale, che quasi non conosce confini,
come nel « Romanticismo nel mondo latino », sono
pur sempre le singole personalità che lo incatenano,
e. tra personalità e personalità, non già contatti
esteriori, ma le profonde consonanze spirituali.
Ricerca della personalità non vuol dire infatti per
lui ricerca della sola personalità poetica, bensì, più
largamente e profondamente, ricerca della totale
personalità umana e artistica: che il Farinelli non
ha mai indulto a una critica esclusivamente estetica,
ma. pure sensibilissimo a ciò che è poesia e ch'egli
sa ben distinguere dalla non poesia, ha sempre cer
cato, nell'opera poetica altresì e non meno un con
tenuto ideale, ciò che soltanto rende la poesia la
più comprensiva espressione della nostra umanità.
Se nelle «Franche parole alla mia nazione», sorte
dal suo turbamento e dalla sua passione al chiudersi
della grande guerra, è l'espressione più completa
delle sue idealità umane e civili, queste idealità ri
scaldano ogni sua pagina, ed egli non le perde di
vista mai nella sua indagine, sia che combatta i folli
errori che staccano l'uomo dall'uomo, che oppon
gono i fratelli ai fratelli, sia che ricerchi la parola
umana che ogni poeta ha saputo dirci, tramutata in
bellezza, e ne tragga luce e incitamento. Onde il
profondo carattere educativo della sua opera, che
10 già ponevo in rilievo, uscito da non molto dalla
sua scuola, illuminando la figura del Maestro; onde
11 suo generoso impeto suscitatore, per cui non po
teva non auspicare e sentire e accompagnare il ri
sveglio e l'affermazione della nuova giovinezza d 'I
talia: «Sono guasti i pretesi sostegni della società,
e noi li rifiuteremo; e la gioventù che ci è affidata,
e
che vogliamo forte, libera, sana e sincera, offrirà
le basi di una società nuova, che non soffrirà crollo
e
avrà vita verace».
Tutto fervore di sentimento e fantasia, si direbbe
che ogni opera critica del Farinelli scaturisca da
una emozione iniziale: e alcune conservano traccia
di tale origine nel titolo stesso: « Dai'*" * le stelle».
« Der Aufstieg der Seele bei Dante», u i_ olisse del-
l'Oceano », «Saluto a un compagno che trasmi
gra »...; ma anche ove il titolo non tradisce tale ori
gine e il carattere dell'opera, questi si rivelano
subito alle prime pagine da mille segni, dal calore e
colore, dal movimento e dal tono della parola, dal
l'atteggiamento personalissimo dello scrittore, tal
ché, qualunque sia il suo oggetto, qualunque il poeta
o l'opera su cui si sofferma, sempre egli è dinanzi
a noi. con la sua spiccata inconfondibile perso
nalità.
Senza intima, totale partecipazione, senza piena ade
sione del cuore e della fantasia oltreché dell'intel
letto, al Farinelli non é possibile scrivere: e scri
vere è per lui comporre, creare. Se quindi voi
cercaste in lui, nonostante la sua favolosa dottrina,
quella copia e determinatezza di notizie e di dati,
che formano l'ambizione del ricercatore e dello sto
rico, vi trovereste disingannati. Ed io ricordo come
ebbi a stupire dello stupore del buon Muncker, di
cui seguivo le lezioni all'Università di Monaco di
Baviera, perchè nel «Hebbel » del Farinelli, — del
resto da lui apprezzatissimo — non era la data di
nascita del poeta! AI che non mi fu difficile rispon
dere che in qualunque storia della letteratura la si
poteva trovare, che certo la conoscevano quanti po
tevano interessarsi dd Hebbel (e se anche non la
conoscevano con precisione, non era poi gran male).
Gli è che il Muncker era agli antipodi del Farinelli :
un uomo tutto cervello e niente sensibilità, un mi
nutissimo e, diciamo pure, aridissimo schedatore e
collezionatore di testi, die io intesi in una lenone
squadernare senza un appunto un'interminabile bi-


















