
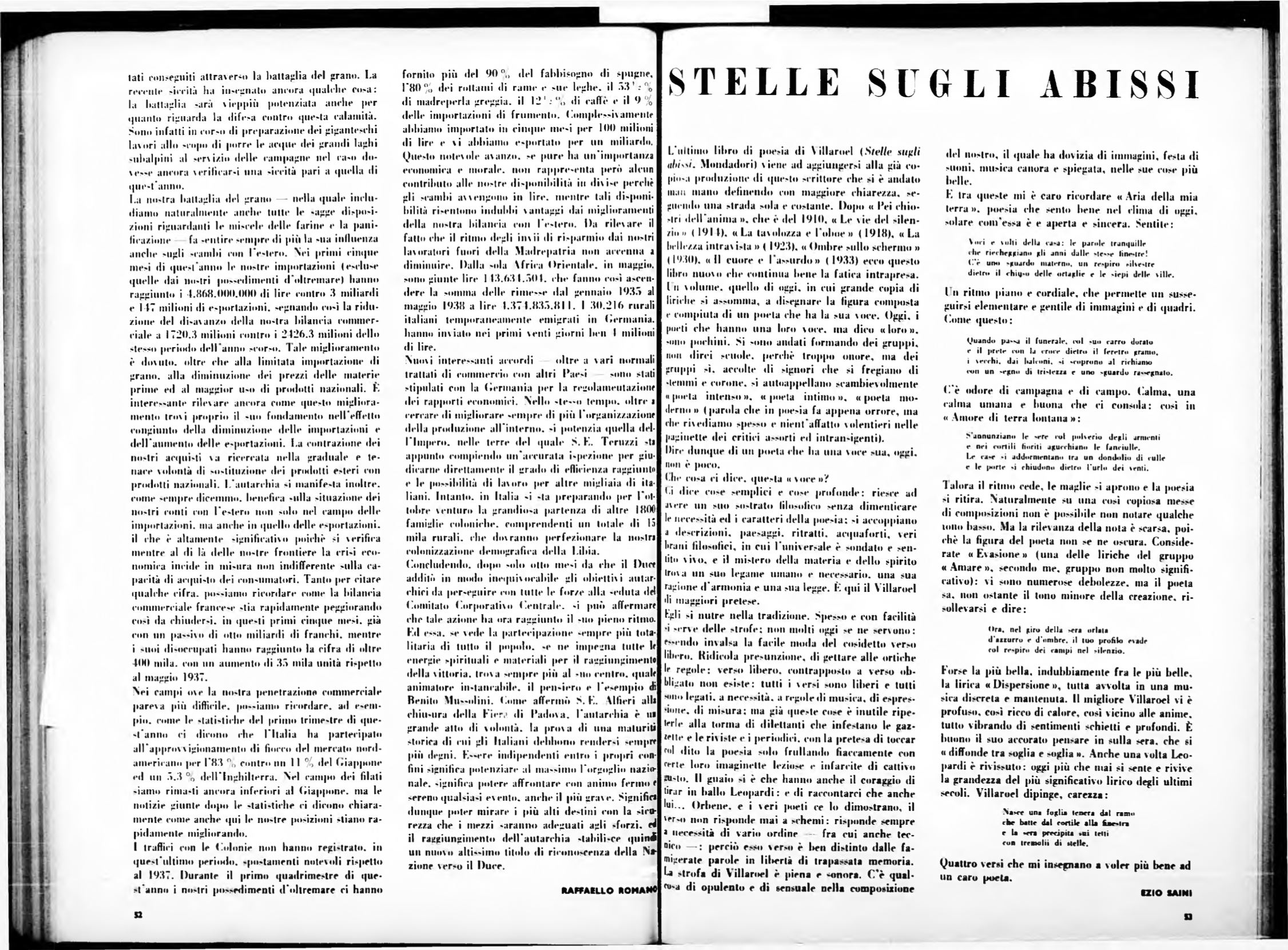
tati conseguiti attraverso la battaglia del grano. La
recente
'ir c ilà
Ita iiwgnato ancora qualche cosa:
la battaglia -ara vieppiù potenziata anche per
quanto riguarda la difesa contro questa calamità.
Sono infatti in corso di preparazione dei giganteschi
lavori allo scopo di porre le acque dei grandi laghi
subalpini al servizio delle campagne nel caso do
vesse ancora verificarsi una siccità pari a quella ili
quest'anno.
La nostra battaglia del grano — nella quale inclu
diamo naturalmente anche tutte le «agge disposi
zioni riguardanti le miscele delle farine
e
la pani
ficazione fa sentire sempre di più la sua influenza
anche
su g li
«cambi con
I
estero. Nei primi cinque
mesi di quest anno le nostre importazioni (escluse
quelle dai nostri possedimenti d oltremare) hanno
raggiunto i 4.868.000.000 di lire contro 3 miliardi
e 147 milioni di esportazioni, segnando così la ridu
zione del disavanzo della nostra bilancia commer
ciale a 1720.3 milioni contro i 2126.3 milioni dello
stesso
periodo deH aiino scorso, (ale miglioramento
è dovuto, oltre che alla limitata importazione di
grano, alla diminuzione dei prezzi delle materie
prime ed al maggior
Uso
di prodotti nazionali.
E
interessante rilevare ancora come questo migliora
mento trovi proprio il suo fondamento nell efTetto
congiunto della diminuzione delle importazioni
e
dell'aumento delle esportazioni. La contrazione dei
nostri acquisti va ricercata nella graduale e te
nace volontà di sostituzione dei prodotti esteri con
prodotti nazionali. L ’autarchia si manifesta inoltre,
come sempre dicemmo, benefica -lilla situazione dei
nostri conti con l’estero non
so lo
nel campo delle
importazioni, ma anche in quello delle esportazioni,
il che è altamente significativo poiché si verifica
mentre al rii
là
«Ielle nostre frontiere la crisi eco
nomica incide in misura non indifferente sulla ca
pacità di acquisto dei consumatori. Tanto per citare
qualche cifra, possiamo ricordare come la bilancia
commerciale francese »tia rapidamente peggiorami»»
così da chiudersi, in questi primi cinque mesi, già
con un passivo di otto miliardi di franchi, mentre
i suoi di'occupati hanno raggiunto la cifra di oltre
400 mila, con un aumento di 33 mila unità rispetto
al maggio 1937.
Nei campi ove la nostra penetrazione commerciale
pareva più difficile, possiamo ricordare, ad esem-
pio. come le statistiche «lei primo trimestre «li «pie-
st'anno ci dintno che l'Italia ha partecipato
all'approv vigionaniento «li fi«»cco «lei mercati» nord-
americano per 1*83 °ó contro liti 11 % del (riappone
e«l un 3.3 °ó dell’Inghilterra. Nel campo «lei filati
• iatm» rima-ti ancora inferiori al Chiappone. ma le
notizie giunte dopo le 'tati-tiche ci dic«»n«> chiara
mente «'olile anche qui le n«»stre pttsizioni stiano ra
pidamente migliorando.
I traffici con le Colonie non hanm» registrati». in
(juest'ultimo periodo. 'p«»stamenti notevoli rispetto
al 1937. Durante il prim«» quadrimestre «li que-
st anno i nostri poss<*dimenti «l’oltremare ci hanm»
52
fornito più del
90
°,( «lei fabbisogno di spugne,
|'80
% dei rottami «li rame e sue leghe, il
33
1
: %
di madreperla gr«*ggia. il 12’ : % di calle e il 9%
delle importazioni di frumento. Complessivamente
abbiamo importai*» in cimpie me-i per 100 milioni
«li lire e vi abbiami» esportato per un miliardo.
(Questo notevole avanzo,
se
pure ha un'importanza
economica e morale, non rapprc'cnta però alcun
contributi» alle nostre disponibilità ili
divise
perché
gli scambi avvengono in lire, numtre tali disponi-
hilita risentono indubbi vantaggi dai miglioramenti
della nostra bilancia con l’esten». Da rilevare il
fatto che il ritmo degli invii di risparmio dai n«»slri
lavoratori fuori della Madrepatria non accenna a
diminuire. Dalla sola \frica Orientale, ili maggio,
sono giunte lire
113.634.304.
che fanno «•«•si ascen
dere la somma «Ielle rimesse dal gennaio
1933
al
maggio
19.38
a lire
4.374.833.811.
I
30.216
rurali
italiani temporaneamente emigrati in (Germania,
hanno inviato nei primi venti giorni ben t milioni
di lire.
Nuovi interessanti accorili
«»ltre a vari normali
trattati «li «•«itnmercio cim altri Paesi — sono stati
stipulati con la Germania per la r<*golanieutaziont
«lei rapporti economici. Nello ste—o tempo. oltr«- a
cercare di migliorare sempre di più l'organizzazione
della produzione all'interno, 'i potenzia «piella del
l'impero. nelle terre del quale S. K. Teruzzi -ta
appunto compicn«lo un’accurata ispezione per giu
dicarne direttamente il grado di efficienza raggiunto
e le possibilità «li lavori» per altre migliaia di ita
liani. Intanto, in Italia si >ta preparando per l’ot
tobre venturo la grandiosa partenza di altre
1800
famiglie coloniche, comprendenti un totale «li ló
mila rurali, che dovranno perfezionare la nostri
«‘«•Ionizzazione demografica «Iella Libia.
Concludemlo. dopo s«tl«» otto mesi da che il Ducf
additò in modo inequivocabile gli obiettivi autar
chici da perseguire con tutte le forze alla seduta «lei
Comitato Corporativo Centrale, si può affermar?
che tale azione ha ora raggiunto il 'ilo pieno ritmo.
K«l essa, se vede la partei-ipazione sempre più t«»ta-
litaria di tutt«» il popolo. •«* ne impenna tutte Ir
energie spirituali e materiali per il raggiungimento
della vittoria, trova sempre più al
-ilo
centro, <jualf
animatore instancabile, il pensiero e l'esempio di
Benito Mussolini. Come affermò S. K. Alfieri alla
chiusura «Iella Fiera «li Padova, l'autarchia è un
grande atto di volontà, la prova «li una maturiti
storica di cui gli Italiani «lehhono rendersi sempre
più degni. F»sere indipendenti entro i propri «’«»n-
fini significa potenziare al massimi» l'orgoglio nazio
nale. significa potere affrontare c«»n animo ferino e
sereno qualsiasi evento, anche il più grave. Significò
dunque poter mirare i più alti destini con la scu
rezza che i mezzi «aranno adeguati agli sf«»rzi. e«l
il raggiungimento deH'autarchia stabilisce «piindi
un nuovo altissimi» titolo «li riconoscenza della Na
zione verso il Duce.
RAFFAELLO ROMA*
S T E L L E S C
L'ultimo libro di poesia di \ illaroel (Stelle stigli
aitici. Mondadori) viene ad aggiungersi alla già co
piosa produzioni- di
«piesto
scrittore che si è andato
man mano 4Ìefìnen<i«> con maggiore chiarezza, se
guendo una strada sola e costante. Dop«» « Pei chio
stri dell anima >». che v del 1910, « Le vie del silen
zio » ( 1914), « La tavolozza e 1«»b«»e>» ( 1918), « La
bellezza intravista » ( 1923), « Ombre sullo schermo »
( 1930), « Il cu«»re «* I assurdo» ( 1933) ecco <|uesto
libro nuovo che continua bene la fatica intrapresa.
In volume, «jnello «li oggi, in cui grande copia di
liriche si assomma, a disegnare la figura composta
e compiuta di un poeta che ha la sua v«»«‘e. Oggi, i
poeti che hanno una loro v«»ce, ma «li***» «loro»,
sono
pochini. Si
son«»
andati formando dei gruppi,
non dir«*i scuole, perchè tntppo onore, ma «lei
gruppi si, accolte «li signori che si fregiano «li
•lemmi e corone, si autoappellano scambievolmente
«poeta intenso », « poeta intimi» », « poeta mo
derno » (parola che ili poesia fa appena orrore, ina
«•Ile
rivediamo
spessi»
e nielli affatto volentieri nelle
paginette «lei critici assorti ed intransigenti).
Dire dunque di un p«»eta che ha una voce sua, oggi,
non è poco.
(.Ile «-osa ci «lii-e. questa « voce »?
Li
di«-e cose semplici e cose pr«tf«»ude: riesce ad
avere un suo s«»strat«»
filosofici»
senza dimenticare
le necessità e«l i caratteri della p«»esia; si accoppiano
a descrizioni, paesaggi, ritratti, acquafòrti, veri
liraui filosofici, ili cui l'universale è sondato e sen
tito
vivo, e il mistero «Iella materia e dello spirito
trova un su«» legame umano e necessario, una sua
ragione d'armonia e una sua legge. È «|ui il Yillaroel
ili maggiori pretese.
Egli si nutre nella tradizi«»ue. Spesso e con facilità
*i serve «Ielle str«»fe: non limiti oggi se ne servono:
essendo invalsa la facile moda «lei cosidett«» vers«»
libero. Kidicola presunzione, di gettare alle ortiche
li* regole: vers«» libero, contrapposto a verso ob
bligati» non esiste: tutti i versi sono liberi e tutti
nino legati, a necessità, a regole «li musica, di espres
sone. di misura; ma già queste cose è inutile ripe-
t«*rle alla t«»rma di dilettanti che infestano le gaz-
lette e le riv iste e i periodici, con la pretesa di toccar
r"l «lito la poesia s«»lo frullando fiaccamente c«m
orte l«»ro imaginette leziose e infarcite di cattivo
sU'to. Il guaio si è che hanno am*he il coraggio di
lirar in hallo Le«»pardi: e di racc«»ntarci che anche
lui... Orbene, e i veri p«»eti ce lo dimostrano, il
'er.o non risp«»nde mai a schemi : risponde sempre
* necessità di vario ordine — fra cui anche tec
nico — : perciò esso verso è ben distinto dalle
fa
migerate parole in li!»ertà di trapassata memoria.
La strofa
di V
illaroel è piena e sonora. C'è
qual-
n>sa di opulento e
di
sensuale nella
composizione
G L I A B I S S I
«lei nostro, il «piale ha dovizia di immagini, festa di
suoni, musica canora e spiegata, nelle sue c«»se più
belle.
F tra queste mi è caro ricordare « Aria «Iella mia
terra ». poesia che sento bene nel dima di oggi,
s«»lare coni essa è e aperta e sincera. Sentite:
\uri e >
olii del la casa: Ir panile tranquille
•Ile riecheggiano (ili anni dalle . t e e line-ire!
C'è uno 'guardo materno, un respiro i>il\r>tre
dietro il ehiijMi delle ortaglie e le siepi delle \ille.
I n ritmi» piano e cordiale, che permette un susse
guirsi elementare e gentile di immagini e di «piadri.
Come «juesto:
«Quando passa il funerale, eoi >uo carro durato
e il prete eoi» la crore dietro il feretro gramo,
i vecchi, dai lialeoni. »i scoprono al richiamo
eon un .egno di tristezza e uno .guardo ra.*egnato.
C'è odore di campagna e di campo. Calma, una
calma umana e buona «‘he ci consola: cosi in
«Amore di terra lontana»:
>annunziano le «ere eoi polverio degli armenti
e nei cortili fioriti agucchiano le fanciulle.
Le ca»e si addormentano tra un dondolio di culle
e le porte .i chiudono dietro l'urlo dei \enli.
1 alora il ritmo <*ede, le maglie si aprono e la poesia
si ritira. Naturalmente su una cosi copiosa messe
di c«»mposizioni non è possibile non notare qualche
nino basso. Ma la rilevanza della nota è scarsa, poi
ché la figura del poeta non se ne oscura. Conside
rate « Fvasione » (una «Ielle liriche del gruppo
« Amare », secondo me, gruppo non m«»lto signifi
cativo): vi som» numerose debolezze, ma il poeta
sa, non ostante il tono minore «Iella «'reazione, ri
sollevarsi e dire:
«Ira, nel giro della sera orlala
d'azzurro e d'ombre, il tuo profilo e\ade
col re.piro dei rampi nel silenzio.
Forse la più bella, indubbiamente fra le più belle,
la lirica « Dispersione », tutta avvolta in una mu
sica discreta e mantenuta. Il migliore Yillaroel vi è
profuso, così ricco di calore, c«>si vicino alle anime,
tutto vibrando di sentimenti schietti e profondi. È
buono il suo a«'corato pensare in sulla sera, che si
« diffonde tra soglia e soglia ». Anche una volta Leo
pardi è rivissuto : oggi più che mai si sente e rivive
la grandezza del più significativo lirico degli ultimi
secoli. Yillaroel dipinge, carezza:
-Nasce una foglia tenera dal ramo
che batte dal cortile alla finestra
e la .era precipita »ui tetti
con tremolìi di delle.
(Quattro versi che mi insegnano a voler più bene ad
un caro poeta.
IZIO CAINI
a


















