
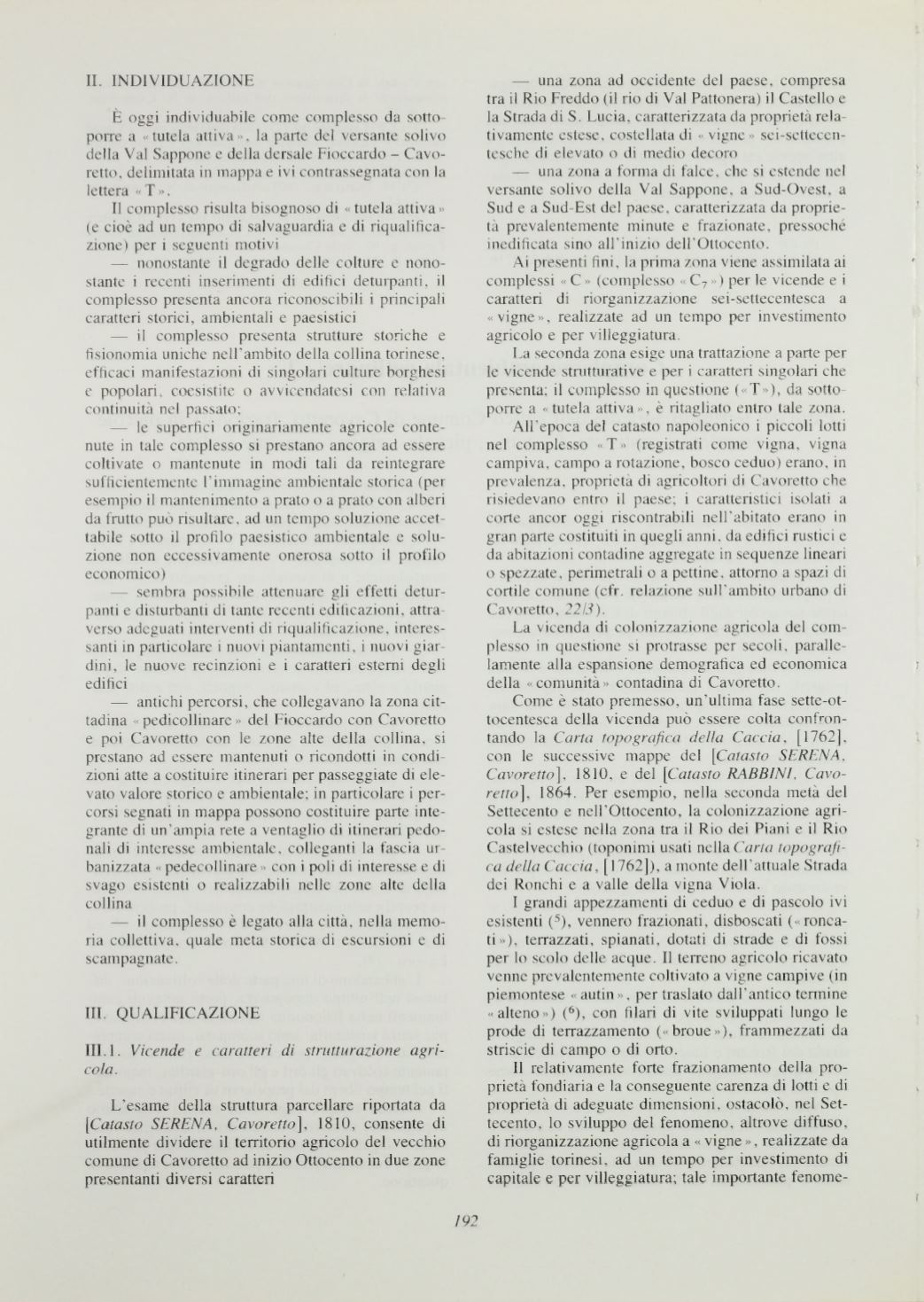
II. INDIVIDUAZIONE
È oggi individuabile come complesso da sotto-
porre a « tutela attiva » , la parte del versante solivo
della Val Sappone e della dersale Fioccardo – Cavo-
retto, delimitata in mappa e ivi contrassegnata con la
lettera « T ».
Il complesso risulta bisognoso di «tutela attiva»
(e cioè ad un tempo di salvaguardia e di riqualifica-
zione) per i seguenti motivi
— nonostante il degrado delle colture e nono-
stante i recenti inserimenti di edifici deturpanti, il
complesso presenta ancora riconoscibili i principali
caratteri storici, ambientali e paesistici
- il complesso presenta strutture storiche e
fisionomia uniche nell'ambito della collina torinese,
efficaci manifestazioni di singolari culture borghesi
e popolari, coesistite o avvicendatesi con relativa
continuità nel passato;
- le superfici originariamente agricole conte-
nute in tale complesso si prestano ancora ad essere
coltivate o mantenute in modi tali da reintegrare
sufficientemente l'immagine ambientale storica (per
esempio il mantenimento a prato o a prato con alberi
da frutto può risultare, ad un tempo soluzione accet-
tabile sotto il profilo paesistico ambientale e solu-
zione non eccessivamente onerosa sotto il profilo
economico)
- sembra possibile attenuare gli effetti detur-
panti e disturbanti di tante recenti edificazioni, attra-
verso adeguati interventi di riqualificazione, interes-
santi in particolare i nuovi piantamenti, i nuovi giar-
dini, le nuove recinzioni e i caratteri esterni degli
edifici
- antichi percorsi, che collegavano la zona cit-
tadina « pedicollinare » del Fioccardo con Cavoretto
e poi Cavoretto con le zone alte della collina, si
prestano ad essere mantenuti o ricondotti in condi-
zioni atte a costituire itinerari per passeggiate di ele-
vato valore storico e ambientale; in particolare i per-
corsi segnati in mappa possono costituire parte inte-
grante di un'ampia rete a ventaglio di itinerari pedo-
nali di interesse ambientale, colleganti la fascia ur-
banizzata «pedecollinare» con i poli di interesse e di
svago esistenti o realizzabili nelle zone alte della
collina
- il complesso è legato alla città, nella memo-
ria collettiva, quale meta storica di escursioni e di
scampagnate.
III.
QUALIFICAZIONE
III.1. Vicende e caratteri di strutturazione agri-
cola.
L'esame della struttura parcellare riportata da
[Catasto SERENA, Cavoretto],
1810, consente di
utilmente dividere il territorio agricolo del vecchio
comune di Cavoretto ad inizio Ottocento in due zone
presentanti diversi caratteri
- una zona ad occidente del paese, compresa
tra
il
Rio Freddo (il rio di Val Pattonera) il Castello e
la Strada di S. Lucia, caratterizzata da proprietà rela-
tivamente estese, costellata di « vigne » sei-settecen-
tesche di elevato o di medio decoro
— una zona a forma di falce, che si estende nel
versante solivo della Val Sappone, a Sud-Ovest, a
Sud e a Sud-Est del paese, caratterizzata da proprie-
tà prevalentemente minute e frazionate, pressoché
inedificata sino all'inizio dell'Ottocento.
Ai presenti fini, la prima zona viene assimilata ai
complessi 0C » (complesso « C, ») per le vicende e i
caratteri di riorganizzazione sei-settecentesca a
vigne», realizzate ad un tempo per investimento
agricolo e per villeggiatura.
La seconda zona esige una trattazione a parte per
le vicende strutturative e per i caratteri singolari che
presenta; il complesso in questione (»T»), da sotto-
porre a «tutela attiva», è ritagliato entro tale zona.
All'epoca del catasto napoleonico i piccoli lotti
nel complesso «T» (registrati come vigna, vigna
campiva, campo a rotazione, bosco ceduo) erano, in
prevalenza, proprietà di agricoltori di Cavoretto che
risiedevano entro il paese; i caratteristici isolati a
corte ancor oggi riscontrabili nell'abitato erano in
gran parte costituiti in quegli anni, da edifici rustici e
da abitazioni contadine aggregate in sequenze lineari
o spezzate, perimetrali o a pettine, attorno a spazi di
cortile comune (cfr. relazione sull'ambito urbano di
Cavoretto,
22/3).
La vicenda di colonizzazione agricola del com-
plesso in questione si protrasse per secoli, paralle-
lamente alla espansione demografica ed economica
della «comunità» contadina di Cavoretto.
Come è stato premesso, un'ultima fase sette-ot-
tocentesca della vicenda può essere colta confron-
tando la
Carta topografica detla Caccia,
[1762],
con le successive mappe del
[Catasto SERENA,
Cavoretto],
1810,
e
del
[Catasto RABBINI, Cavo-
retto],
1864. Per esempio, nella seconda metà del
Settecento e nell'Ottocento, la colonizzazione agri-
cola si estese nella zona tra il Rio dei Piani e il Rio
Castelvecchio (toponimi usati nella
Carta topografi-
ca detta Caccia, [17621),
a monte dell'attuale Strada
dei Ronchi e a valle della vigna Viola.
I grandi appezzamenti di ceduo e di pascolo ivi
esistenti (
5
), vennero frazionati, disboscati (« ronca-
ti »), terrazzati, spianati, dotati di strade e di fossi
per lo scolo delle acque. Il terreno agricolo ricavato
venne prevalentemente coltivato a vigne campive (in
piemontese « autin », per traslato dall'antico termine
« alteno ») (
6
), con filari di vite sviluppati lungo le
prode di terrazzamento (« broue »), frammezzati da
striscie di campo o di orto.
Il relativamente forte frazionamento della pro-
prietà fondiaria e la conseguente carenza di lotti e di
proprietà di adeguate dimensioni, ostacolò, nel Set-
tecento, lo sviluppo del fenomeno, altrove diffuso,
di riorganizzazione agricola a « vigne » , realizzate da
famiglie torinesi, ad un tempo per investimento di
capitale e per villeggiatura; tale importante fenome-
192


















