
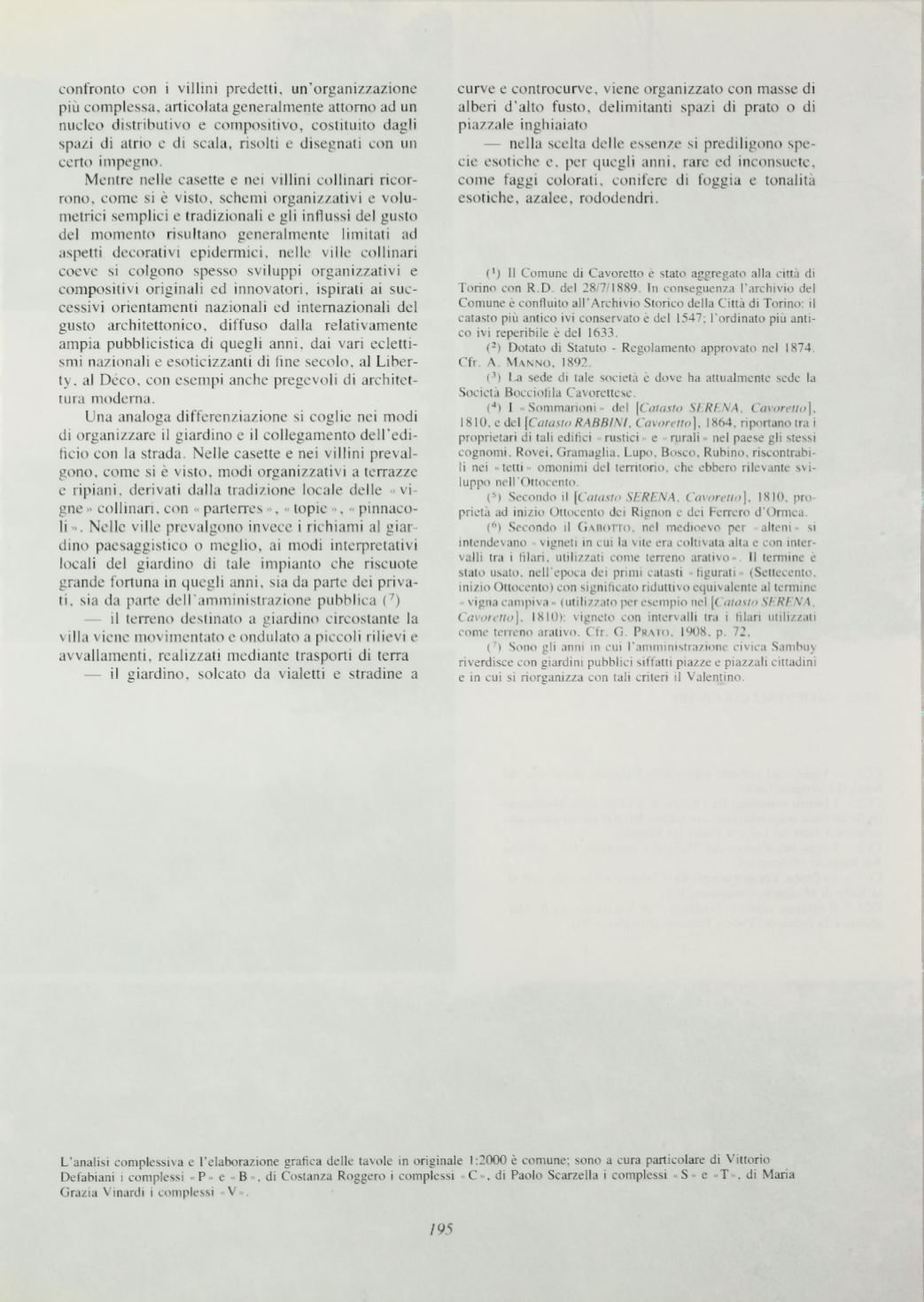
confronto con i villini predetti, un'organizzazione
più complessa, articolata generalmente attorno ad un
nucleo distributivo e compositivo, costituito dagli
spazi di atrio e di scala, risolti e disegnati con un
certo impegno.
Mentre nelle casette e nei villini collinari ricor-
rono, come si è visto, schemi organizzativi e volu-
metrici semplici e tradizionali e gli influssi del gusto
del momento risultano generalmente limitati ad
aspetti decorativi epidermici, nelle ville collinari
coeve si colgono spesso sviluppi organizzativi e
componitivi originali ed innovatori, ispirati ai suc-
cessivi orientamenti nazionali ed internazionali del
gusto architettonico, diffuso dalla relativamente
ampia pubblicistica di quegli anni, dai vari ecletti-
smi nazionali e esoticizzanti di fine secolo, al Liber-
ty, al Déco, con esempi anche pregevoli di architet-
tura moderna.
Una analoga differenziazione si coglie nei modi
di organizzare il giardino e il collegamento dell'edi-
ficio con la strada. Nelle casette e nei villini preval-
gono, come si è visto, modi organizzativi a terrazze
e ripiani, derivati dalla tradizione locale delle «vi-
gne» collinari, con «parterres», « topie», « pinnaco-
li» . Nelle ville prevalgono invece i richiami al giar-
dino paesaggistico o meglio, ai modi interpretativi
locali del giardino di tale impianto che riscuote
grande fortuna in quegli anni, sia da parte dei priva-
ti, sia da parte dell'amministrazione pubblica
(
7
)
- il
terreno destinato a giardino circostante la
villa viene movimentato e ondulato a piccoli rilievi e
avvallamenti, realizzati mediante trasporti di terra
- il giardino, solcato da vialetti e stradine a
curve e controcurve, viene organizzato con masse di
alberi d'alto fusto, delimitanti spazi di prato o di
piazzale inghiaiato
nella scelta delle essenze si prediligono spe-
cie esotiche e, per quegli anni, rare ed inconsuete,
come faggi colorati, conifere di foggia e tonalità
esotiche, azalee, rododendri.
(1) Il Comune di Cavoretto
è
stato aggregato alla città di
Torino con R.D. del 28/7/1889. In conseguenza l'archivio def
Comune è confluito all'Archivio Storico della Città di Torino: il
catasto più antico ivi conservato
è
del 1547; l'ordinato più anti-
co ivi reperibile è del 1633.
(2) Dotato di Statuto - Regolamento approvato nel 1874.
Cfr. A.
MANNO,
1892.
(3) La sede di tale società
è
dove ha attualmente sede la
Società Bocciofila Cavorettese.
(4) I « Sommarioni del
[Catasto SERENA, Cavoretto],
1810, e del
[Catasto RABBINI, Cavorettol,
1864, riportano tra i
proprietari di tali edifici « rustici» e « rurali » nel paese gli stessi
cognomi, Rovei, Gramaglia, Lupo, Bosco, Rubino, riscontrabi-
li nei « tetti » omonimi del territorio, che ebbero rilevante svi-
luppo nell'Ottocento.
(5) Secondo il
[Catasto SERENA, Cavoretto],
1810, pro-
prietà ad inizio Ottocento dei Rignon e dei Ferrero d'Ormea.
(6) Secondo il
GABOTrO,
nel medioevo per « alleni » si
intendevano vigneti in cui la vite era coltivata alta e con inter-
valli tra i filari, utilizzati come terreno arativo». Il termine è
stato usato, nell'epoca dei primi catasti « figurati » (Settecento,
inizio Ottocento) con significato riduttivo equivalente al termine
vigna campiva (utilizzato per esempio nel
[Catasto SERENA,
Cavorettol,
1810): vigneto con intervalli tra i filari utilizzati
come terreno arativo. Cfr. G.
PRATO,
1908, p. 72,
(
7
) Sono gli anni in cui l'amministrazione civica Sambuy
riverdisce con giardini pubblici siffatti piazze e piazzali cittadini
e in cui si riorganizza con tali criteri il Valentino.
L'analisi complessiva e l'elaborazione grafica delle tavole in originale 1:2000 è comune; sono a cura particolare di Vittorio
Defabiani i complessi P. e «B»
,
di Costanza Roggero i complessi «C», di Paolo Scarzella i complessi «S» e «T», di Maria
Grazia Vinardi i complessi «V».
195


















