
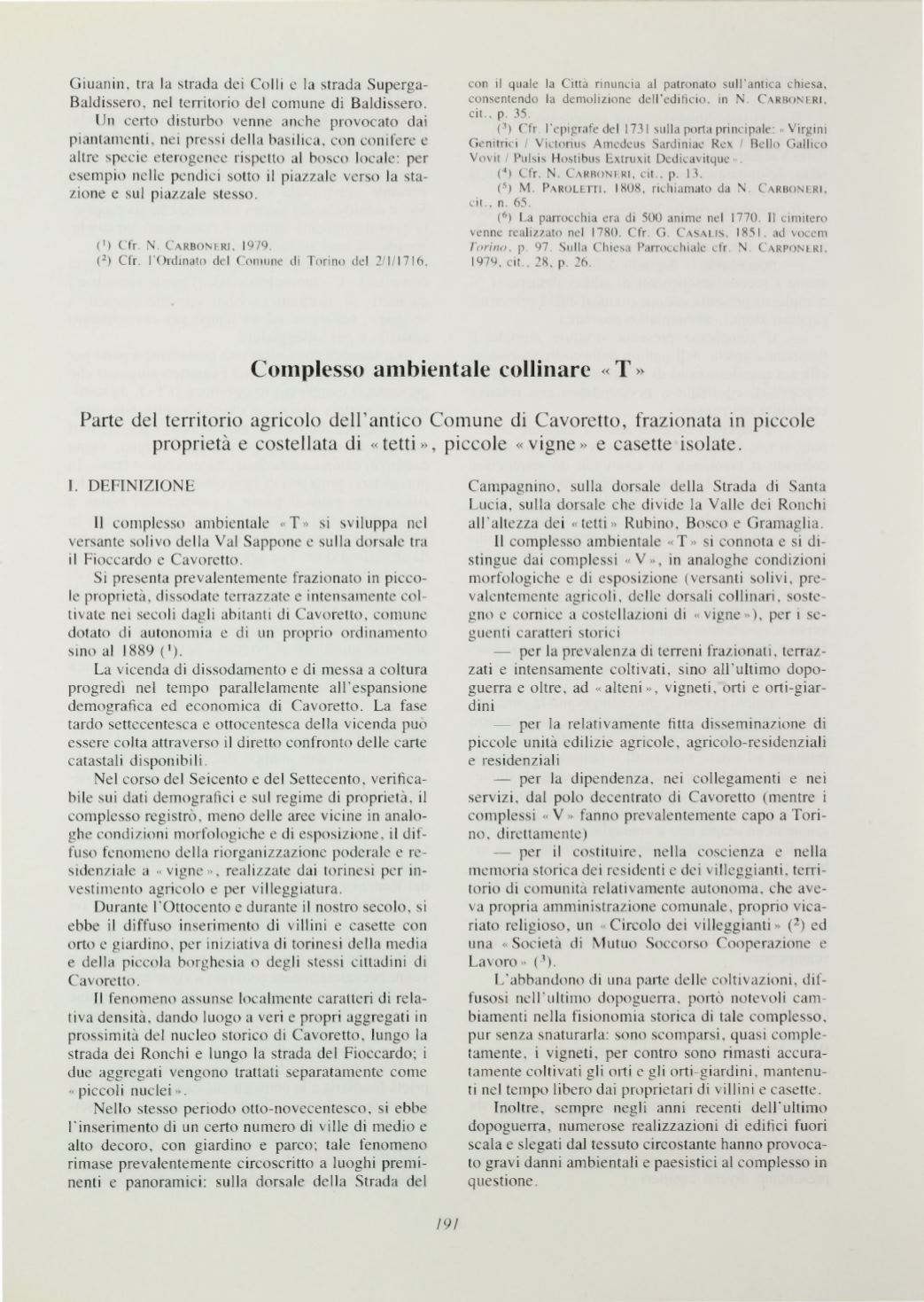
Givanin, tra la strada dei Colli e la strada Superga-
Baldissero, nel territorio del comune di Baldissero.
Un certo disturbo venne anche provocato dai
piantamenti, nei pressi della basilica, con conifere e
altre specie eterogenee rispetto al bosco locale: per
esempio nelle pendici sotto il piazzale verso la sta-
zione e sul piazzale stesso.
(1) Cfr. N.
CARBONERI,
1979.
(2) Cfr. l'Ordinato
del
Comune
di Torino del
2/1/1716.
con il quale la Città rinuncia al patronato sull'antica chiesa,
consentendo la demolizione dell'edificio, in N. CARBONERI,
cit., p. 35.
(3) Cfr. l'epigrafe del 1731 sulla porta principale: « Virgini
Genitrici / Victorius Amedeus Sardiniae Rex / Bello Gallico
Vovit / Pulsis Hostibus Extruxit Dedicavitque..
(4) Cfr. N. CARBONERI, cit., p. 13.
(5) M. PAROLETtI, 1808, richiamato da N. CARBONERI,
cit.,
n. 65.
(6) La parrocchia era di 500 anime nel 1770. Il cimitero
venne realizzato nel 1780. Cfr. G. CASALIS, 1851, ad vocem
Torino,
p. 97. Sulla Chiesa Parrocchiale cfr. N. CARBONERI,
1979,
cit.,
28, p. 26.
Complesso ambientale collinare « T »
Parte del territorio agricolo dell'antico Comune di Cavoretto, frazionata in piccole
proprietà e costellata di « tetti » , piccole «vigne» e casette isolate.
I. DEFINIZIONE
Il complesso ambientale «T» si sviluppa nel
versante solivo della Val Sappone e sulla dorsale tra
il Fioccardo e Cavoretto.
Si presenta prevalentemente frazionato in picco-
le proprietà, dissodate terrazzate e intensamente col-
tivate nei secoli dagli abitanti di Cavoretto, comune
dotato di autonomia e di un proprio ordinamento
sino al 1889
(
1
).
La vicenda di dissodamento e di messa a coltura
progredì nel tempo parallelamente all'espansione
demografica ed economica di Cavoretto. La fase
tardo settecentesca e ottocentesca della vicenda può
essere colta attraverso il diretto confronto delle carte
catastali disponibili.
Nel corso del Seicento e del Settecento, verifica-
bile sui dati demografici e sul regime di proprietà, il
complesso registrò, meno delle aree vicine in analo-
ghe condizioni morfologiche e di esposizione, il dif-
fuso fenomeno della riorganizzazione poderale e re-
sidenziale a «vigne», realizzate dai torinesi per in-
vestimento agricolo e per villeggiatura.
Durante l'Ottocento e durante il nostro secolo, si
ebbe il diffuso inserimento di villini e casette con
orto e giardino, per iniziativa di torinesi della media
e della piccola borghesia o degli stessi cittadini di
Cavoretto.
Il fenomeno assunse localmente caratteri di rela-
tiva densità, dando luogo a veri e propri aggregati in
prossimità del nucleo storico di Cavoretto, lungo la
strada dei Ronchi e lungo la strada del Fioccardo; i
due aggregati vengono trattati separatamente come
« piccoli nuclei » .
Nello stesso periodo otto-novecentesco, si ebbe
l'inserimento di un certo numero di ville di medio e
alto decoro, con giardino e parco; tale fenomeno
rimase prevalentemente circoscritto a luoghi premi-
nenti e panoramici: sulla dorsale della Strada del
Campagnino, sulla dorsale della Strada di Santa
Lucia, sulla dorsale che divide la Valle dei Ronchi
all'altezza dei «tetti» Rubino, Bosco e Gramaglia.
Il complesso ambientale «T» si connota e si di-
stingue dai complessi « V », in analoghe condizioni
morfologiche e di esposizione (versanti solivi, pre-
valentemente agricoli, delle dorsali collinari, soste-
gno e cornice a costellazioni di «vigne»), per i se-
guenti caratteri storici
- per la prevalenza di terreni frazionati, terraz-
zati e intensamente coltivati, sino all'ultimo dopo-
guerra e oltre, ad « alieni », vigneti, orti e orti-giar-
dini
- per la relativamente fitta disseminazione di
piccole unità edilizie agricole, agricolo-residenziali
e residenziali
— per la dipendenza, nei collegamenti e nei
servizi, dal polo decentrato di Cavoretto (mentre i
complessi « V » fanno prevalentemente capo a Tori-
no, direttamente)
— per il costituire, nella coscienza e nella
memoria storica dei residenti e dei villeggianti, terri-
torio di comunità relativamente autonoma, che ave-
va propria amministrazione comunale, proprio vica-
riato religioso, un « Circolo dei villeggianti
» (
2
)
ed
una « Società di Mutuo Soccorso Cooperazione e
Lavoro»
(
3
).
L'abbandono di una parte delle coltivazioni, dif-
fusosi nell'ultimo dopoguerra, portò notevoli cam-
biamenti nella fisionomia storica di tale complesso,
pur senza snaturarla: sono scomparsi, quasi comple-
tamente, i vigneti, per contro sono rimasti accura-
tamente coltivati gli orti e gli orti-giardini, mantenu-
ti nel tempo libero dai proprietari di villini e casette.
Inoltre, sempre negli anni recenti dell'ultimo
dopoguerra, numerose realizzazioni di edifici fuori
scala e slegati dal tessuto circostante hanno provoca-
to gravi danni ambientali e paesistici al complesso in
questione.
/91


















