
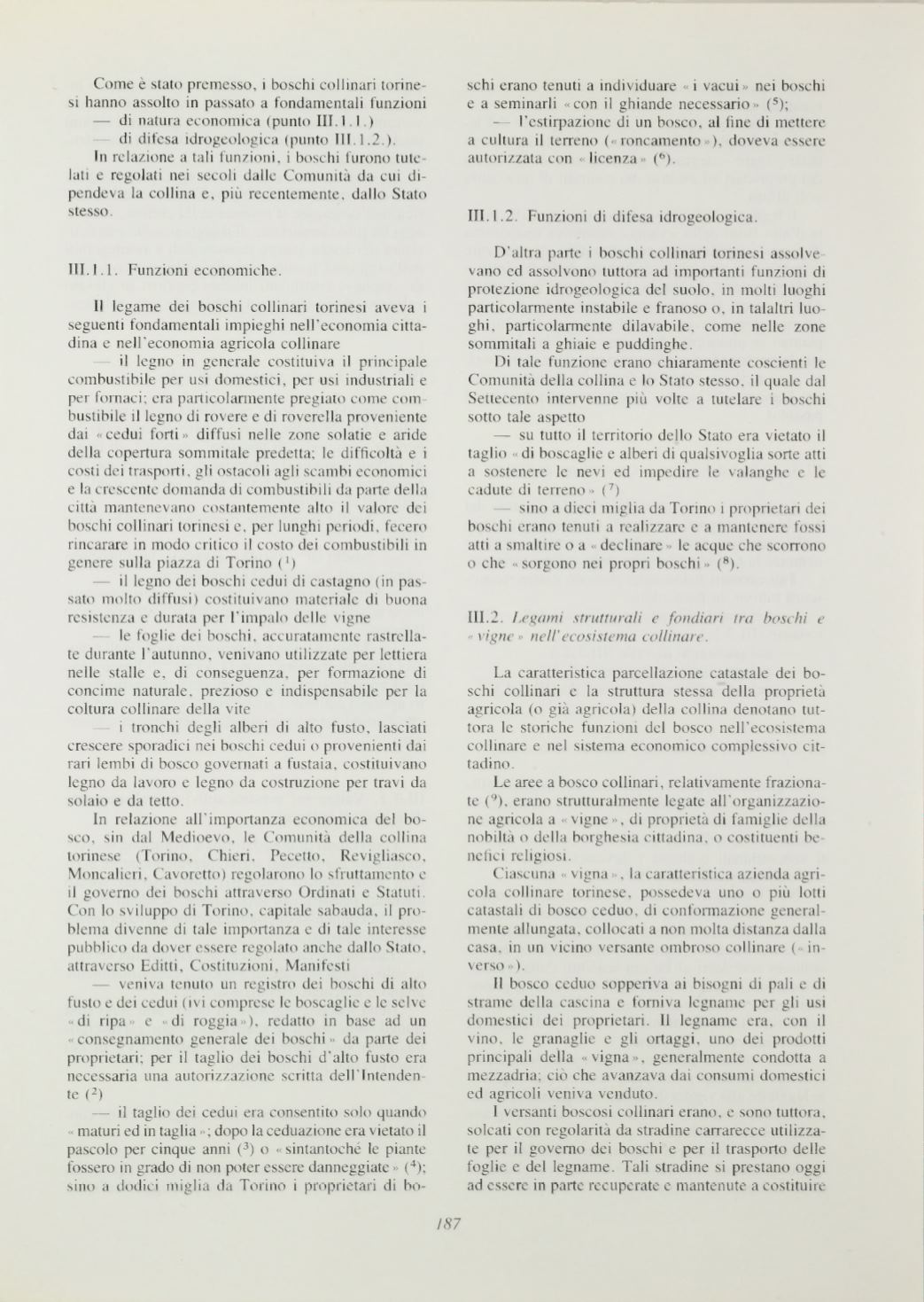
Come è stato premesso, i boschi collinari torine-
si hanno assolto in passato a fondamentali funzioni
- di natura economica (punto III.1.1.)
- di difesa idrogeologica (punto III.1.2.).
In relazione a tali funzioni, i boschi furono tute-
lati e regolati nei secoli dalle Comunità da cui di-
pendeva la collina e, più recentemente, dallo Stato
stesso.
III.1.1. Funzioni economiche.
Il legame dei boschi collinari torinesi aveva i
seguenti fondamentali impieghi nell'economia citta-
dina e nell'economia agricola collinare
- il legno in generale costituiva il principale
combustibile per usi domestici, per usi industriali e
per fornaci; era particolarmente pregiato come com-
bustibile il legno di rovere e di roverella proveniente
dai « cedui forti » diffusi nelle zone solatie e aride
della copertura sommitale predetta; le difficoltà e i
costi dei trasporti, gli ostacoli agli scambi economici
e la crescente domanda di combustibili da parte della
città mantenevano costantemente alto il valore dei
boschi collinari torinesi e, per lunghi periodi, fecero
rincarare in modo critico il costo dei combustibili in
genere sulla piazza di Torino (i)
- il legno dei boschi cedui di castagno (in pas-
sato molto diffusi) costituivano materiale di buona
resistenza e durata per l'impalo delle vigne
— le foglie dei boschi, accuratamente rastrella-
te durante l'autunno, venivano utilizzate per lettiera
nelle stalle e, di conseguenza, per formazione di
concime naturale, prezioso e indispensabile per la
coltura collinare della vite
- i tronchi degli alberi di alto fusto, lasciati
crescere sporadici nei boschi cedui o provenienti dai
rari lembi di bosco governati a fustaia, costituivano
legno da lavoro e legno da costruzione per travi da
solaio e da tetto.
In relazione all'importanza economica del bo-
sco, sin dal Medioevo, le Comunità della collina
torinese (Torino, Chieri, Pecetto, Revigliasco,
Moncalieri, Cavoretto) regolarono lo sfruttamento e
il governo dei boschi attraverso Ordinati e Statuti.
Con lo sviluppo di Torino, capitale sabauda, il pro-
blema divenne di tale importanza e di tale interesse
pubblico da dover essere regolato anche dallo Stato,
attraverso Editti, Costituzioni, Manifesti
- veniva tenuto un registro dei boschi di alto
fusto e dei cedui (ivi comprese le boscaglie e le selve
« di ripa » e « di roggia »), redatto in base ad un
consegnamento generale dei boschi » da parte dei
proprietari; per il taglio dei boschi d'alto fusto era
necessaria una autorizzazione scritta dell'Intenden-
te (
2
)
— il taglio dei cedui era consentito solo quando
« maturi ed in taglia »; dopo la ceduazione era vietato il
pascolo per cinque anni (
3
) o « sintantoché le piante
fossero in grado di non poter essere danneggiate » (
4
);
sino a dodici miglia da Torino i proprietari di bo-
schi erano tenuti a individuare « i vacui » nei boschi
e a seminarli « con il ghiande necessario » (
5
);
— l'estirpazione di un bosco, al fine di mettere
a cultura il terreno (« roncamento »), doveva essere
autorizzata con « licenza » (
6
).
III.I.2. Funzioni di difesa idrogeologica.
D'altra parte i boschi collinari torinesi assolve-
vano ed assolvono tuttora ad importanti funzioni di
protezione idrogeologica del suolo, in molti luoghi
particolarmente instabile e franoso o, in talaltri luo-
ghi, particolarmente dilavabile, come nelle zone
sommitali a ghiaie e puddinghe.
Di tale funzione erano chiaramente coscienti le
Comunità della collina e lo Stato stesso, il quale dal
Settecento intervenne più volte a tutelare i boschi
sotto tale aspetto
— su tutto il territorio dello Stato era vietato il
taglio «di boscaglie e alberi di qualsivoglia sorte atti
a sostenere le nevi ed impedire le valanghe e le
cadute di terreno» (
7
)
- sino a dieci miglia da Torino i proprietari dei
boschi erano tenuti a realizzare e a mantenere fossi
atti a smaltire o a « declinare » le acque che scorrono
o che « sorgono nei propri boschi » (
8
).
III.2.
Legami strutturali e fondiari tra boschi e
vigne nett'ecosistema collinare.
La caratteristica parcellazione catastale dei bo-
schi collinari e la struttura stessa della proprietà
agricola (o già agricola) della collina denotano tut-
tora le storiche funzioni del bosco nell'ecosistema
collinare e nel sistema economico complessivo cit-
tadino.
Le aree a bosco collinari, relativamente fraziona-
te (
9
), erano strutturalmente legate all'organizzazio-
ne agricola a « vigne », di proprietà di famiglie della
nobiltà o della borghesia cittadina, o costituenti be-
nefici religiosi.
Ciascuna «vigna» , la caratteristica azienda agri-
cola collinare torinese, possedeva uno o più lotti
catastali di bosco ceduo, di conformazione general-
mente allungata, collocati a non molta distanza dalla
casa, in un vicino versante ombroso collinare (« in-
verso »).
Il bosco ceduo sopperiva ai bisogni di pali e di
strame della cascina e forniva legname per gli usi
domestici dei proprietari. Il legname era, con il
vino, le granaglie e gli ortaggi, uno dei prodotti
principali della « vigna», generalmente condotta a
mezzadria; ciò che avanzava dai consumi domestici
ed agricoli veniva venduto.
I versanti boscosi collinari erano, e sono tuttora,
solcati con regolarità da stradine carrarecce utilizza-
te per il governo dei boschi e per il trasporto delle
foglie e del legname. Tali stradine si prestano oggi
ad essere in parte recuperate e mantenute a costituire
187


















