
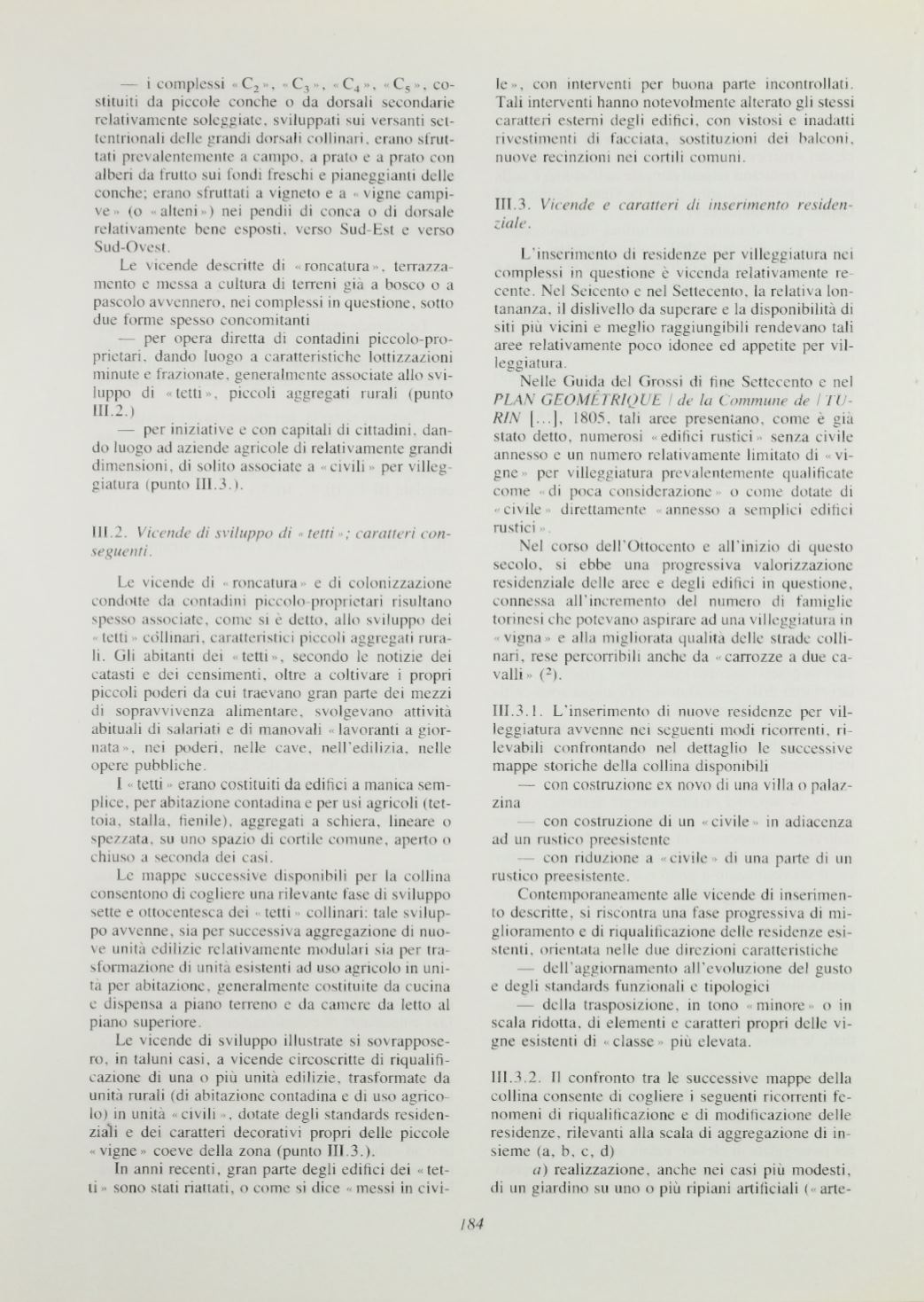
— i complessi «
C2 » , «
C
3
» , « C4 » , « C
s
» , Co-
stituiti
da piccole conche o da dorsali secondarie
relativamente soleggiate, sviluppati sui versanti set-
tentrionali delle grandi dorsali collinari, erano sfrut-
tati prevalentemente a campo, a prato e a prato con
alberi da frutto sui fondi freschi e pianeggianti delle
conche; erano sfruttati a vigneto e a « vigne campi-
ve » (o « alieni ») nei pendii di conca o di dorsale
relativamente bene esposti, verso Sud-Est e verso
Sud-Ovest.
Le vicende descritte di «roncatura», terrazza-
mento e messa a cultura di terreni già a bosco o a
pascolo avvennero, nei complessi in questione, sotto
due forme spesso concomitanti
— per opera diretta di contadini piccolo-pro-
prietari, dando luogo a caratteristiche lottizzazioni
minute e frazionate, generalmente associate allo svi-
luppo di « tetti », piccoli aggregati rurali (punto
111.2.)
- per iniziative e con capitali di cittadini, dan-
do luogo ad aziende agricole di relativamente grandi
dimensioni, di solito associate a « civili » per villeg-
giatura (punto III.3.).
III.2.
Vicende di svituppo di « tetti »; caratteri con-
seguenti.
Le vicende di « roncatura» e di colonizzazione
condotte da contadini piccolo-proprietari risultano
spesso associate, come si è detto, allo sviluppo dei
tetti » collinari, caratteristici piccoli aggregati rura-
li. Gli abitanti dei «tetti», secondo le notizie dei
catasti e dei censimenti, oltre a coltivare i propri
piccoli poderi da cui traevano gran parte dei mezzi
di sopravvivenza alimentare, svolgevano attività
abituali di salariati e di manovali « lavoranti a gior-
nata», nei poderi, nelle cave, nell'edilizia, nelle
opere pubbliche.
I « tetti » erano costituiti da edifici a manica sem-
plice, per abitazione contadina e per usi agricoli (tet-
toia, stalla, fienile), aggregati a schiera, lineare o
spezzata, su uno spazio di cortile comune, aperto o
chiuso a seconda dei casi.
Le mappe successive disponibili per la collina
consentono di cogliere una rilevante fase di sviluppo
sette e ottocentesca dei « tetti » collinari: tale svilup-
po avvenne, sia per successiva aggregazione di nuo-
ve unità edilizie relativamente modulari sia per tra-
sformazione di unità esistenti ad uso agricolo in uni-
tà per abitazione, generalmente costituite da cucina
e dispensa a piano terreno e da camere da letto al
piano superiore.
Le vicende di sviluppo illustrate si sovrappose-
ro, in taluni casi, a vicende circoscritte di riqualifi-
cazione di una o più unità edilizie, trasformate da
unità rurali (di abitazione contadina e di uso agrico-
lo) in unità « civili », dotate degli standards residen-
ziali e dei caratteri decorativi propri delle piccole
« vigne » coeve della zona (punto 111.3.).
In anni recenti, gran parte degli edifici dei «tet-
ti » sono stati riattati, o come si dice « messi in civi-
le », con interventi per buona parte incontrollati.
Tali interventi hanno notevolmente alterato gli stessi
caratteri esterni degli edifici, con vistosi e inadatti
rivestimenti di facciata, sostituzioni dei balconi,
nuove recinzioni nei cortili comuni.
III.3.
Vicende e caratteri
di
inserimento residen-
ziale.
L'inserimento di residenze per villeggiatura nei
complessi in questione è vicenda relativamente re-
cente. Nel Seicento e nel Settecento, la relativa lon-
tananza, il dislivello da superare e la disponibilità di
siti più vicini e meglio raggiungibili rendevano tali
aree relativamente poco idonee ed appetite per vil-
leggiatura.
Nelle Guida del Grossi di fine Settecento e nel
PLAN GEOMETRIQUE I de la Commune de / TU
RIN
[...], 1805, tali aree presentano, come è già
stato detto, numerosi «edifici rustici» senza civile
annesso e un numero relativamente limitato di « vi-
gne » per villeggiatura prevalentemente qualificate
come « di poca considerazione » o come dotate di
«civile» direttamente «annesso a semplici edifici
rustici» .
Nel corso dell'Ottocento e all'inizio di questo
secolo, si ebbe una progressiva valorizzazione
residenziale delle aree e degli edifici in questione,
connessa all'incremento del numero di famiglie
torinesi che potevano aspirare ad una villeggiatura in
«vigna» e alla migliorata qualità delle strade colli-
nari, rese percorribili anche da «carrozze a due ca-
valli» (
2
).
111.3. 1. L'inserimento di nuove residenze per vil-
leggiatura avvenne nei seguenti modi ricorrenti, ri-
levabili confrontando nel dettaglio le successive
mappe storiche della collina disponibili
— con costruzione ex novo di una villa o palaz-
zina
— con costruzione di un «civile» in adiacenza
ad un rustico preesistente
— con riduzione a «civile» di una parte di un
rustico preesistente.
Contemporaneamente alle vicende di inserimen-
to descritte, si riscontra una fase progressiva di mi-
glioramento e di riqualificazione delle residenze esi-
stenti, orientata nelle due direzioni caratteristiche
- dell'aggiornamento all'evoluzione del gusto
e degli standards funzionali e tipologici
- della trasposizione, in tono «minore» o in
scala ridotta, di elementi e caratteri propri delle vi-
gne esistenti di «classe» più elevata.
II1.3.2. Il confronto tra le successive mappe della
collina consente di cogliere i seguenti ricorrenti fe-
nomeni di riqualificazione e di modificazione delle
residenze, rilevanti alla scala di aggregazione di in-
sieme (a, b, c, d)
a)
realizzazione, anche nei casi più modesti,
di un giardino su uno o più ripiani artificiali (« arte-
/84


















