
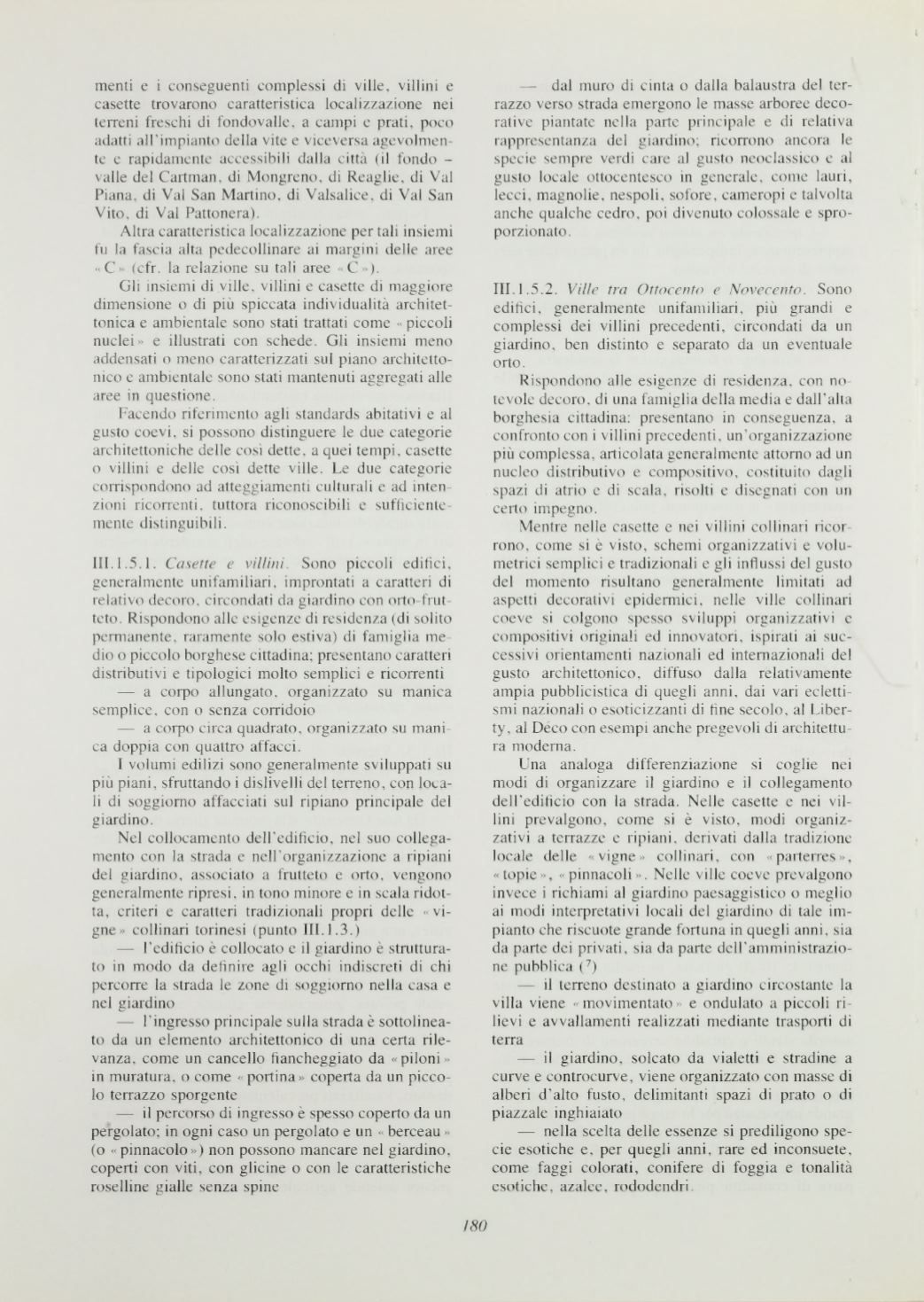
menti e i conseguenti complessi di ville, villini e
casette trovarono caratteristica localizzazione nei
terreni freschi di fondovalle, a campi e prati, poco
adatti all'impianto della vite e viceversa agevolmen-
te e rapidamente accessibili dalla città (il fondo –
valle del Cartman, di Mongreno, di Reaglie, di Val
Piana, di Val San Ma
rt
ino, di Valsalice, di Val San
Vito, di Val Pattonera).
Altra caratteristica localizzazione per tali insiemi
fu la fascia alta pedecollinare ai margini delle aree
«C» (cfr. la relazione su tali aree «C»).
Gli insiemi di ville, villini e casette di maggiore
dimensione o di più spiccata individualità architet-
tonica e ambientale sono stati trattati come « piccoli
nuclei » e illustrati con schede. Gli insiemi meno
addensati o meno caratterizzati sul piano architetto-
nico e ambientale sono stati mantenuti aggregati alle
aree in questione.
Facendo riferimento agli standards abitativi e al
gusto coevi, si possono distinguere le due categorie
architettoniche delle così dette, a quei tempi, casette
o villini e delle così dette ville. Le due categorie
corrispondono ad atteggiamenti culturali e ad inten-
zioni ricorrenti, tuttora riconoscibili e sufficiente-
mente distinguibili.
III. 1.5.1.
Casette e villini.
Sono piccoli edifici,
generalmente unifamiliari, improntati a caratteri di
relativo decoro, circondati da giardino con orto-frut-
teto. Rispondono alle esigenze di residenza (di solito
permanente, raramente solo estiva) di famiglia me-
dio o piccolo borghese cittadina; presentano caratteri
distributivi e tipologici molto semplici e ricorrenti
- a corpo allungato, organizzato su manica
semplice, con o senza corridoio
- a corpo circa quadrato, organizzato su mani-
ca doppia con quattro affacci.
I volumi edilizi sono generalmente sviluppati su
più piani, sfruttando i dislivelli del terreno, con loLa-
li di soggiorno affacciati sul ripiano principale del
giardino.
Nel collocamento dell'edificio, nel suo collega-
mento con la strada e nell'organizzazione a ripiani
del giardino, associato a frutteto e orto, vengono
generalmente ripresi, in tono minore e in scala ridot-
ta, criteri e caratteri tradizionali propri delle « vi-
gne» collinari torinesi (punto 111.1 .3.)
— l'edificio è collocato e il giardino è struttura-
to in modo da definire agli occhi indiscreti di chi
percorre la strada le zone di soggiorno nella casa e
nel giardino
- l'ingresso principale sulla strada è sottolinea-
to da un elemento architettonico di una certa rile-
vanza, come un cancello fiancheggiato da «piloni»
in muratura, o come «portina» coperta da un picco-
lo terrazzo sporgente
- il percorso di ingresso è spesso coperto da un
pergolato; in ogni caso un pergolato e un « berceau »
(o « pinnacolo ») non possono mancare nel giardino,
coperti con viti, con glicine o con le caratteristiche
roselline gialle senza spine
— dal muro di cinta o dalla balaustra del ter-
razzo verso strada emergono le masse arboree deco-
rative piantate nella parte principale e di relativa
rappresentanza del giardino; ricorrono ancora le
specie sempre verdi care al gusto neoclassico e al
gusto locale ottocentesco in generale, come lauri,
lecci, magnolie, nespoli, sofore, cameropi e talvolta
anche qualche cedro, poi divenuto colossale e spro-
porzionato.
I1I.1.5.2.
Vilte tra Ottocento e Novecento.
Sono
edifici, generalmente unifamiliari, più grandi e
complessi dei villini precedenti, circondati da un
giardino, ben distinto e separato da un eventuale
orto.
Rispondono alle esigenze di residenza, con no-
tevole decoro, di una famiglia della media e dall'alta
borghesia cittadina: presentano in conseguenza, a
confronto con i villini precedenti, un'organizzazione
più complessa, articolata generalmente attorno ad un
nucleo distributivo e compositivo, costituito dagli
spazi di atrio e di scala, risolti e disegnati con un
certo impegno.
Mentre nelle casette e nei villini collinari ricor-
rono, come si è visto, schemi organizzativi e volu-
metrici semplici e tradizionali e gli influssi del gusto
del momento risultano generalmente limitati ad
aspetti decorativi epidermici, nelle ville collinari
coeve si colgono spesso sviluppi organizzativi e
compositivi originali ed innovatori, ispirati ai suc-
cessivi orientamenti nazionali ed internazionali del
gusto architettonico, diffuso dalla relativamente
ampia pubblicistica di quegli anni, dai vari ecletti-
smi nazionali o esoticizzanti di fine secolo, al Liber-
ty, al Déco con esempi anche pregevoli di architettu-
ra moderna.
Una analoga differenziazione si coglie nei
modi di organizzare il giardino e il collegamento
dell'edificio con la strada. Nelle casette e nei vil-
lini prevalgono, come si è visto, modi organiz-
zativi a terrazze e ripiani, derivati dalla tradizione
locale delle « vigne » collinari, con « parterres »,
topie », « pinnacoli » . Nelle ville coeve prevalgono
invece i richiami al giardino paesaggistico o meglio
ai modi interpretativi locali del giardino di tale im-
pianto che riscuote grande fortuna in quegli anni, sia
da parte dei privati, sia da parte dell'amministrazio-
ne pubblica (
7
)
- il terreno destinato a giardino circostante la
villa viene «movimentato» e ondulato a piccoli ri-
lievi e avvallamenti realizzati mediante trasporti di
terra
— il giardino, solcato da vialetti e stradine a
curve e controcurve, viene organizzato con masse di
alberi d'alto fusto, delimitanti spazi di prato o di
piazzale inghiaiato
— nella scelta delle essenze si prediligono spe-
cie esotiche e, per quegli anni, rare ed inconsuete,
come faggi colorati, conifere di foggia e tonalità
esotiche, azalee, rododendri.
1
180


















