
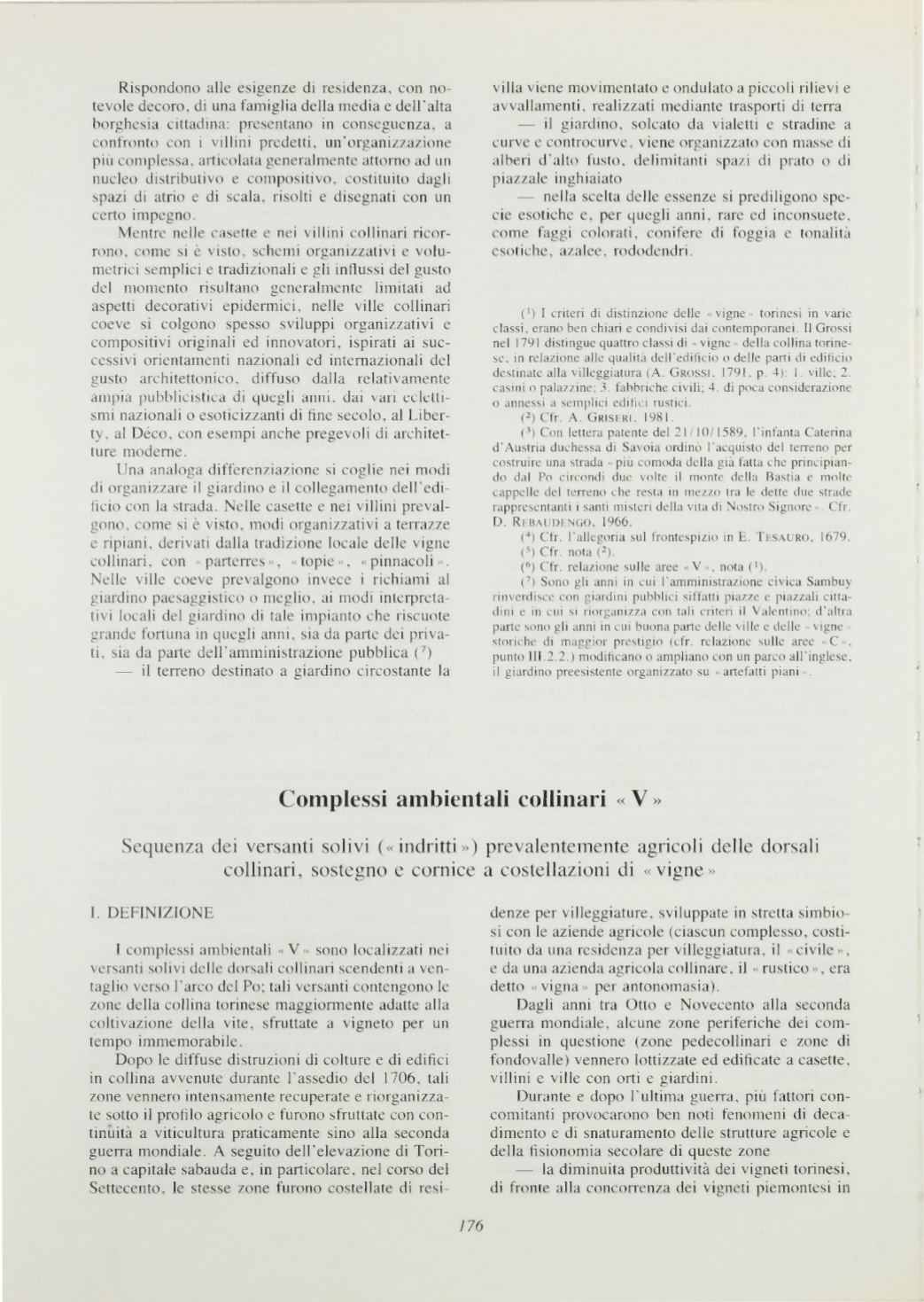
Rispondono alle esigenze di residenza, con no-
tevole decoro, di una famiglia della media e dell'alta
borghesia cittadina: presentano in conseguenza, a
confronto con i villini predetti, un'organizzazione
più complessa, articolata generalmente attorno ad un
nucleo distributivo e compositivo, costituito dagli
spazi di atrio e di scala, risolti e disegnati con un
certo impegno.
Mentre nelle casette e nei villini collinari ricor-
rono, come si è visto, schemi organizzativi e volu-
metrici semplici e tradizionali e gli influssi del gusto
del momento risultano generalmente limitati ad
aspetti decorativi epidermici, nelle ville collinari
coeve
si
colgono spesso sviluppi organizzativi e
compositivi originali ed innovatori, ispirati ai suc-
cessivi orientamenti nazionali ed internazionali del
gusto architettonico, diffuso dalla relativamente
ampia pubblicistica di quegli anni, dai vari ecletti-
smi nazionali o esoticizzanti di fine secolo, al Liber-
ty, al Déco, con esempi anche pregevoli di architet-
ture moderne.
Una analoga differenziazione si coglie nei modi
di organizzare il giardino e il collegamento dell'edi-
ficio con la strada. Nelle casette e nei villini preval-
gono, come si
è
visto, modi organizzativi a terrazze
e ripiani, derivati dalla tradizione locale delle vigne
collinari, con « parterres », « topie » , « pinnacoli » .
Nelle ville coeve prevalgono invece i richiami al
giardino paesaggistico o meglio, ai modi interpreta-
tivi locali del giardino di tale impianto che riscuote
grande fortuna in quegli anni, sia da parte dei priva-
ti, sia da parte dell'amministrazione pubblica
(
7
)
il terreno destinato a giardino circostante la
villa viene movimentato e ondulato a piccoli rilievi e
avvallamenti, realizzati mediante trasporti di terra
— il giardino, solcato da vialetti e stradine a
curve e controcurve, viene organizzato con masse di
alberi d'alto fusto, delimitanti spazi di prato o di
piazzale inghiaiato
- nella scelta delle essenze si prediligono spe-
cie esotiche e, per quegli anni, rare ed inconsuete,
come faggi colorati, conifere di foggia e tonalità
esotiche, azalee, rododendri.
(') I criteri di distinzione delle « vigne » torinesi in varie
classi, erano ben chiari e condivisi dai contemporanei. Il Grossi
nel 1791 distingue quattro classi di « vigne » della collina torine-
se, in relazione alle qualità dell'edificio o delle parti di edificio
destinate alla villeggiatura (A.
GRossI,
1791, p. 4): 1. ville; 2.
casini o palazzine; 3. fabbriche civili; 4. di poca considerazione
o annessi a semplici edifici rustici.
(2) Cfr. A.
GRIsERl.
1981.
(3) Con lettera patente del 21/10/1589, l'infanta Caterina
d'Austria duchessa di Savoia ordinò l'acquisto del terreno per
costruire una strada .. più comoda della già fatta che principian-
do dal Po circondi due volte il monte della Bastia e molte
cappelle del terreno che resta in mezzo tra le dette due strade
rappresentanti i santi misteri della vita di Nostro Signore». Cfr.
D.
REBAUDENGO,
1966.
(4) Cfr. l'allegoria sul frontespizio in E.
TESAURO,
1679.
(5) Cfr. nota (
2
).
(6) Cfr. relazione sulle aree » V», nota (
1
).
(7) Sono gli anni in cui l'amministrazione civica Sambuy
rinverdisce con giardini pubblici siffatti piazze e piazzali citta-
dini e in cui si riorganizza con tali criteri il Valentino; d'altra
parte sono gli anni in cui buona parte delle ville e delle » vigne»
storiche di maggior prestigio (cfr. relazione sulle aree » C»,
punto II1.2.2.) modificano o ampliano con un parco all'inglese,
il giardino preesistente organizzato su «artefatti piani».
Complessi ambientali collinari « V »
Sequenza dei versanti solivi (« indritti ») prevalentemente agricoli delle dorsali
collinari, sostegno e cornice a costellazioni di « vigne»
I. DEFINIZIONE
I complessi ambientali « V » sono localizzati nei
versanti solivi delle dorsali collinari scendenti a ven-
taglio verso l'arco del Po; tali versanti contengono le
zone della collina torinese maggiormente adatte alla
coltivazione della vite, sfruttate a vigneto per un
tempo immemorabile.
Dopo le diffuse distruzioni di colture e di edifici
in collina avvenute durante l'assedio del 1706, tali
zone vennero intensamente recuperate e riorganizza-
te sotto il profilo agricolo e furono sfruttate con con-
tiniiità a viticultura praticamente sino alla seconda
guerra mondiale. A seguito dell'elevazione di Tori-
no a capitale sabauda e,
in
particolare, nel corso del
Settecento, le stesse zone furono costellate di resi-
denze per villeggiature, sviluppate in stretta simbio-
si con le aziende agricole (ciascun complesso, costi-
tuito da una residenza per villeggiatura, il «
civile » ,
e da una azienda agricola collinare, il «rustico», era
detto » vigna » per antonomasia).
Dagli anni tra Otto e Novecento alla seconda
guerra mondiale, alcune zone periferiche dei com-
plessi in questione (zone pedecollinari e zone di
fondovalle) vennero lottizzate ed edificate a casette,
villini e ville con orti e giardini.
Durante e dopo l'ultima guerra, più fattori con-
comitanti provocarono ben noti fenomeni di deca-
dimento e di snaturamento delle strutture agricole e
della fisionomia secolare di queste zone
- la diminuita produttività dei vigneti torinesi,
di fronte alla concorrenza dei vigneti piemontesi in
176


















