
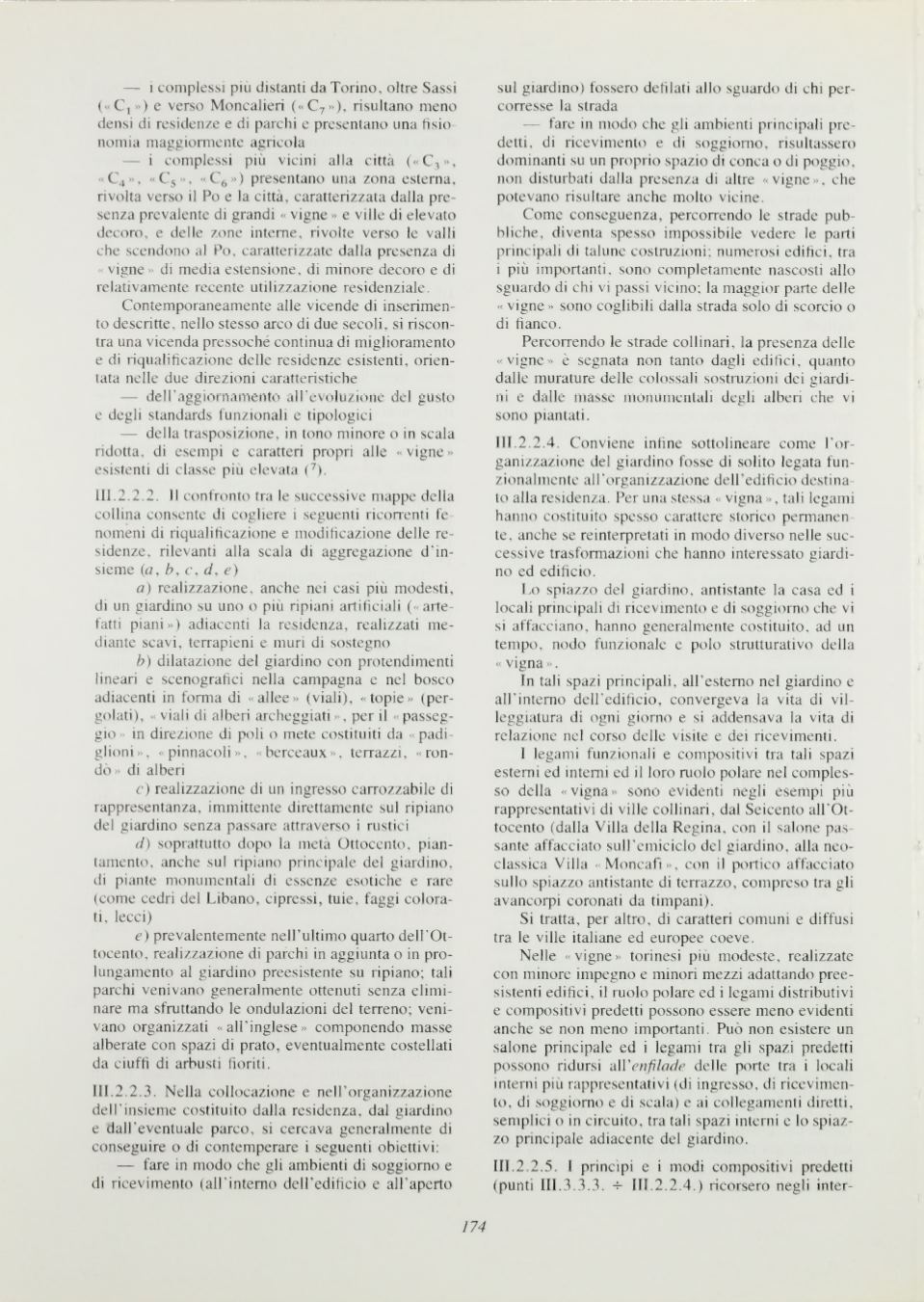
— i complessi più distanti da Torino, oltre Sassi
(« C, ») e verso Moncalieri
(« C7 »),
risultano meno
densi di residenze e di parchi e presentano una fisio-
nomia maggiormente agricola
— i complessi più vicini alla città (« C
3
»,
C
4
», « C
s
», « C
6
»)
presentano una zona esterna,
rivolta verso il Po e la città, caratterizzata dalla pre-
senza prevalente di grandi «vigne» e ville di elevato
decoro, e delle zone interne, rivolte verso le valli
che scendono al Po, caratterizzate dalla presenza di
vigne » di media estensione, di minore decoro e di
relativamente recente utilizzazione residenziale.
Contemporaneamente alle vicende di inserimen-
to descritte, nello stesso arco di due secoli, si riscon-
tra una vicenda pressoché continua di miglioramento
e di riqualificazione delle residenze esistenti, orien-
tata nelle due direzioni caratteristiche
- dell'aggiornamento all'evoluzione del gusto
e degli standards funzionali e tipologici
- della trasposizione, in tono minore o in scala
ridotta, di esempi e caratteri propri alle « vigne »
esistenti di classe più elevata (
7
).
I11.2.2.2. Il confronto tra le successive mappe della
collina consente di cogliere i seguenti ricorrenti fe-
nomeni di riqualificazione e modificazione delle re-
sidenze, rilevanti alla scala di aggregazione d'in-
sieme
(a, b, c, d, e)
a) realizzazione, anche nei casi più modesti,
di un giardino su uno o più ripiani artificiali (« arte-
fatti piani ») adiacenti la residenza, realizzati me-
diante scavi, terrapieni e muri di sostegno
b) dilatazione del giardino con protendimenti
lineari e scenografici nella campagna e nel bosco
adiacenti in forma di « allee » (viali), « topie » (per-
golati), « viali di alberi archeggiati », per il « passeg-
gio » in direzione di poli o mete costituiti da « padi-
glioni», «pinnacoli», «berceaux», terrazzi, «ron-
dò » di alberi
c) realizzazione di un ingresso carrozzabile di
rappresentanza, immittente direttamente sul ripiano
del giardino senza passare attraverso i rustici
d) soprattutto dopo la metà Ottocento, pian-
tamento, anche sul ripiano principale del giardino,
di piante monumentali di essenze esotiche e rare
(come cedri del Libano, cipressi, tuie, faggi colora-
ti, lecci)
e) prevalentemente nell'ultimo quarto dell'Ot-
tocento, realizzazione di parchi in aggiunta o in pro-
lungamento al giardino preesistente su ripiano; tali
parchi venivano generalmente ottenuti senza elimi-
nare ma sfruttando le ondulazioni del terreno; veni-
vano organizzati « all'inglese » componendo masse
alberate con spazi di prato, eventualmente costellati
da ciuffi di arbusti fioriti.
I1L2.2.3. Nella collocazione e nell'organizzazione
dell'insieme costituito dalla residenza, dal giardino
e dall'eventuale parco, si cercava generalmente di
conseguire o di contemperare i seguenti obiettivi:
— fare in modo che gli ambienti di soggiorno e
di ricevimento (all'interno dell'edificio e all'aperto
sul giardino) fossero defilati allo sguardo di chi per-
corresse la strada
— fare in modo che gli ambienti principali pre-
detti, di ricevimento e di soggiorno, risultassero
dominanti su un proprio spazio di conca o di poggio,
non disturbati dalla presenza di altre «vigne», che
potevano risultare anche molto vicine.
Come conseguenza, percorrendo le strade pub-
bliche, diventa spesso impossibile vedere le parti
principali di talune costruzioni; numerosi edifici, tra
i più importanti, sono completamente nascosti allo
sguardo di chi vi passi vicino; la maggior parte delle
vigne» sono coglibili dalla strada solo di scorcio o
di fianco.
Percorrendo le strade collinari, la presenza delle
vigne » è segnata non tanto dagli edifici, quanto
dalle murature delle colossali sostruzioni dei giardi-
ni e dalle masse monumentali degli alberi che vi
sono piantati.
III.2.2.4. Conviene infine sottolineare come l'or-
ganizzazione del giardino fosse di solito legata fun-
zionalmente all'organizzazione dell'edificio destina-
to alla residenza. Per una stessa «vigna», tali legami
hanno costituito spesso carattere storico permanen-
te, anche se reinterpretati in modo diverso nelle suc-
cessive trasformazioni che hanno interessato giardi-
no ed edificio.
Lo spiazzo del giardino, antistante la casa ed i
locali principali di ricevimento e di soggiorno che vi
si affacciano, hanno generalmente costituito, ad un
tempo, nodo funzionale e polo strutturativo della
vigna».
In tali spazi principali, all'esterno nel giardino e
all'interno dell'edificio, convergeva la vita di vil-
leggiatura di ogni giorno e si addensava la vita di
relazione nel corso delle visite e dei ricevimenti.
I legami funzionali e compositivi tra tali spazi
esterni ed interni ed il loro ruolo polare nel comples-
so della «vigna» sono evidenti negli esempi più
rappresentativi di ville collinari, dal Seicento all'Ot-
tocento (dalla Villa della Regina, con il salone pas-
sante affacciato sull'emiciclo del giardino, alla neo-
classica Villa « Moncafi »
,
con il portico affacciato
sullo spiazzo antistante di terrazzo, compreso tra gli
avancorpi coronati da timpani).
Si tratta, per altro, di caratteri comuni e diffusi
tra le ville italiane ed europee coeve.
Nelle « vigne » torinesi più modeste, realizzate
con minore impegno e minori mezzi adattando pree-
sistenti edifici, il ruolo polare ed i legami distributivi
e compositivi predetti possono essere meno evidenti
anche se non meno importanti. Può non esistere un
salone principale ed i legami tra gli spazi predetti
possono ridursi
all'enfilade
delle porte tra i locali
interni più rappresentativi (di ingresso, di ricevimen-
to, di soggiorno e di scala) e ai collegamenti diretti,
semplici o in circuito, tra tali spazi interni e lo spiaz-
zo principale adiacente del giardino.
1II.2.2.5. I principi e i modi compositivi predetti
(punti III .3.3.3. - IlI.2.2.4.) ricorsero negli inter-
174


















