
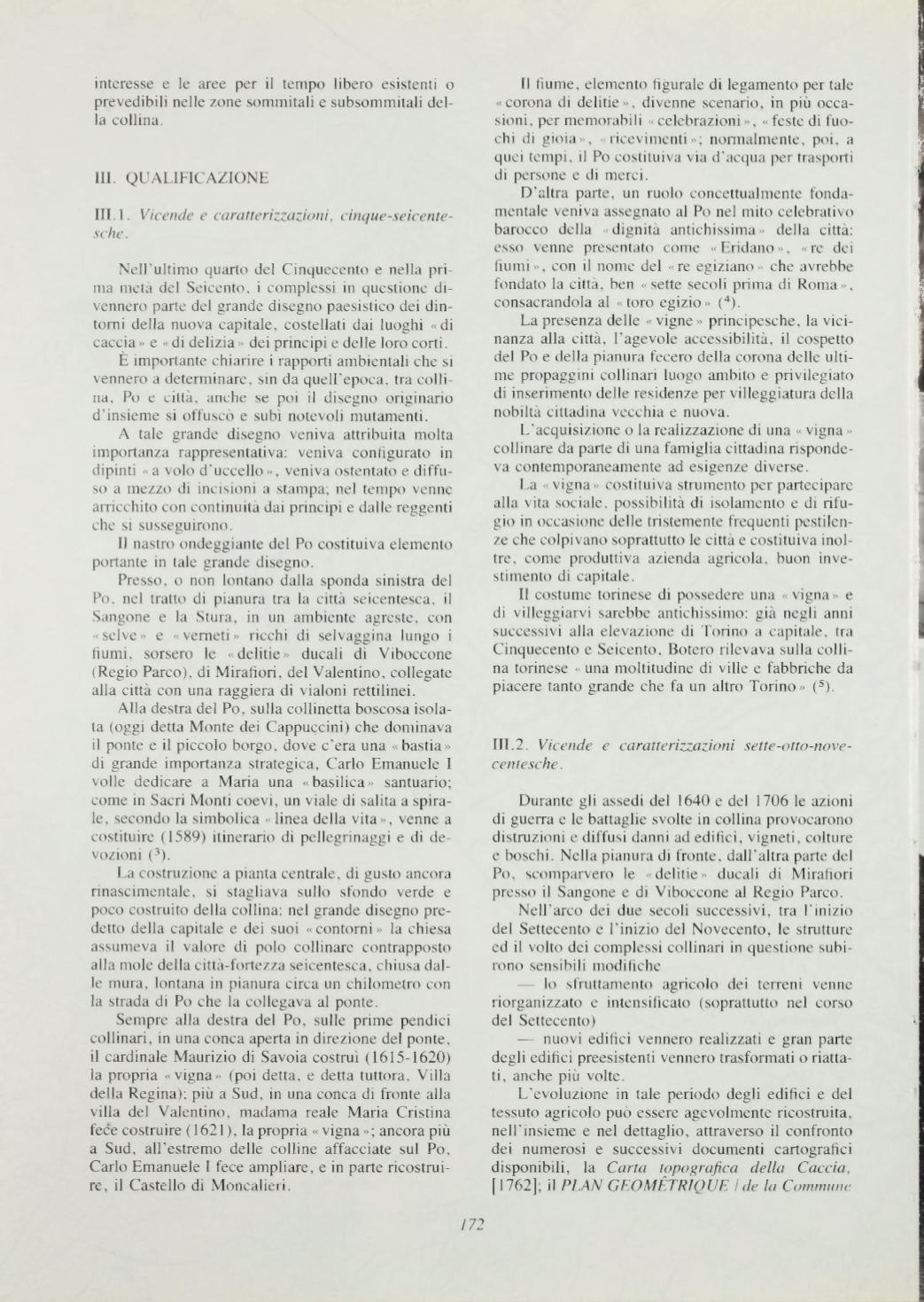
interesse e le aree per il tempo libero esistenti o
prevedibili nelle zone sommitali e subsommitali del-
la collina.
III. QUALIFICAZIONE
III.1.
Vicende e caratterizzazioni, cinque-seicente-
sche.
Nell'ultimo quarto del Cinquecento e nella pri-
ma metà del Seicento, i complessi in questione di-
vennero parte del grande disegno paesistico dei din-
torni della nuova capitale, costellati dai luoghi «di
caccia » e « di delizia » dei principi e delle loro corti.
È importante chiarire i rapporti ambientali che si
vennero a determinare, sin da quell'epoca, tra colli-
na, Po e città, anche se poi il disegno originario
d'insieme
si
offuscò e subì notevoli mutamenti.
A tale grande disegno veniva attribuita molta
importanza rappresentativa: veniva configurato in
dipinti « a volo d'uccello » , veniva ostentato e diffu-
so a mezzo di incisioni a stampa; nel tempo venne
arricchito con continuità dai principi e dalle reggenti
che si susseguirono.
Il nastro ondeggiante del Po costituiva elemento
portante in tale grande disegno.
Presso, o non lontano dalla sponda sinistra del
Po, nel tratto di pianura tra la città seicentesca, il
Sangone e la Stura, in un ambiente agreste, con
« selve » e « verneti » ricchi di selvaggina lungo i
fiumi, sorsero le «delitie» ducali di Viboccone
(Regio Parco), di Mirafiori, del Valentino, collegate
alla città con una raggiera di vialoni rettilinei.
Alla destra del Po, sulla collinetta boscosa isola-
ta (oggi detta Monte dei Cappuccini) che dominava
il ponte e
il
piccolo borgo, dove c'era una «bastia»
di grande importanza strategica, Carlo Emanuele I
volle dedicare a Maria una «basilica» santuario;
come in Sacri Monti coevi, un viale di salita a spira-
le, secondo la simbolica « linea della
vita»,
venne a
costituire (1589) itinerario di pellegrinaggi e di de-
vozioni (
3
).
La costruzione a pianta centrale, di gusto ancora
rinascimentale, si stagliava sullo sfondo verde e
poco costruito della collina: nel grande disegno pre-
detto della capitale e dei suoi «contorni» la chiesa
assumeva il valore di polo collinare contrapposto
alla mole della città-fortezza seicentesca, chiusa dal-
le mura, lontana in pianura circa un chilometro con
la strada di Po che la collegava al ponte.
Sempre alla destra del Po, sulle prime pendici
collinari, in una conca aperta
in
direzione del ponte,
il cardinale Maurizio di Savoia costruì (1615-1620)
la propria «vigna» (poi detta, e detta tuttora, Villa
della Regina); più a Sud, in una conca di fronte alla
villa del Valentino, madama reale Maria Cristina
fece costruire (1621), la propria «vigna»; ancora più
a Sud, all'estremo delle colline affacciate sul Po,
Carlo Emanuele I fece ampliare, e in parte ricostrui-
re, il Castello di Moncalieri.
II fiume, elemento figurale di legamento per tale
« corona di delitie », divenne scenario, in più occa-
sioni, per memorabili «celebrazioni», «feste di fuo-
chi di gioia», «ricevimenti» ; normalmente, poi, a
quei tempi, il Po costituiva via d'acqua per trasporti
di persone e di merci.
D'altra parte, un ruolo concettualmente fonda-
mentale veniva assegnato al Po nel mito celebrativo
barocco della «dignità antichissima » della città:
esso venne presentato come « Eridano », « re dei
fiumi », con il nome del « re egiziano » che avrebbe
fondato la città, ben « sette secoli prima di Roma »,
consacrandola al «toro egizio» (
4
).
La presenza delle « vigne » principesche, la vici-
nanza alla città, l'agevole accessibilità, il cospetto
del Po e della pianura fecero della corona delle ulti-
me propaggini collinari luogo ambito e privilegiato
di inserimento delle residenze per villeggiatura della
nobiltà cittadina vecchia e nuova.
L'acquisizione
o la realizzazione di una «vigna»
collinare da parte di una famiglia cittadina risponde-
va contemporaneamente ad esigenze diverse.
La «vigna» costituiva strumento per partecipare
alla vita sociale, possibilità di isolamento e di rifu-
gio in occasione delle tristemente frequenti pestilen-
ze che colpivano soprattutto le città e costituiva inol-
tre, come produttiva azienda agricola, buon inve-
stimento di capitale.
Il costume torinese di possedere una « vigna»
e
di
villeggiarvi sarebbe antichissimo: già negli anni
successivi alla elevazione di Torino a capitale, tra
Cinquecento e Seicento, Botero rilevava sulla colli-
na torinese « una moltitudine di ville e fabbriche da
piacere tanto grande che fa un altro Torino» (
5
).
I11.2.
Vicende e caratterizzazioni sette-otto-nove-
centesche.
Durante gli assedi del 1640 e del 1706 le azioni
di guerra e le battaglie svolte in collina provocarono
distruzioni e diffusi danni ad edifici, vigneti, colture
e boschi. Nella pianura di fronte, dall'altra parte del
Po, scomparvero le « delitie » ducali di Mirafiori
presso il Sangone e di Viboccone al Regio Parco.
Nell'arco dei due secoli successivi, tra l'inizio
del Settecento e l'inizio del Novecento, le strutture
ed il volto dei complessi collinari in questione subi-
rono sensibili modifiche
- lo sfruttamento agricolo dei terreni venne
riorganizzato e intensificato (soprattutto nel corso
del Settecento)
- nuovi edifici vennero realizzati e gran parte
degli edifici preesistenti vennero trasformati o riatta-
ti, anche più volte.
L'evoluzione in tale periodo degli edifici e del
tessuto agricolo può essere agevolmente ricostruita,
nell'insieme e nel dettaglio, attraverso il confronto
dei numerosi e successivi documenti cartografici
disponibili, la
Carta topografica detta Caccia,
[1762]; il
PLAN GEOMETRIQUE I de ta Commune
172


















