
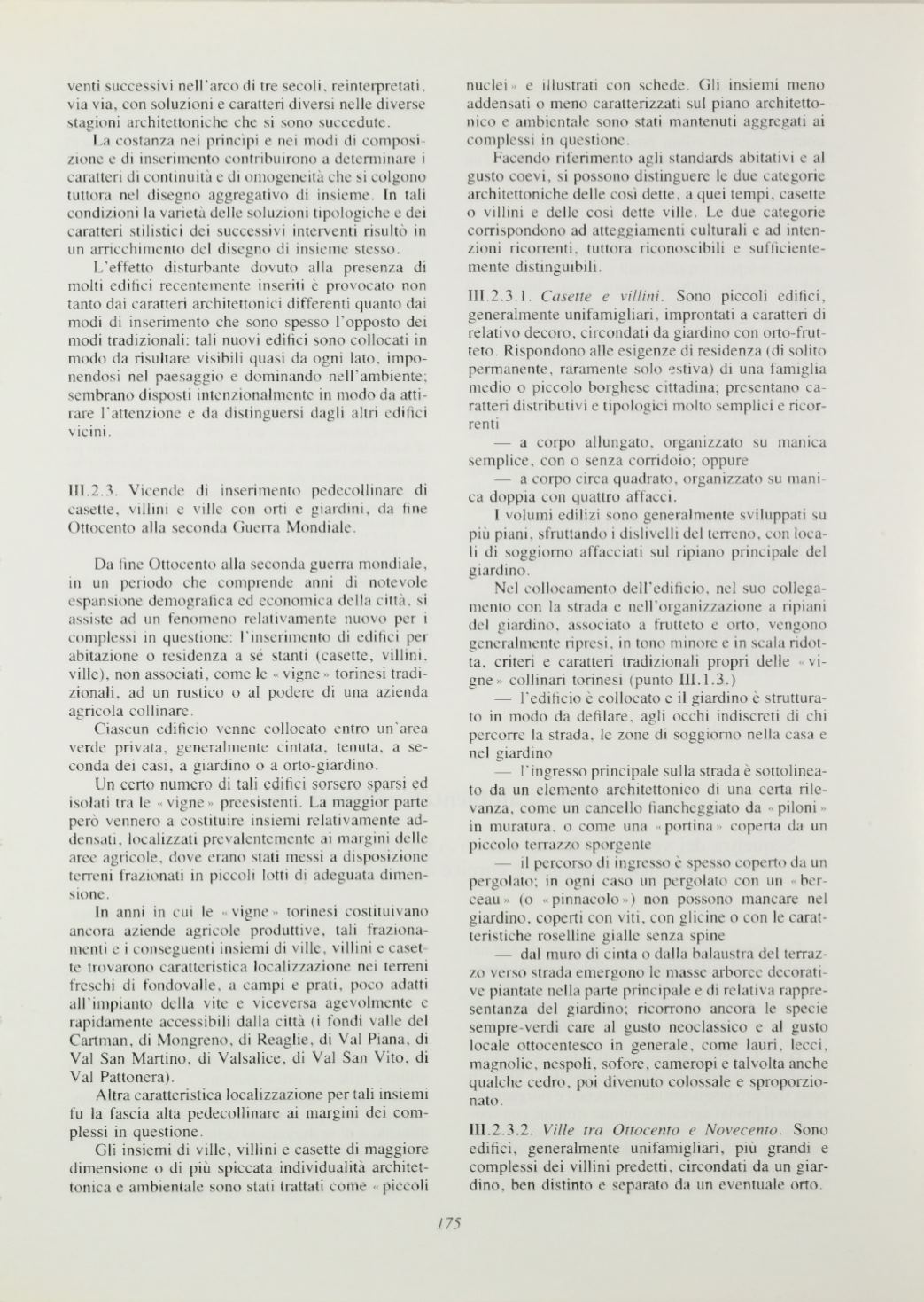
venti successivi nell'arco di tre secoli, reinterpretati,
via via, con soluzioni e caratteri diversi nelle diverse
stagioni architettoniche che si sono succedute.
La costanza nei princìpi e nei modi di composi-
zione e di inserimento contribuirono a determinare i
caratteri di continuità e di omogeneità che si colgono
tuttora nel disegno aggregativo di insieme. In tali
condizioni la varietà delle soluzioni tipologiche e dei
caratteri stilistici dei successivi interventi risultò in
un arricchimento del disegno di insieme stesso.
L'effetto disturbante dovuto alla presenza di
molti edifici recentemente inseriti è provocato non
tanto dai caratteri architettonici differenti quanto dai
modi di inserimento che sono spesso l'opposto dei
modi tradizionali: tali nuovi edifici sono collocati in
modo da risultare visibili quasi da ogni lato, impo-
nendosi nel paesaggio e dominando nell'ambiente;
sembrano disposti intenzionalmente in modo da atti-
rare l'attenzione e da distinguersi dagli altri edifici
vicini.
I1L2.3. Vicende di inserimento pedecollinare di
casette, villini e ville con orti e giardini, da fine
Ottocento alla seconda Guerra Mondiale.
Da fine Ottocento alla seconda guerra mondiale,
in un periodo che comprende anni di notevole
espansione demografica ed economica della città, si
assiste ad un fenomeno relativamente nuovo per i
complessi in questione: l'inserimento di edifici per
abitazione o residenza a sé stanti (casette, villini,
ville), non associati, come le « vigne » torinesi tradi-
zionali, ad un rustico o al podere di una azienda
agricola collinare.
Ciascun edificio venne collocato entro un'area
verde privata, generalmente cintata, tenuta, a se-
conda dei casi, a giardino o a orto-giardino.
Un certo numero di tali edifici sorsero sparsi ed
isolati tra le « vigne » preesistenti. La maggior parte
però vennero a costituire insiemi relativamente ad-
densati, localizzati prevalentemente ai margini delle
aree agricole, dove erano stati messi a disposizione
terreni frazionati in piccoli lotti di adeguata dimen-
sione.
In anni in cui le «vigne» torinesi costituivano
ancora aziende agricole produttive, tali fraziona-
menti e i conseguenti insiemi di ville, villini e caset-
te trovarono caratteristica localizzazione nei terreni
freschi di fondovalle, a campi e prati, poco adatti
all'impianto della vite e viceversa agevolmente e
rapidamente accessibili dalla città (i fondi valle del
Cartman, di Mongreno, di Reaglie, di Val Piana, di
Val San Ma
rt
ino, di Valsalice, di Val San Vito, di
Val Pattonera).
Altra caratteristica localizzazione per tali insiemi
fu la fascia alta pedecollinare ai margini dei com-
plessi in questione.
Gli insiemi di ville, villini e casette di maggiore
dimensione o di più spiccata individualità architet-
tonica e ambientale sono stati trattati come « piccoli
nuclei» e illustrati con schede. Gli insiemi meno
addensati o meno caratterizzati sul piano architetto-
nico e ambientale sono stati mantenuti aggregati ai
complessi in questione.
Facendo riferimento agli standards abitativi e al
gusto coevi, si possono distinguere le due categorie
architettoniche delle così dette, a quei tempi, casette
o villini e delle così dette ville. Le due categorie
corrispondono ad atteggiamenti culturali e ad inten-
zioni ricorrenti, tuttora riconoscibili e sufficiente-
mente distinguibili.
II1.2.3.1.
Casette e viltini.
Sono piccoli edifici,
generalmente unifamigliari, improntati a caratteri di
relativo decoro, circondati da giardino con orto-frut-
teto. Rispondono alle esigenze di residenza (di solito
permanente, raramente solo estiva) di una famiglia
medio o piccolo borghese cittadina; presentano ca-
ratteri distributivi e tipologici molto semplici e ricor-
renti
- a corpo allungato, organizzato su manica
semplice, con o senza corridoio; oppure
- a corpo circa quadrato, organizzato su mani-
ca doppia con quattro affacci.
I volumi edilizi sono generalmente sviluppati su
più piani, sfruttando i dislivelli del terreno, con loca-
li di soggiorno affacciati sul ripiano principale del
giardino.
Nel collocamento dell'edificio, nel suo collega-
mento con la strada e nell'organizzazione a ripiani
del giardino, associato a frutteto e orto, vengono
generalmente ripresi, in tono minore e in scala ridot-
ta, criteri e caratteri tradizionali propri delle « vi-
gne» collinari torinesi (punto 111.1 .3.)
- l'edificio è collocato e il giardino è struttura-
to in modo da defilare, agli occhi indiscreti di chi
percorre la strada, le zone di soggiorno nella casa e
nel giardino
- l'ingresso principale sulla strada è sottolinea-
to da un elemento architettonico di una certa rile-
vanza, come un cancello fiancheggiato da «piloni
»
in muratura, o come una « portina » coperta da un
piccolo terrazzo sporgente
- il percorso di ingresso è spesso coperto da un
pergolato; in ogni caso un pergolato con un « ber-
ceau» (o «pinnacolo ») non possono mancare nel
giardino, coperti con viti, con glicine o con le carat-
teristiche roselline gialle senza spine
- dal muro di cinta o dalla balaustra del terraz-
zo verso strada emergono le masse arboree decorati-
ve piantate nella parte principale e di relativa rappre-
sentanza del giardino; ricorrono ancora le specie
sempre-verdi care al gusto neoclassico e al gusto
locale ottocentesco in generale, come lauri, lecci,
magnolie, nespoli, sofore, cameropi e talvolta anche
qualche cedro, poi divenuto colossale e sproporzio-
nato.
III.2.3.2.
Vitte tra Ottocento e Novecento.
Sono
edifici, generalmente unifamigliari, più grandi e
complessi dei villini predetti, circondati da un giar-
dino, ben distinto e separato da un eventuale orto.
/75


















