
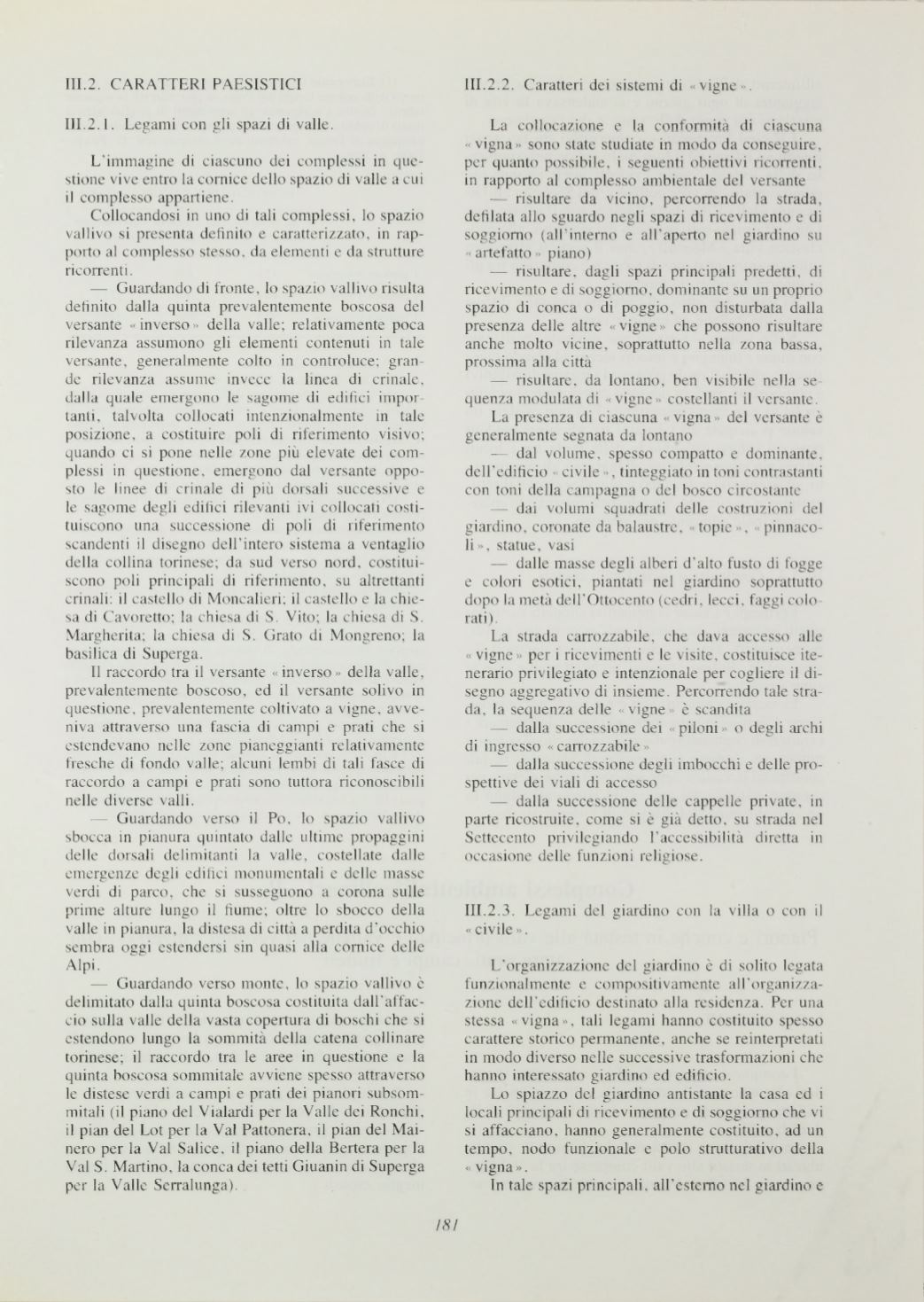
III.2. CARATTERI PAESISTICI
11I.2.2. Caratteri dei sistemi di « vigne » .
III.2.1. Legami con gli spazi di valle.
L'immagine di ciascuno dei complessi in que-
stione vive entro la cornice dello spazio di valle a cui
il complesso appartiene.
Collocandosi in uno di tali complessi, lo spazio
vallivo si presenta definito e caratterizzato, in rap-
porto al complesso stesso, da elementi e da strutture
ricorrenti.
- Guardando di fronte, lo spazio vallivo risulta
definito dalla quinta prevalentemente boscosa del
versante « inverso » della valle; relativamente poca
rilevanza assumono gli elementi contenuti in tale
versante, generalmente colto in controluce; gran-
de rilevanza assume invece la linea di crinale,
dalla quale emergono le sagome di edifici impor-
tanti, talvolta collocati intenzionalmente in tale
posizione, a costituire poli di riferimento visivo;
quando ci si pone nelle zone più elevate dei com-
plessi
ill
questione, emergono dal versante oppo-
sto le linee di crinale di più dorsali successive e
le sagome degli edifici rilevanti ivi collocati costi-
tuiscono una successione di poli di riferimento
scandenti
il
disegno dell'intero sistema a ventaglio
della collina torinese; da sud verso nord, costitui-
scono poli principali di riferimento, su altrettanti
crinali: il castello di Moncalieri; il castello e la chie-
sa di Cavoretto; la chiesa di S. Vito; la chiesa di S.
Margherita; la chiesa di S. Grato di Mongreno; la
basilica di Superga.
Il raccordo tra il versante « inverso » della valle,
prevalentemente boscoso, ed il versante solivo in
questione, prevalentemente coltivato a vigne, avve-
niva attraverso una fascia di campi e prati che si
estendevano nelle zone pianeggianti relativamente
fresche di fondo valle; alcuni lembi di tali fasce di
raccordo a campi e prati sono tuttora riconoscibili
nelle diverse valli.
- Guardando verso il Po, lo spazio vallivo
sbocca in pianura quintato dalle ultime propaggini
delle dorsali delimitanti la valle, costellate dalle
emergenze degli edifici monumentali e delle masse
verdi di parco, che si susseguono a corona sulle
prime alture lungo il fiume; oltre lo sbocco della
valle in pianura, la distesa di città a perdita d'occhio
sembra oggi estendersi sin quasi alla cornice delle
Alpi.
- Guardando verso monte, lo spazio vallivo è
delimitato dalla quinta boscosa costituita dall'affac-
cio sulla valle della vasta copertura di boschi che si
estendono lungo la sommità della catena collinare
torinese; il raccordo tra le aree in questione e la
quinta boscosa sommitale avviene spesso attraverso
le distese verdi a campi e prati dei pianori subsom-
mitali (il piano del Vialardi per la Valle dei Ronchi,
il pian del Lot per la Val Pattonera,
il
pian del Mai-
nero per la Val Salice,
il
piano della Bertera per la
Val S. Martino, la conca dei tetti Givanin di Superga
per la Valle Serralunga).
La collocazione e la conformità di ciascuna
«vigna» sono state studiate in modo da conseguire,
per quanto possibile, i seguenti obiettivi ricorrenti,
in rapporto al complesso ambientale del versante
— risultare da vicino, percorrendo la strada,
defilata allo sguardo negli spazi di ricevimento e di
soggiorno (all'interno e all'aperto nel giardino su
« artefatto » piano)
— risultare, dagli spazi principali predetti, di
ricevimento e di soggiorno, dominante su un proprio
spazio di conca o di poggio, non disturbata dalla
presenza delle altre «vigne» che possono risultare
anche molto vicine, soprattutto nella zona bassa,
prossima alla città
- risultare, da lontano, ben visibile nella se-
quenza modulata di « vigne » costellanti il versante.
La presenza di ciascuna « vigna » del versante è
generalmente segnata da lontano
- dal volume, spesso compatto e dominante,
dell'edificio « civile » , tinteggiato in toni contrastanti
con toni della campagna o del bosco circostante
- dai
volumi
squadrati delle costruzioni del
giardino, coronate da balaustre, « topie » , « pinnaco-
li » , statue, vasi
— dalle masse degli alberi d'alto fusto di fogge
e colori esotici, piantati nel giardino soprattutto
dopo la metà dell'Ottocento (cedri, lecci, faggi colo-
rati).
La strada carrozzabile, che dava accesso alle
« vigne » per i ricevimenti e le visite, costituisce ite-
nerario privilegiato e intenzionale per cogliere il di-
segno aggregativo di insieme. Percorrendo tale stra-
da, la sequenza delle « vigne » è scandita
- dalla successione dei « piloni» o degli archi
di ingresso « carrozzabile
- dalla successione degli imbocchi e delle pro-
spettive dei viali di accesso
- dalla successione delle cappelle private, in
parte ricostruite, come si è già detto, su strada nel
Settecento privilegiando
l'accessibilità
diretta in
occasione delle funzioni religiose.
III.2.3. Legami del giardino con
la
villa o con il
«civile ».
L'organizzazione del giardino è di solito legata
funzionalmente e compositivamente all'organizza-
zione dell'edificio destinato alla residenza. Per una
stessa « vigna» , tali legami hanno costituito spesso
carattere storico permanente, anche se reinterpretati
in modo diverso nelle successive trasformazioni che
hanno interessato giardino ed edificio.
Lo spiazzo del giardino antistante la casa ed i
locali principali di ricevimento e di soggiorno che vi
si affacciano, hanno generalmente costituito, ad un
tempo, nodo funzionale e polo strutturativo della
« vigna».
In tale spazi principali, all'esterno nel giardino e
181


















