
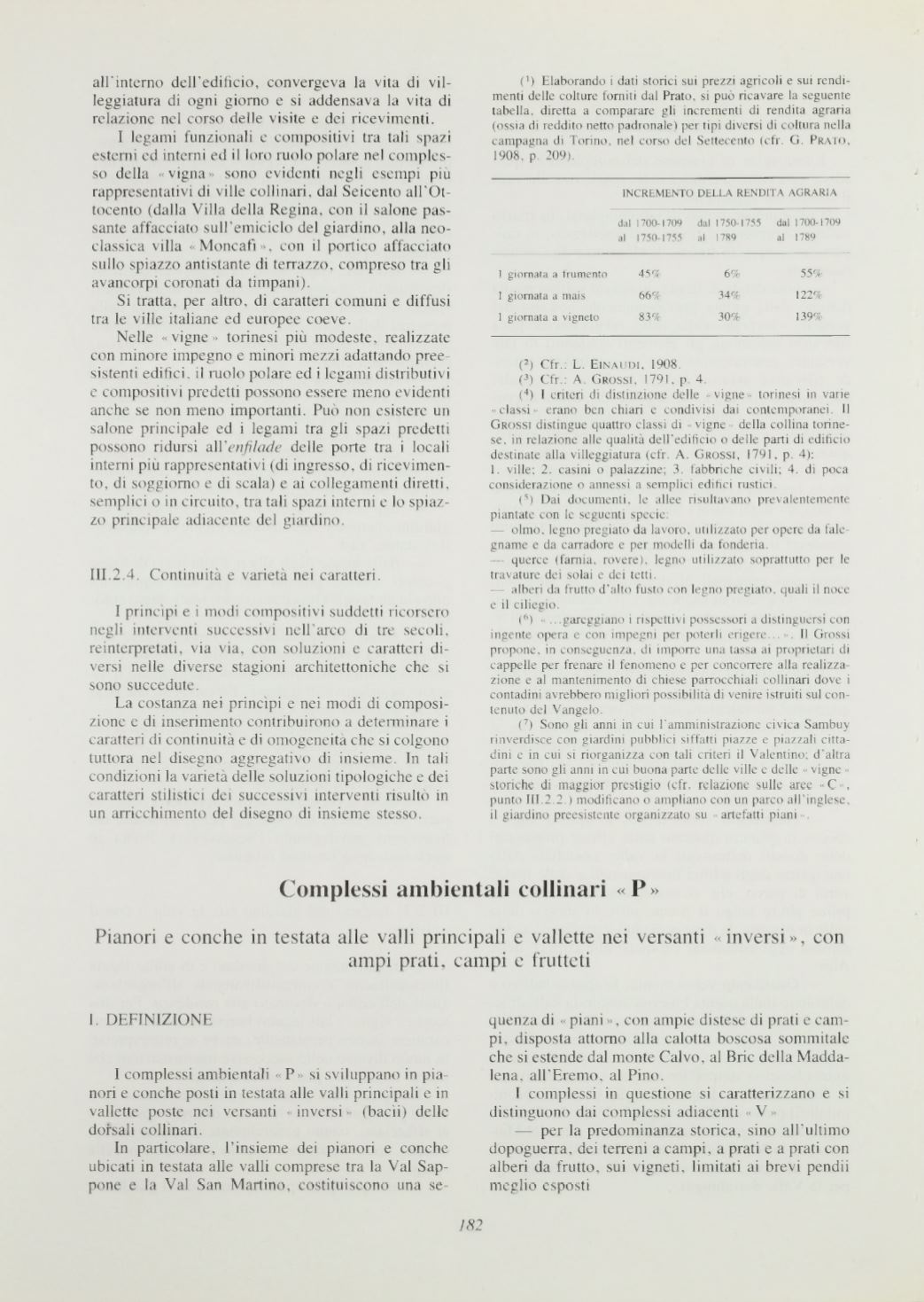
all'interno dell'edificio, convergeva la vita di vil-
leggiatura di ogni giorno e si addensava la vita di
relazione nel corso delle visite e dei ricevimenti.
I legami funzionali e compositivi tra tali spazi
esterni ed interni ed il loro ruolo polare nel comples-
so della « vigna» sono evidenti negli esempi più
rappresentativi di ville collinari, dal Seicento all'Ot-
tocento (dalla Villa della Regina, con il salone pas-
sante affacciato sull'emiciclo del giardino, alla neo-
classica villa «Moncafi », con il portico affacciato
sullo spiazzo antistante di terrazzo, compreso tra gli
avancorpi coronati da timpani).
Si tratta, per altro, di caratteri comuni e diffusi
tra le ville italiane ed europee coeve.
Nelle «vigne» torinesi più modeste, realizzate
con minore impegno e minori mezzi adattando pree-
sistenti edifici, il ruolo polare ed i legami distributivi
e compositivi predetti possono essere meno evidenti
anche se non meno importanti. Può non esistere un
salone principale ed i legami tra gli spazi predetti
possono ridursi
all'enfilade
delle porte tra i locali
interni più rappresentativi (di ingresso, di ricevimen-
to, di soggiorno e di scala) e ai collegamenti diretti,
semplici o in circuito, tra tali spazi interni e lo spiaz-
zo principale adiacente del giardino.
III.2.4. Continuità e varietà nei caratteri.
I principi e i modi compositivi suddetti ricorsero
negli interventi successivi nell'arco di tre secoli,
reinterpretati, via via, con soluzioni e caratteri di-
versi nelle diverse stagioni architettoniche che si
sono succedute.
La costanza nei principi e nei modi di composi-
zione e di inserimento contribuirono a determinare i
caratteri di continuità e di omogeneità che si colgono
tuttora nel disegno aggregativo di insieme. In tali
condizioni la varietà delle soluzioni tipologiche e dei
caratteri stilistici dei successivi interventi risultò in
un arricchimento del disegno di insieme stesso.
(i) Elaborando i dati storici sui prezzi agricoli e sui rendi-
menti delle colture forniti dal Prato, si può ricavare la seguente
tabella, diretta a comparare gli incrementi di rendita agraria
(ossia di reddito netto padronale) per tipi diversi di coltura nella
campagna di Torino, nel corso del Settecento (cfr. G.
PRATO,
1908, p. 209).
INCREMENTO DELLA RENDITA AGRARIA
dal 1700-1709 dal 1750-1755 dal 1700-1709
at
1750-1755 al 1789
al l 789
I giornata a frumento
45%
6%
55%
1 giornata a mais
66%
34%
122%
I giornata a vigneto
83%
30%
139%
(2) Cfr.: L.
EINAUDI,
1908.
(3) Cfr.: A.
GRossI,
1791, p. 4.
(4) I criteri di distinzione delle «vigne» torinesi in varie
classi » erano ben chiari e condivisi dai contemporanei. Il
GRossI
distingue quattro classi di .. vigne » della collina torine-
se, in relazione alle qualità dell'edificio o delle parti di edificio
destinate alla villeggiatura (cfr. A.
GROSSI,
1791, p. 4):
1. ville; 2. casini o palazzine; 3. fabbriche civili; 4. di poca
considerazione o annessi a semplici edifici rustici.
(5) Dai documenti, le allee risultavano prevalentemente
piantate con le seguenti specie:
olmo, legno pregiato da lavoro, utilizzato per opere da fale-
gname e da carradore e per modelli da fonderia.
— querce (farnia, rovere), legno utilizzato soprattutto per le
travature dei solai e dei tetti.
— alberi da frutto d'alto fusto con legno pregiato, quali il noce
e il ciliegio.
(6) «...gareggiano i rispettivi possessori a distinguersi con
ingente opera e con impegni per poterli erigere...... Il Grossi
propone, in conseguenza, di imporre una tassa ai proprietari di
cappelle per frenare il fenomeno e per concorrere alla realizza-
zione e al mantenimento di chiese parrocchiali collinari dove i
contadini avrebbero migliori possibilità di venire istruiti sul con-
tenuto del Vangelo.
(7) Sono gli anni in cui l'amministrazione civica Sambuy
rinverdisce con giardini pubblici siffatti piazze e piazzali citta-
dini e in cui si riorganizza con tali criteri il Valentino; d'altra
parte sono gli anni in cui buona parte delle ville e delle «vigne»
storiche di maggior prestigio (cfr. relazione sulle aree «C.>,
punto III.2.2.) modificano o ampliano con un parco all'inglese,
il giardino preesistente organizzato su « artefatti piani
Complessi ambientali collinari «P»
Pianori e conche in testata alle valli principali e vallette nei versanti «inversi», con
ampi prati, campi e frutteti
I. DEFINIZIONE
I complessi ambientali « P» si sviluppano in pia-
noni e conche posti in testata alle valli principali e in
vallette poste nei versanti « inversi » (bacii) delle
dorsali collinari.
In particolare, l'insieme dei pianori e conche
ubicati in testata alle valli comprese tra la Val Sap-
pone e la Val San Martino, costituiscono una se-
quenza di «piani», con ampie distese di prati e cam-
pi, disposta attorno alla calotta boscosa sommitale
che si estende dal monte Calvo, al Bric della Madda-
lena, all'Eremo, al Pino.
I complessi in questione si caratterizzano e si
distinguono dai complessi adiacenti « V
per la predominanza storica, sino all'ultimo
dopoguerra, dei terreni a campi, a prati e a prati con
alberi da frutto, sui vigneti, limitati ai brevi pendii
meglio esposti
182


















