
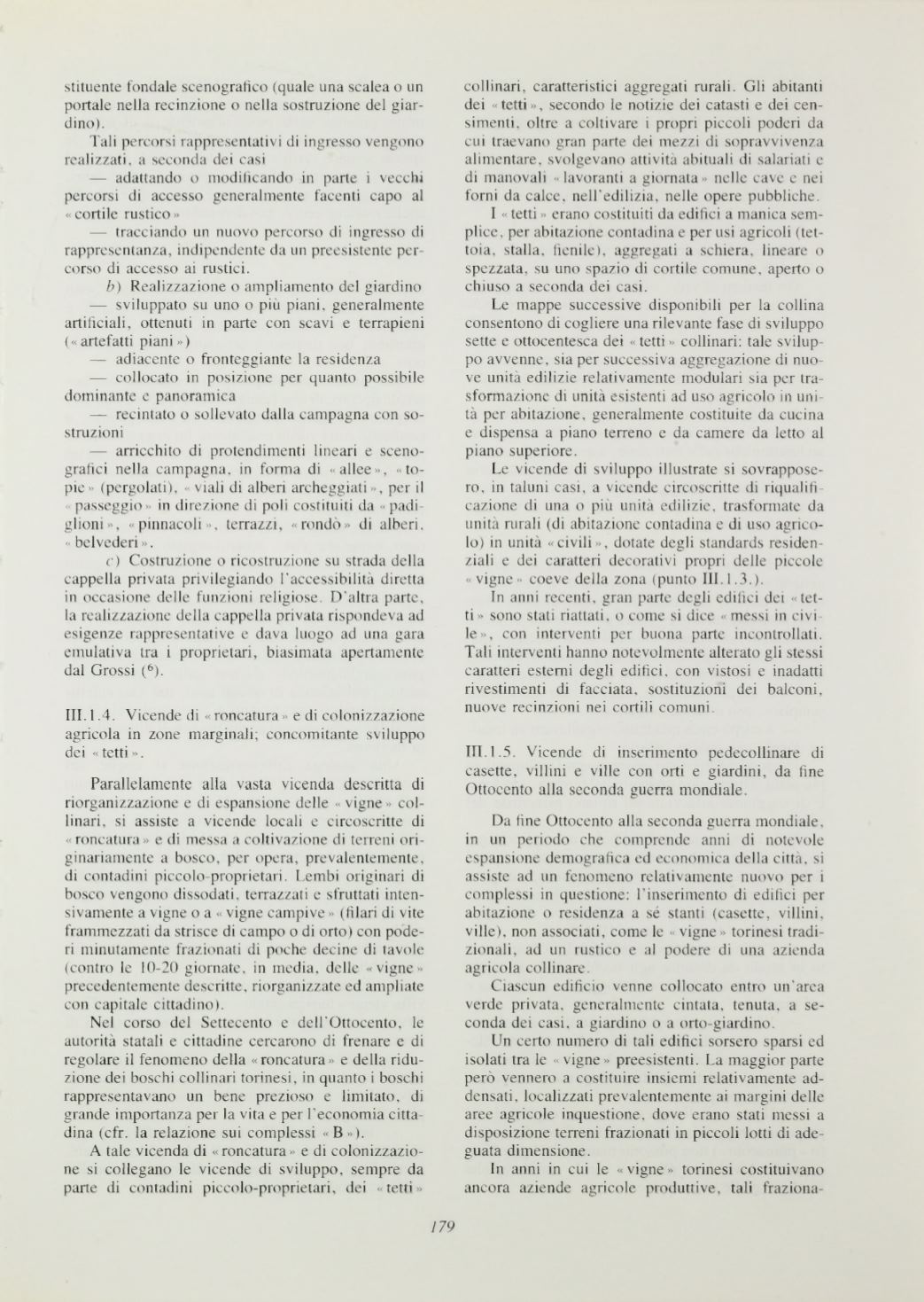
stituente fondale scenografico (quale una scalea o un
portale nella recinzione o nella sostruzione del giar-
dino).
Tali percorsi rappresentativi di ingresso vengono
realizzati, a seconda dei casi
- adattando o modificando in parte i vecchi
percorsi di accesso generalmente facenti capo al
«
cortile rustico»
- tracciando un nuovo percorso di ingresso di
rappresentanza, indipendente da un preesistente per-
corso di accesso ai rustici.
b)
Realizzazione o ampliamento del giardino
- sviluppato su uno o più piani, generalmente
artificiali, ottenuti in parte con scavi e terrapieni
(«
artefatti piani »)
— adiacente o fronteggiante la residenza
- collocato in posizione per quanto possibile
dominante e panoramica
— recintato o sollevato dalla campagna con so-
struzioni
- arricchito di protendimenti lineari e sceno-
grafici nella campagna, in forma di « allee » , » to-
pie» (pergolati), «viali di alberi archeggiati», per il
passeggio » in direzione di poli costituiti da « padi-
glioni », » pinnacoli » , terrazzi, « ronde)» di alberi,
belvederi » .
c)
Costruzione o ricostruzione su strada della
cappella privata privilegiando l'accessibilità diretta
in occasione delle funzioni religiose. D'altra parte,
la realizzazione della cappella privata rispondeva ad
esigenze rappresentative e dava luogo ad una gara
emulativa tra i proprietari, biasimata apertamente
dal Grossi (
6
).
III.1.4. Vicende di «roncatura» e di colonizzazione
agricola in zone marginali; concomitante sviluppo
dei « tetti».
Parallelamente alla vasta vicenda descritta di
riorganizzazione e di espansione delle « vigne» col-
linari, si assiste a vicende locali e circoscritte di
roncatura» e di messa a coltivazione di terreni ori-
ginariamente a bosco, per opera, prevalentemente,
di contadini piccolo-proprietari. Lembi originari di
bosco vengono dissodati, terrazzati e sfruttati inten-
sivamente a vigne o a « vigne campive» (filari di vite
frammezzati da strisce di campo o di orto) con pode-
ri minutamente frazionati di poche decine di tavole
(contro le 10-20 giornate, in media, delle «vigne»
precedentemente descritte, riorganizzate ed ampliate
con capitale cittadino).
Nel corso del Settecento e dell'Ottocento, le
autorità statali e cittadine cercarono di frenare e di
regolare il fenomeno della «roncatura» e della ridu-
zione dei boschi collinari torinesi, in quanto i boschi
rappresentavano un bene prezioso e limitato, di
grande importanza per la vita e per l'economia citta-
dina (cfr. la relazione sui complessi «
B »).
A tale vicenda di »roncatura» e di colonizzazio-
ne si collegano le vicende di sviluppo, sempre da
parte di contadini piccolo-proprietari, dei «tetti»
collinari, caratteristici aggregati rurali. Gli abitanti
dei «
tetti » ,
secondo le notizie dei catasti e dei cen-
simenti, oltre a coltivare i propri piccoli poderi da
cui traevano gran parte dei mezzi di sopravvivenza
alimentare, svolgevano attività abituali di salariati e
di manovali « lavoranti a giornata» nelle cave e nei
forni da calce, nell'edilizia, nelle opere pubbliche.
I « tetti » erano costituiti da edifici a manica sem-
plice, per abitazione contadina e per usi agricoli (tet-
toia, stalla, fienile), aggregati a schiera, lineare o
spezzata, su uno spazio di cortile comune, aperto o
chiuso a seconda dei casi.
Le mappe successive disponibili per la collina
consentono di cogliere una rilevante fase di sviluppo
sette e ottocentesca dei « tetti » collinari: tale svilup-
po avvenne, sia per successiva aggregazione di nuo-
ve unità edilizie relativamente modulari sia per tra-
sformazione di unità esistenti ad uso agricolo in uni-
tà per abitazione, generalmente costituite da cucina
e dispensa a piano terreno e da camere da letto al
piano superiore.
Le vicende di sviluppo illustrate si sovrappose-
ro, in taluni casi, a vicende circoscritte di riqualifi-
cazione di una o più unità edilizie, trasformate da
unità rurali (di abitazione contadina e di uso agrico-
lo) in unità « civili », dotate degli standards residen-
ziali e dei caratteri decorativi propri delle piccole
« vigne » coeve della zona (punto
111.
1 . 3 . ).
In anni recenti, gran parte degli edifici dei «tet-
ti » sono stati riattati, o come si dice « messi in civi-
le
»,
con interventi per buona parte incontrollati.
Tali interventi hanno notevolmente alterato gli stessi
caratteri esterni degli edifici, con vistosi e inadatti
rivestimenti di facciata, sostituzioni dei balconi,
nuove recinzioni nei cortili comuni.
III.1.5. Vicende di inserimento pedecollinare di
casette, villini e ville con orti e giardini, da fine
Ottocento alla seconda guerra mondiale.
Da fine Ottocento alla seconda guerra mondiale,
in un periodo che comprende anni di notevole
espansione demografica ed economica della città, si
assiste ad un fenomeno relativamente nuovo per i
complessi in questione: l'inserimento di edifici per
abitazione o residenza a sé stanti (casette, villini,
ville), non associati, come le «vigne» torinesi tradi-
zionali, ad un rustico e al podere di una azienda
agricola collinare.
Ciascun edificio venne collocato entro un'area
verde privata, generalmente cintata, tenuta, a se-
conda dei casi, a giardino o a orto-giardino.
Un certo numero di tali edifici sorsero sparsi ed
isolati tra le » vigne» preesistenti. La maggior parte
però vennero a costituire insiemi relativamente ad-
densati, localizzati prevalentemente ai margini delle
aree agricole inquestione, dove erano stati messi a
disposizione terreni frazionati in piccoli lotti di ade-
guata dimensione.
In anni in cui le » vigne » torinesi costituivano
ancora aziende agricole produttive,
tali
fraziona-
179


















