
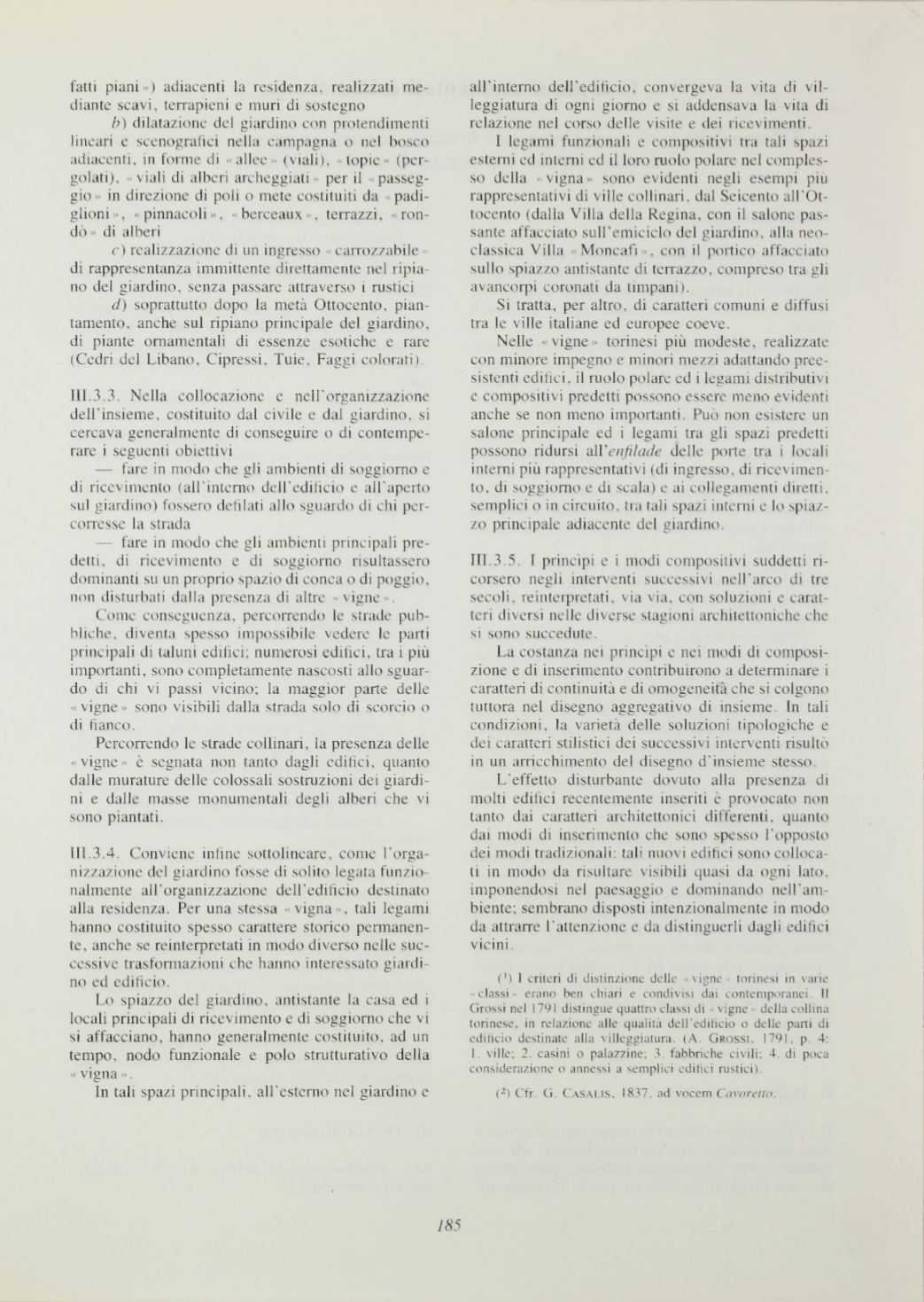
fatti piani ») adiacenti la residenza, realizzati me-
diante scavi, terrapieni e muri di sostegno
b) dilatazione del giardino con protendimenti
lineari e scenografici nella campagna o nel bosco
adiacenti, in forme di « allee » (viali), « topie » (per-
golati), « viali di alberi archeggiati » per il « passeg-
gio » in direzione di poli o mete costituiti da « padi-
glioni », « pinnacoli », « berceaux » , terrazzi, « ron-
dò » di alberi
c) realizzazione di un ingresso « carrozzabile »
di rappresentanza immittente direttamente nel ripia-
no del giardino, senza passare attraverso i rustici
d)
soprattutto dopo la metà Ottocento, pian-
tamento, anche sul ripiano principale del giardino,
di piante ornamentali di essenze esotiche e rare
(Cedri del Libano, Cipressi, Tuie, Faggi colorati).
III.3.3. Nella collocazione e nell'organizzazione
dell'insieme, costituito dal civile e dal giardino, si
cercava generalmente di conseguire o di contempe-
rare i seguenti obiettivi
- fare in modo che gli ambienti di soggiorno e
di ricevimento (all'interno dell'edificio e all'aperto
sul giardino) fossero defilati allo sguardo di chi per-
corresse la strada
- fare in modo che gli ambienti principali pre-
detti, di ricevimento e di soggiorno risultassero
dominanti su un proprio spazio di conca o di poggio,
non disturbati dalla presenza di altre «vigne».
Come conseguenza, percorrendo le strade pub-
bliche, diventa spesso impossibile vedere le parti
principali di taluni edifici; numerosi edifici, tra i più
importanti, sono completamente nascosti allo sguar-
do di chi vi passi vicino; la maggior parte delle
vigne » sono visibili dalla strada solo di scorcio o
di fianco.
Percorrendo le strade collinari, la presenza delle
vigne » è segnata non tanto dagli edifici, quanto
dalle murature delle colossali sostruzioni dei giardi-
ni e dalle masse monumentali degli alberi che vi
sono piantati.
IIL3.4. Conviene infine sottolineare, come l'orga-
nizzazione del giardino fosse di solito legata funzio-
nalmente all'organizzazione dell'edificio destinato
alla residenza. Per una stessa « vigna» , tali legami
hanno costituito spesso carattere storico permanen-
te, anche se reinterpretati in modo diverso nelle suc-
cessive trasformazioni che hanno interessato giardi-
no ed edificio.
Lo spiazzo del giardino, antistante la casa ed i
locali principali di ricevimento e di soggiorno che vi
si affacciano, hanno generalmente costituito, ad un
tempo, nodo funzionale e polo strutturativo della
«vigna».
In tali spazi principali, all'esterno nel giardino e
all'interno dell'edificio, convergeva la vita di vil-
leggiatura di ogni giorno e si addensava la vita di
relazione nel corso delle visite e dei ricevimenti.
I legami funzionali e compositivi tra tali spazi
esterni ed interni ed il loro ruolo polare nel comples-
so della « vigna » sono evidenti negli esempi più
rappresentativi di ville collinari, dal Seicento all'Ot-
tocento (dalla Villa della Regina, con il salone pas-
sante affacciato sull'emiciclo del giardino, alla neo-
classica Villa «Moncafi», con il portico affacciato
sullo spiazzo antistante di terrazzo, compreso tra gli
avancorpi coronati da timpani).
Si tratta, per altro, di caratteri comuni e diffusi
tra le ville italiane ed europee coeve.
Nelle « vigne » torinesi più modeste, realizzate
con minore impegno e minori mezzi adattando pree-
sistenti edifici, il ruolo polare ed i legami distributivi
e compositivi predetti possono essere meno evidenti
anche se non meno importanti. Può non esistere un
salone principale ed i legami tra gli spazi predetti
possono ridursi
all'enfitade
delle porte tra i locali
interni più rappresentativi (di ingresso, di ricevimen-
to, di soggiorno e di scala) e ai collegamenti diretti,
semplici o in circuito, tra tali spazi interni e lo spiaz-
zo principale adiacente del giardino.
IIL3.5. I principi e i modi compositivi suddetti ri-
corsero negli interventi successivi nell'arco di tre
secoli, reinterpretati, via via, con soluzioni e carat-
teri diversi nelle diverse stagioni architettoniche che
si sono succedute.
La costanza nei principi e nei modi di composi-
zione e di inserimento contribuirono a determinare i
caratteri di continuità e di omogeneità che si colgono
tuttora nel disegno aggregativo di insieme. In tali
condizioni, la varietà delle soluzioni tipologiche e
dei caratteri stilistici dei successivi interventi risultò
in un arricchimento del disegno d'insieme stesso.
L'effetto disturbante dovuto alla presenza di
molti edifici recentemente inseriti è provocato non
tanto dai caratteri architettonici differenti, quanto
dai modi di inserimento che sono spesso l'opposto
dei modi tradizionali: tali nuovi edifici sono colloca-
ti in modo da risultare visibili quasi da ogni lato,
imponendosi nel paesaggio e dominando nell'am-
biente; sembrano disposti intenzionalmente in modo
da attrarre l'attenzione e da distinguerli dagli edifici
vicini.
(1) I criteri di distinzione delle .. vigne» torinesi in varie
«classi ., erano ben chiari e condivisi dai contemporanei. Il
Grossi nel 1791 distingue quattro classi di « vigne „ della collina
torinese, in relazione alle qualità dell'edificio o delle parti di
edificio destinate alla villeggiatura. (A.
GRossI,
1791, p. 4:
1. ville; 2. casini o palazzine;
3.
fabbriche civili; 4. di poca
considerazione o annessi a semplici edifici rustici).
(2) Cfr.
G.
CASALIS, 1837,
ad
vocem
Cavoretto.
185


















