
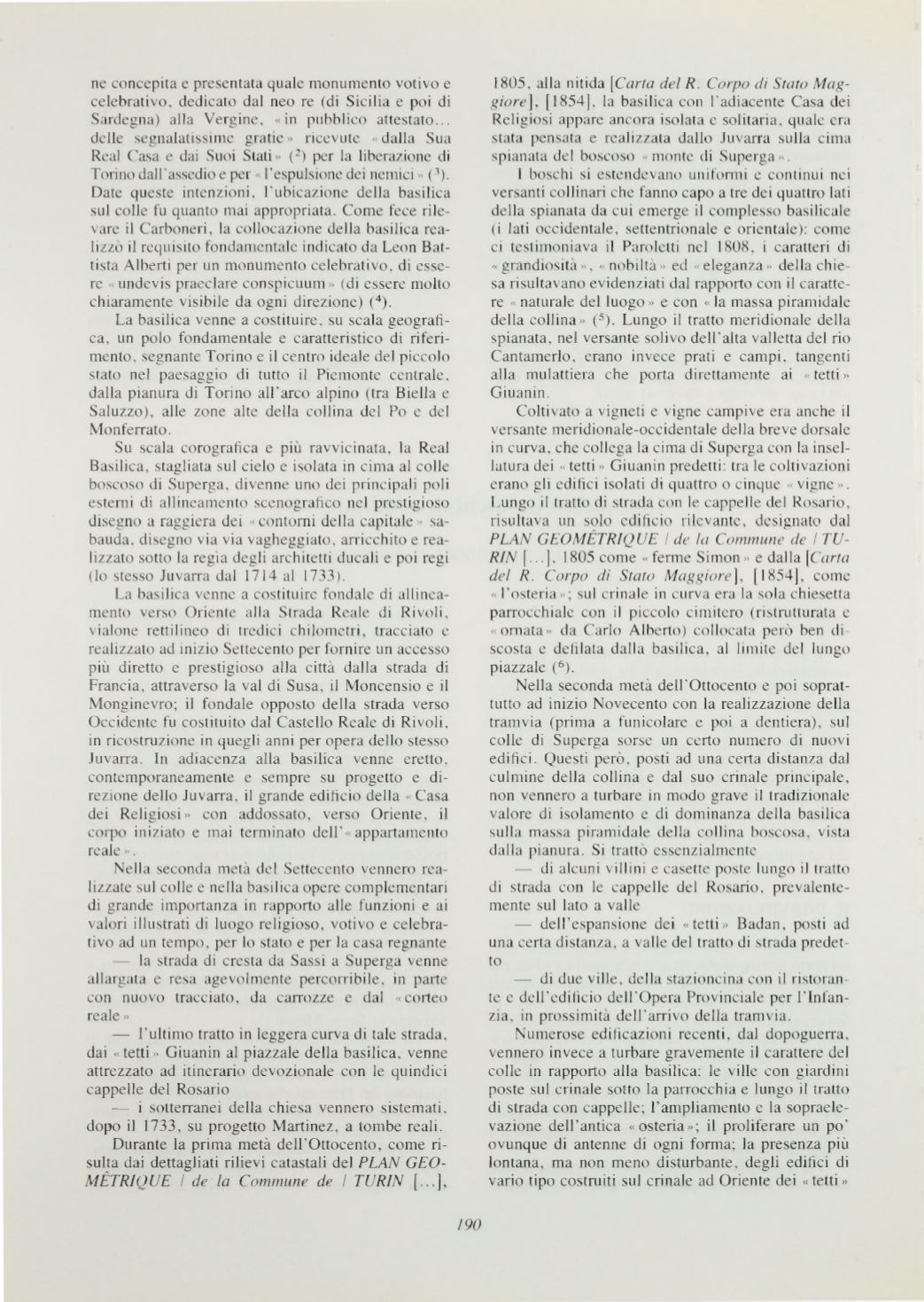
ne concepita e presentata quale monumento votivo e
celebrativo, dedicato dal neo re (di Sicilia e poi di
Sardegna) alla Vergine, « in pubblico attestato...
delle segnalatissime grafie » ricevute « dalla Sua
Real Casa e dai Suoi Stati » (
2
) per la liberazione di
Torino dall'assedio e per « l'espulsione dei nemici » (
3
).
Date queste intenzioni, l'ubicazione della basilica
sul colle fu quanto mai appropriata. Come fece rile-
vare il Carboneri, la collocazione della basilica rea-
lizzò il requisito fondamentale indicato da Leon Bat-
tista Alberti per un monumento celebrativo, di esse-
re « undevis praeclare conspicuum » (di essere molto
chiaramente visibile da ogni direzione) (
4
).
La basilica venne a costituire, su scala geografi-
ca, un polo fondamentale e caratteristico di riferi-
mento, segnante Torino e il centro ideale del piccolo
stato nel paesaggio di tutto il Piemonte centrale,
dalla pianura di Torino all'arco alpino (tra Biella e
Saluzzo), alle zone alte della collina del Po e del
Monferrato.
Su scala corografica e più ravvicinata, la Real
Basilica, stagliata sul cielo e isolata in cima al colle
boscoso di Superga, divenne uno dei principali poli
esterni di allineamento scenografico nel prestigioso
disegno a raggiera dei «contorni della capitale» sa-
bauda, disegno via via vagheggiato, arricchito e rea-
lizzato sotto la regia degli architetti ducali e poi regi
(lo stesso Juvarra dal 1714 al 1733).
La basilica venne a costituire fondale di allinea-
mento verso Oriente alla Strada Reale di Rivoli,
vialone rettilineo di tredici chilometri, tracciato e
realizzato ad inizio Settecento per fornire un accesso
più diretto e prestigioso alla città dalla strada di
Francia, attraverso la val di Susa, il Moncensio e il
Monginevro; il fondale opposto della strada verso
Occidente fu costituito dal Castello Reale di Rivoli,
in ricostruzione in quegli anni per opera dello stesso
Juvarra. In adiacenza alla basilica venne eretto.
contemporaneamente e sempre su progetto e di-
rezione dello Juvarra, il grande edificio della « Casa
dei Religiosi» con addossato, verso Oriente, il
corpo iniziato e mai terminato dell'« appartamento
reale».
Nella seconda metà del Settecento vennero rea-
lizzate sul colle e nella basilica opere complementari
di grande importanza in rapporto alle funzioni e ai
valori illustrati di luogo religioso, votivo e celebra-
tivo ad un tempo, per lo stato e per la casa regnante
- la strada di cresta da Sassi a Superga venne
allargata e resa agevolmente percorribile, in parte
con nuovo tracciato, da carrozze e dal « corteo
reale »
— l'ultimo tratto in leggera curva di tale strada,
dai «tetti» Givanin al piazzale della basilica, venne
attrezzato ad itinerario devozionale con le quindici
cappelle del Rosario
— i sotterranei della chiesa vennero sistemati,
dopo il I733, su progetto Ma
rt
inez, a tombe reali.
Durante la prima metà dell'Ottocento, come ri-
sulta dai dettagliati rilievi catastali del
PLAN GEO-
METRIQUE I de la Commune de l TURIN [...],
1805, alla nitida
[Carta det R. Corpo di Stato Mag-
giore],
[I854], la basilica con l'adiacente Casa dei
Religiosi appare ancora isolata e solitaria, quale era
stata pensata e realizzata dallo Juvarra sulla cima
spianata del boscoso « monte di Superga ».
I boschi si estendevano uniformi e continui nei
versanti collinari che fanno capo a tre dei quattro lati
della spianata da cui emerge il complesso basilicale
(i lati occidentale, settentrionale e orientale): come
ci testimoniava il Paroletti nel 1808, i caratteri di
«grandiosità», «nobiltà» ed «eleganza» della chie-
sa risultavano evidenziati dal rapporto con il caratte-
re « naturale del luogo » e con « la massa piramidale
della collina» (
5
). Lungo il tratto meridionale della
spianata, nel versante solivo dell'alta valletta del rio
Cantamerlo, erano invece prati e campi, tangenti
alla mulattiera che porta direttamente ai « tetti »
Givanin.
Coltivato a vigneti e vigne campive era anche il
versante meridionale-occidentale della breve dorsale
in curva, che collega la cima di Superga con la insel-
latura dei « tetti » Givanin predetti: tra le coltivazioni
erano gli edifici isolati di quattro o cinque « vigne » .
Lungo il tratto di strada con le cappelle del Rosario,
risultava un solo edificio rilevante, designato dal
PLAN GEOMETRIQUE I de ta Commune de l TU-
RIN [...],
1805 come «ferme Simon» e dalla
[Carta
det R. Corpo di Stato Maggiore],
[1854], come
«l'osteria»; sul crinale in curva era la sola chiesetta
parrocchiale con il piccolo cimitero (ristrutturata e
« ornata» da Carlo Alberto) collocata però ben di-
scosta e defilata dalla basilica, al limite del lungo
piazzale (
6
).
Nella seconda metà dell'Ottocento e poi soprat-
tutto ad inizio Novecento con la realizzazione della
tramvia (prima a funicolare e poi a dentiera), sul
colle di Superga sorse un certo numero di nuovi
edifici. Questi però, posti ad una certa distanza dal
culmine della collina e dal suo crinale principale,
non vennero a turbare in modo grave il tradizionale
valore di isolamento e di dominanza della basilica
sulla massa piramidale della collina boscosa, vista
dalla pianura. Si trattò essenzialmente
- di alcuni villini e casette poste lungo il tratto
di strada con le cappelle del Rosario, prevalente-
mente sul lato a valle
- dell'espansione dei «tetti» Badan, posti ad
una certa distanza, a valle del tratto di strada predet-
to
- di due ville, della stazioncina con il ristoran-
te e dell'edificio dell'Opera Provinciale per l'Infan-
zia, in prossimità dell'arrivo della tramvia.
Numerose edificazioni recenti, dal dopoguerra,
vennero invece a turbare gravemente il carattere del
colle in rapporto alla basilica: le ville con giardini
poste sul crinale sotto la parrocchia e lungo il tratto
di strada con cappelle; l'ampliamento e la sopraele-
vazione dell'antica «osteria»; il proliferare un po'
ovunque di antenne di ogni forma; la presenza più
lontana, ma non meno disturbante, degli edifici di
vario tipo costruiti sul crinale ad Oriente dei « tetti
190


















