
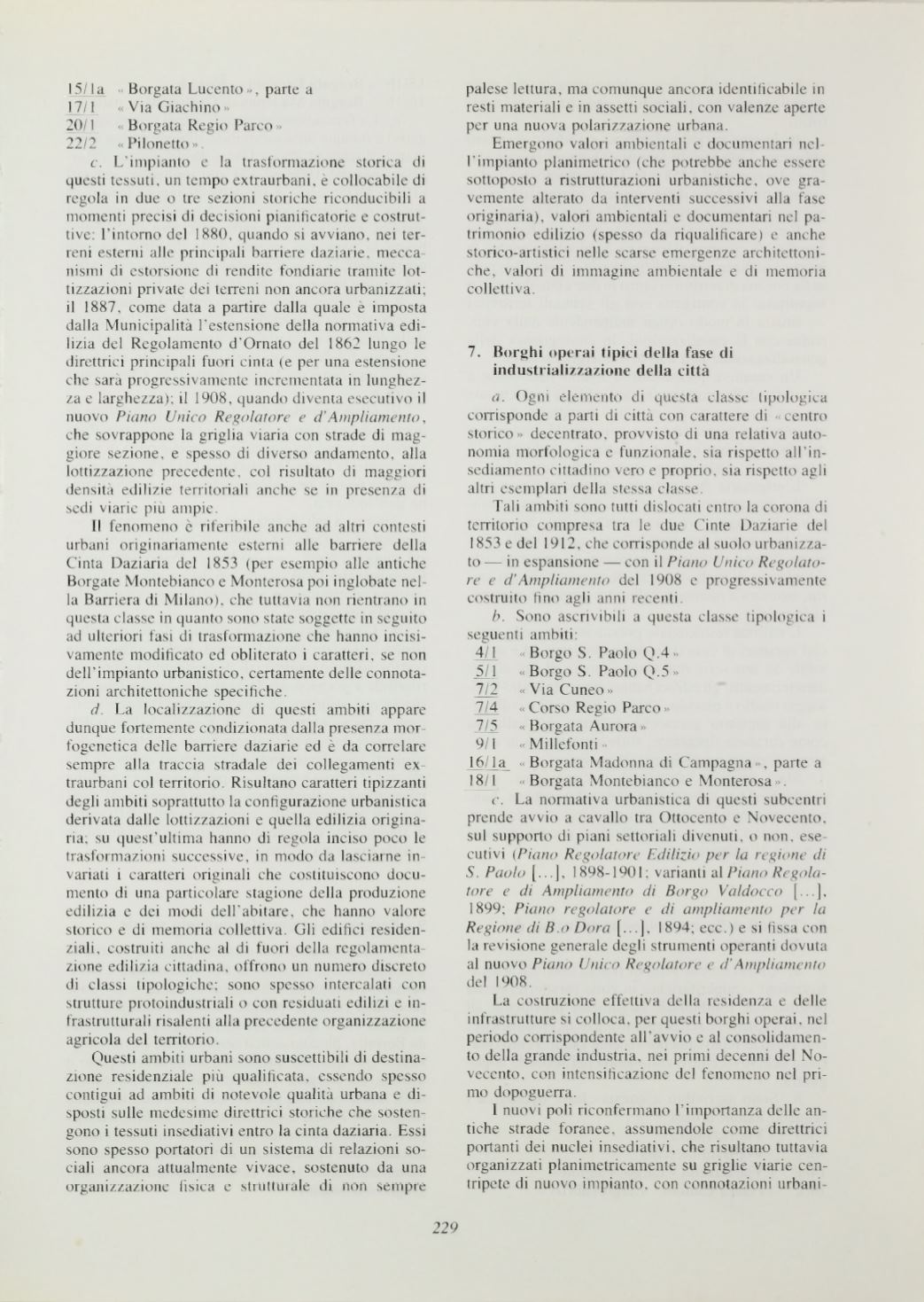
151l a
« Borgata Lucento », parte a
17/1
« Via Giachino
20/1
« Borgata Regio Parco »
22/2 « Pilonetto
» .
c. L'impianto e la trasformazione storica di
questi tessuti, un tempo extraurbani, è collocabile di
regola in due o tre sezioni storiche riconducibili a
momenti precisi di decisioni pianificatone e costrut-
tive: l'intorno del 1880, quando si avviano, nei ter-
reni esterni alle principali barriere daziarie, mecca-
nismi di estorsione di rendite fondiarie tramite lot-
tizzazioni private dei terreni non ancora urbanizzati;
il 1887, come data a partire dalla quale è imposta
dalla Municipalità l'estensione della normativa edi-
lizia del Regolamento d'Ornato del 1862 lungo le
direttrici principali fuori cinta (e per una estensione
che sarà progressivamente incrementata in lunghez-
za e larghezza); il 1908, quando diventa esecutivo il
nuovo
Piano Unico Regotatore e d'Amptiamento,
che sovrappone la griglia viaria con strade di mag-
giore sezione, e spesso di diverso andamento, alla
lottizzazione precedente, col risultato di maggiori
densità edilizie territoriali anche se in presenza di
sedi viarie più ampie.
Il fenomeno è riferibile anche ad altri contesti
urbani originariamente esterni alle barriere della
Cinta Daziaria del 1853 (per esempio alle antiche
Borgate Montebianco e Monterosa poi inglobate nel-
la Barriera di Milano), che tuttavia non rientrano in
questa classe in quanto sono state soggette in seguito
ad ulteriori fasi di trasformazione che hanno incisi-
vamente modificato ed obliterato i caratteri, se non
dell'impianto urbanistico, certamente delle connota-
zioni architettoniche specifiche.
d. La localizzazione di questi ambiti appare
dunque fortemente condizionata dalla presenza mor-
fogenetica delle barriere daziarie ed è da correlare
sempre alla traccia stradale dei collegamenti ex-
traurbani col territorio. Risultano caratteri tipizzanti
degli ambiti soprattutto la configurazione urbanistica
derivata dalle lottizzazioni e quella edilizia origina-
ria; su quest'ultima hanno di regola inciso poco le
trasformazioni successive, in modo da lasciarne in-
variati i caratteri originali che costituiscono docu-
mento di una particolare stagione della produzione
edilizia e dei modi dell'abitare, che hanno valore
storico e di memoria collettiva. Gli edifici residen-
ziali, costruiti anche al di fuori della regolamenta-
zione edilizia cittadina, offrono un numero discreto
di classi tipologiche; sono spesso intercalati con
strutture protoindustriali o con residuati edilizi e in-
frastrutturali risalenti alla precedente organizzazione
agricola del territorio.
Questi ambiti urbani sono suscettibili di destina-
zione residenziale più qualificata, essendo spesso
contigui ad ambiti di notevole qualità urbana e di-
sposti sulle medesime direttrici storiche che sosten-
gono i tessuti insediativi entro la cinta daziaria. Essi
sono spesso portatori di un sistema di relazioni so-
ciali ancora attualmente vivace, sostenuto da una
organizzazione fisica e strutturale di non sempre
palese lettura, ma comunque ancora identificabile in
resti materiali e in assetti sociali, con valenze aperte
per una nuova polarizzazione urbana.
Emergono valori ambientali e documentari nel-
l'impianto planimetrico (che potrebbe anche essere
sottoposto a ristrutturazioni urbanistiche, ove gra-
vemente alterato da interventi successivi alla fase
originaria), valori ambientali e documentar nel pa-
trimonio edilizio (spesso da riqualificare) e anche
storico-artistici nelle scarse emergenze architettoni-
che, valori di immagine ambientale e di memoria
collettiva.
7. Borghi operai tipici della fase di
industrializzazione della città
a. Ogni elemento di questa classe tipologica
corrisponde a parti di città con carattere di « centro
storico» decentrato, provvisto di una relativa auto-
nomia morfologica e funzionale, sia rispetto all'in-
sediamento cittadino vero e proprio, sia rispetto agli
altri esemplari della stessa classe.
Tali ambiti sono tutti dislocati entro la corona di
territorio compresa tra le due Cinte Daziarie del
1853 e del 1912, che corrisponde al suolo urbanizza-
to — in espansione — con il
Piano Unico Regotato-
re e d'Amptiamento
del 1908 e progressivamente
costruito fino agli anni recenti.
b. Sono ascrivibili a questa classe tipologica i
seguenti ambiti:
4/I
« Borgo S. Paolo Q.4
5/1
« Borgo S. Paolo Q.5 »
7/2
« Via Cuneo »
7/4
« Corso Regio Parco
7/5
« Borgata Aurora »
9/I « Millefonti »
16/1a
« Borgata Madonna di Campagna », parte a
181I
«Borgata Montebianco e Monterosa
».
c.
La normativa urbanistica di questi subcentri
prende avvio a cavallo tra Ottocento e Novecento,
sul supporto di piani settoriali divenuti, o non, ese-
cutivi
(Piano Regolatore Editizio per la regione di
S. Paoto [...],
1898-I90I; varianti al
Piano Regota-
tore e di Amptiamento di Borgo Valdocco
[...],
1899;
Piano regolatore e di ampliamento per ta
Regione di B.o Dora [...],
1894; ecc.) e si fissa con
la revisione generale degli strumenti operanti dovuta
al nuovo
Piano Unico Regotatore e d'Amptiamento
del
1908.
La costruzione effettiva della residenza e delle
infrastrutture si colloca, per questi borghi operai, nel
periodo corrispondente all'avvio e al consolidamen-
to della grande industria, nei primi decenni del No-
vecento, con intensificazione del fenomeno nel pri-
mo dopoguerra.
I nuovi poli riconfermano l'importanza delle an-
tiche strade foranee, assumendole come direttrici
portanti dei nuclei insediativi, che risultano tuttavia
organizzati planimetricamente su griglie viarie cen-
tripete di nuovo impianto, con connotazioni urbani-
229


















