
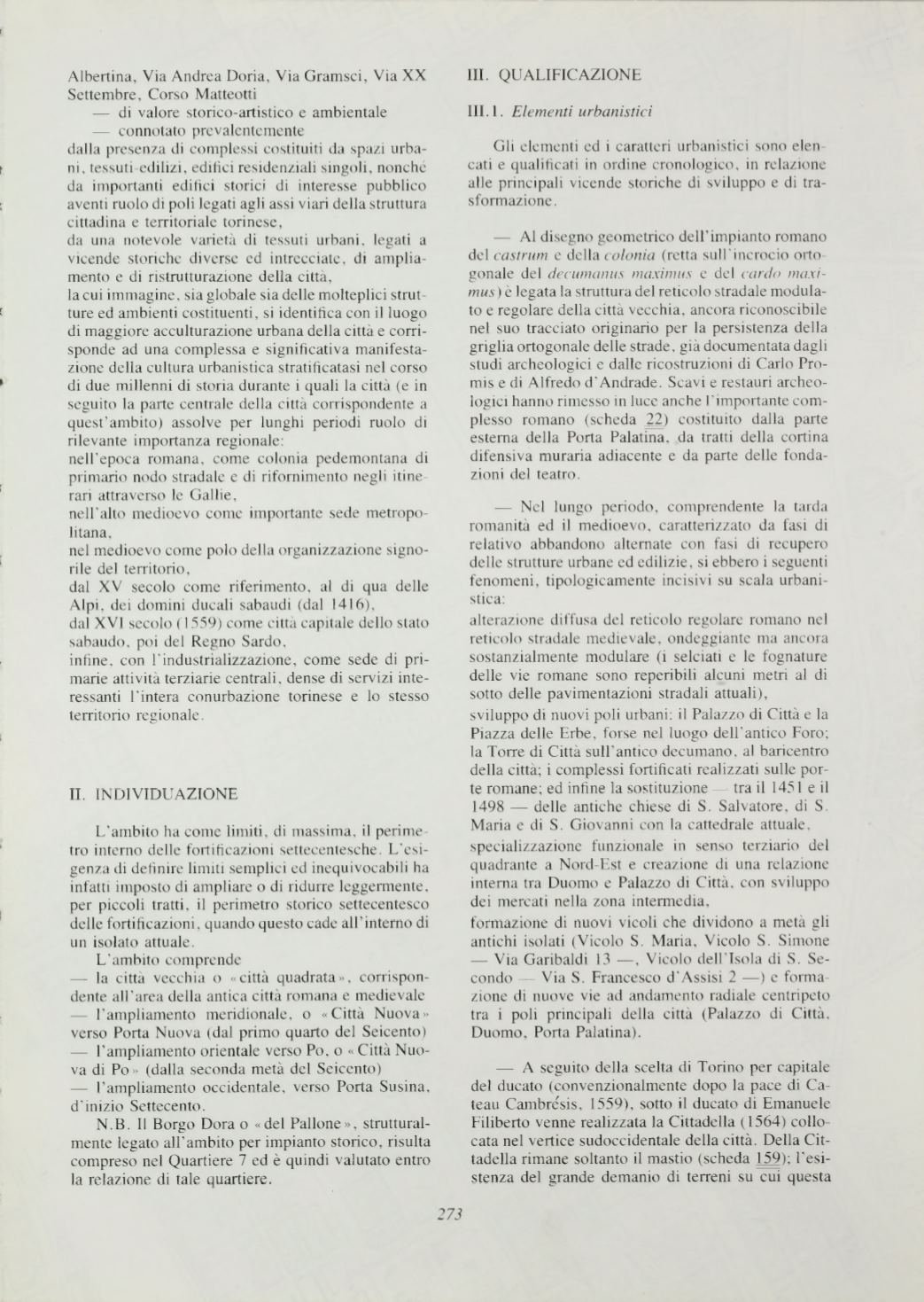
Albertina, Via Andrea Doria, Via Gramsci, Via XX
Settembre, Corso Matteotti
— di valore storico-artistico e ambientale
- connotato prevalentemente
dalla presenza di complessi costituiti da spazi urba-
ni, tessuti-edilizi, edifici residenziali singoli, nonché
da importanti edifici storici di interesse pubblico
aventi ruolo di poli legati agli assi viari della struttura
cittadina e territoriale torinese,
da una notevole varietà di tessuti urbani, legati a
vicende storiche diverse ed intrecciate, di amplia-
mento e di ristrutturazione della città,
la cui immagine, sia globale sia delle molteplici strut-
ture ed ambienti costituenti, si identifica con il luogo
di maggiore acculturazione urbana della città e corri-
sponde ad una complessa e significativa manifesta-
zione della cultura urbanistica stratificatasi nel corso
di due millenni di storia durante i quali la città (e in
seguito la parte centrale della città corrispondente a
quest'ambito) assolve per lunghi periodi ruolo di
rilevante importanza regionale:
nell'epoca romana, come colonia pedemontana di
primario nodo stradale e di rifornimento negli itine-
rari attraverso le Gallie,
nell'alto medioevo come importante sede metropo-
litana,
nel medioevo come polo della organizzazione signo-
rile del territorio,
dal XV secolo come riferimento, al di qua delle
Alpi, dei domini ducali sabaudi (dal 1416),
dal XVI secolo (1559) come città capitale dello stato
sabaudo, poi del Regno Sardo,
infine, con l'industrializzazione, come sede di pri-
marie attività terziarie centrali, dense di servizi inte-
ressanti l'intera conurbazione torinese e lo stesso
territorio regionale.
II. INDIVIDUAZIONE
L'ambito ha come limiti, di massima, il perime-
tro interno delle fortificazioni settecentesche. L'esi-
genza di definire limiti semplici ed inequivocabili ha
infatti imposto di ampliare o di ridurre leggermente,
per piccoli tratti, il perimetro storico settecentesco
delle fortificazioni, quando questo cade all'interno di
un isolato attuale.
L'ambito comprende
— la città vecchia o « città quadrata», corrispon-
dente all'area della antica città romana e medievale
- l'ampliamento meridionale, o « Città Nuova »
verso Porta Nuova (dal primo quarto del Seicento)
l'ampliamento orientale verso Po, o « Città Nuo-
va di Po» (dalla seconda metà del Seicento)
- l'ampliamento occidentale, verso Porta Susina,
d'inizio Settecento.
N.B. Il Borgo Dora o « del Pallone » , struttural-
mente legato all'ambito per impianto storico, risulta
compreso nel Quartiere 7 ed
è
quindi valutato entro
la relazione di tale quartiere.
III. QUALIFICAZIONE
I11.1. Etementi urbanistici
Gli elementi ed i caratteri urbanistici sono elen-
cati e qualificati in ordine cronologico, in relazione
alle principali vicende storiche di sviluppo e di tra-
sformazione.
- Al disegno geometrico dell'impianto romano
del
castrum
e della
colonia
(retta sull'incrocio orto-
gonale del
decumanus rnaximus
e del
cardo maxi-
mus) è
legata la struttura del reticolo stradale modula-
to e regolare della città vecchia, ancora riconoscibile
nel suo tracciato originario per la persistenza della
griglia ortogonale delle strade, già documentata dagli
studi archeologici e dalle ricostruzioni di Carlo Pro-
mis e di Alfredo d'Andrade. Scavi e restauri archeo-
logici hanno rimesso in luce anche l'importante com-
plesso romano (scheda
22)
costituito dalla parte
esterna della Porta Palatina, da tratti della cortina
difensiva muraria adiacente e da parte delle fonda-
zioni del teatro.
- Nel lungo periodo, comprendente la tarda
romanità ed il medioevo, caratterizzato da fasi di
relativo abbandono alternate con fasi di recupero
delle strutture urbane ed edilizie, si ebbero i seguenti
fenomeni, tipologicamente incisivi su scala urbani-
stica:
alterazione diffusa del reticolo regolare romano nel
reticolo stradale medievale, ondeggiante ma ancora
sostanzialmente modulare (i selciati e le fognature
delle vie romane sono reperibili alcuni metri al di
sotto delle pavimentazioni stradali attuali),
sviluppo di nuovi poli urbani: il Palazzo di Città e la
Piazza delle Erbe, forse nel luogo dell'antico Foro;
la Torre di Città sull'antico decumano, al baricentro
della città; i complessi fortificati realizzati sulle por-
te romane; ed infine la sostituzione — tra il 1451 e il
1498 delle antiche chiese di S. Salvatore, di S.
Maria e di S. Giovanni con la cattedrale attuale,
specializzazione funzionale in senso terziario del
quadrante a Nord-Est e creazione di una relazione
interna tra Duomo e Palazzo di Città, con sviluppo
dei mercati nella zona intermedia,
formazione di nuovi vicoli che dividono a metà gli
antichi isolati (Vicolo S. Maria, Vicolo S. Simone
Via Garibaldi 13 —, Vicolo dell'Isola di S. Se-
condo — Via S. Francesco d'Assisi 2 —) e forma-
zione di nuove vie ad andamento radiale centripeto
tra i poli principali della città (Palazzo di Città,
Duomo, Porta Palatina).
- A seguito della scelta di Torino per capitale
del ducato (convenzionalmente dopo la pace di Ca-
teau Cambrésis, 1559), sotto il ducato di Emanuele
Filiberto venne realizzata la Cittadella (1564) collo-
cata nel vertice sudoccidentale della città. Della Cit-
tadella rimane soltanto il mastio (scheda
159);
l'esi-
stenza del grande demanio di terreni su cui questa
273


















