
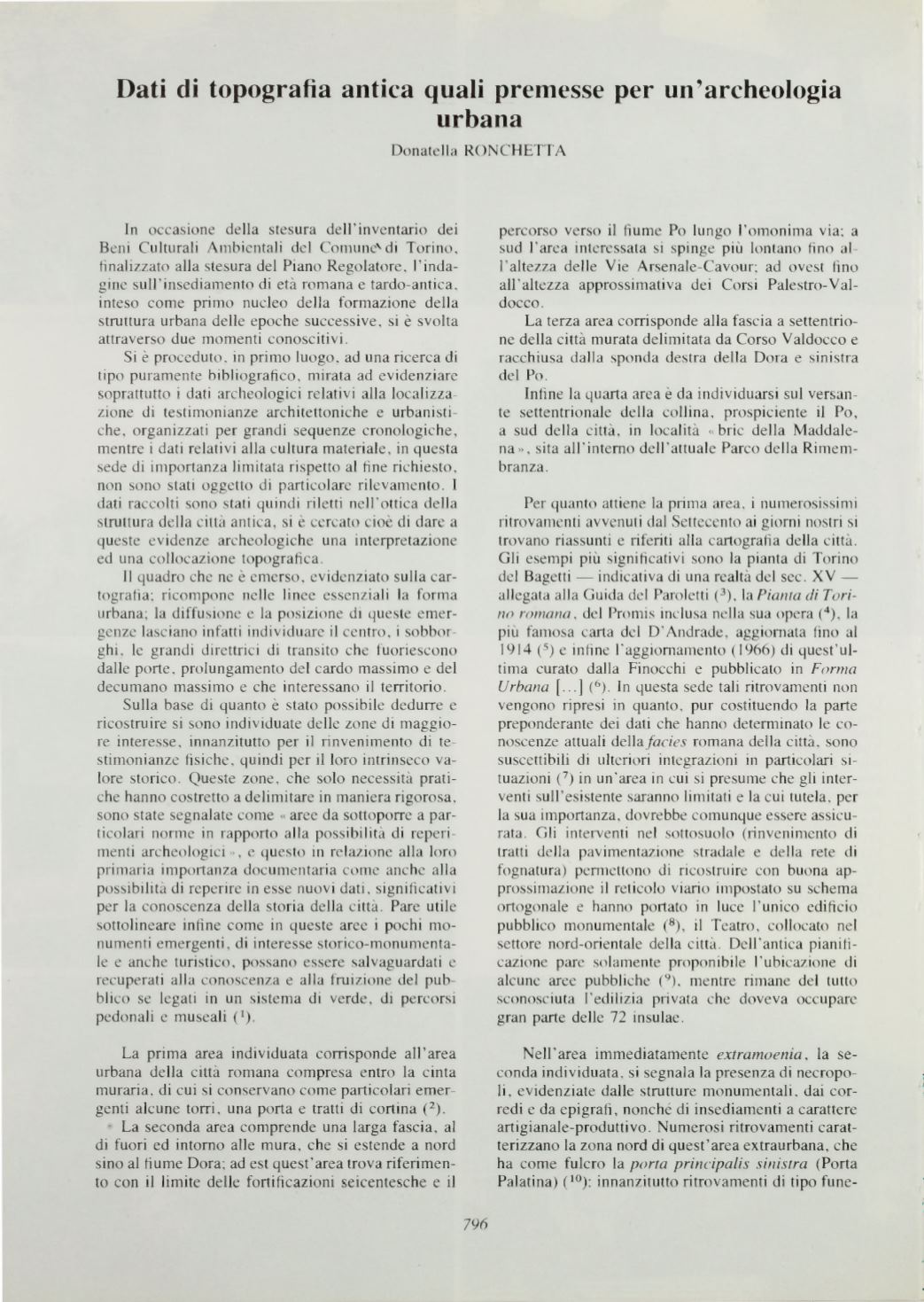
Dati di topografia antica quali premesse per un'archeologia
urbana
Donatella RONCHETTA
In occasione della stesura dell'inventario dei
Beni Culturali Ambientali del Comune' di Torino,
finalizzato alla stesura del Piano Regolatore, l'inda-
gine sull'insediamento di età romana e tardo-antica,
inteso come primo nucleo della formazione della
struttura urbana delle epoche successive, si
è
svolta
attraverso due momenti conoscitivi.
Si è proceduto, in primo luogo, ad una ricerca di
tipo puramente bibliografico, mirata ad evidenziare
soprattutto i dati archeologici relativi alla localizza-
zione di testimonianze architettoniche e urbanisti-
che, organizzati per grandi sequenze cronologiche,
mentre i dati relativi alla cultura materiale, in questa
sede di importanza limitata rispetto al fine richiesto,
non sono stati oggetto di particolare rilevamento. I
dati raccolti sono stati quindi riletti nell'ottica della
struttura della città antica, si
è
cercato cioè di dare a
queste evidenze archeologiche una interpretazione
ed una collocazione topografica.
Il quadro che ne
è
emerso, evidenziato sulla car-
tografia; ricompone nelle linee essenziali la forma
urbana; la diffusione e la posizione di queste emer-
genze lasciano infatti individuare il centro, i sobbor-
ghi. le grandi direttrici di transito che fuoriescono
dalle porte, prolungamento del cardo massimo e del
decumano massimo e che interessano il territorio.
Sulla base di quanto è stato possibile dedurre e
ricostruire si sono individuate delle zone di maggio-
re interesse, innanzitutto per il rinvenimento di te-
stimonianze fisiche, quindi per il loro intrinseco va-
lore storico. Queste zone, che solo necessità prati-
che hanno costretto a delimitare in maniera rigorosa,
sono state segnalate come « aree da sottoporre a par-
ticolari norme in rapporto alla possibilità di reperi-
menti archeologici «, e questo in relazione alla loro
primaria importanza documentaria come anche alla
possibilità di reperire in esse nuovi dati, significativi
per la conoscenza della storia della città. Pare utile
sottolineare infine come in queste aree i pochi mo-
numenti emergenti, di interesse storico-monumenta-
le e anche turistico, possano essere salvaguardati
e
recuperati alla conoscenza e alla fruizione del pub-
blico se legati in un sistema di verde, di percorsi
pedonali e museali (
1
).
La prima area individuata corrisponde all'area
urbana della città romana compresa entro la cinta
muraria, di cui si conservano come particolari emer-
genti alcune torri, una porta e tratti di cortina (
2
).
La seconda area comprende una larga fascia, al
di fuori ed intorno alle mura, che si estende a nord
sino al fiume Dora; ad est quest'area trova riferimen-
to con il limite delle fortificazioni seicentesche e il
percorso verso il fiume Po lungo l'omonima via; a
sud l'area interessata si spinge più lontano fino al-
l'altezza delle Vie Arsenale-Cavour; ad ovest fino
all'altezza approssimativa dei Corsi Palestro-Val-
docco.
La terza area corrisponde alla fascia a settentrio-
ne della città murata delimitata da Corso Valdocco e
racchiusa dalla sponda destra della Dora e sinistra
del Po.
Infine la quarta area è da individuarsi sul versan-
te settentrionale della collina, prospiciente il Po,
a sud della città, in località « bric della Maddale-
na», sita all'interno dell'attuale Parco della Rimem-
branza.
Per quanto attiene la prima area, i numerosissimi
ritrovamenti avvenuti dal Settecento ai giorni nostri si
trovano riassunti e riferiti alla cartografia della città.
Gli esempi più significativi sono la pianta di Torino
del Bagetti indicativa di una realtà del sec. XV —
allegata alla Guida del Paroletti (
3
), la
Pianta di Tori-
no romana,
del Promis inclusa nella sua opera (
4
), la
più famosa carta del D'Andrade, aggiornata fino al
1914 (
5
) e infine l'aggiornamento (1966) di quest'ul-
tima curato dalla Finocchi e pubblicato in
Forma
Urbana [...1
(
6
). In questa sede tali ritrovamenti non
vengono ripresi in quanto, pur costituendo la parte
preponderante dei dati che hanno determinato le co-
noscenze attuali della
facies
romana della città, sono
suscettibili di ulteriori integrazioni in particolari si-
tuazioni (
7
) in un'area in cui si presume che gli inter-
venti sull'esistente saranno limitati e la cui tutela, per
la sua importanza, dovrebbe comunque essere assicu-
rata. Gli interventi nel sottosuolo (rinvenimento di
tratti della pavimentazione stradale e della rete di
fognatura) permettono di ricostruire con buona ap-
prossimazione il reticolo viario impostato su schema
ortogonale e hanno portato in luce l'unico edificio
pubblico monumentale (
8
), il Teatro, collocato nel
settore nord-orientale della città. Dell'antica pianifi-
cazione pare solamente proponibile l'ubicazione di
alcune aree pubbliche (
9
), mentre rimane del tutto
sconosciuta l'edilizia privata che doveva occupare
gran parte delle 72 insulae.
Nell'area immediatamente
extramoenia,
la se-
conda individuata, si segnala la presenza di necropo-
li, evidenziate dalle strutture monumentali, dai cor-
redi e da epigrafi, nonché di insediamenti a carattere
artigianale-produttivo. Numerosi ritrovamenti carat-
terizzano la zona nord di quest'area extraurbana, che
ha come fulcro la
porta principalis sinistra
(Porta
Palatina) (
10
): innanzitutto ritrovamenti di tipo fune-
796


















