
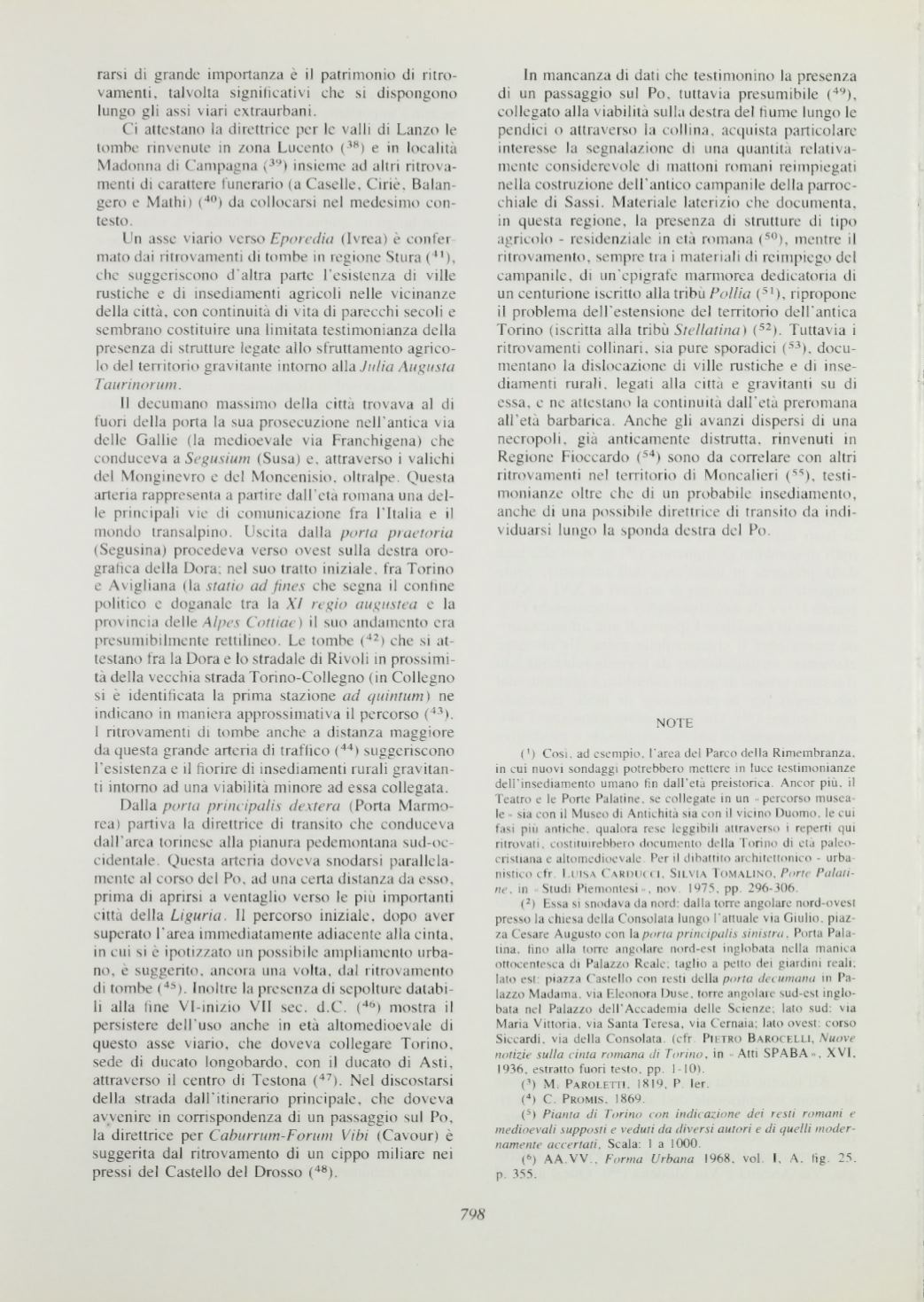
rarsi di grande importanza è il patrimonio di ritro-
vamenti, talvolta significativi che si dispongono
lungo gli assi viari extraurbani.
Ci attestano la direttrice per le valli di Lanzo le
tombe rinvenute in zona Lucento
(
38
) e in località
Madonna di Campagna
(
39
) insieme ad altri ritrova-
menti di carattere funerario (a Caselle, Ciriè, Balan-
gero e Mathi)
(
40
) da collocarsi nel medesimo con-
testo.
Un asse viario verso
Eporedia
(Ivrea) è confer-
mato dai ritrovamenti di tombe in regione Stura
(41),
che suggeriscono d'altra parte l'esistenza di ville
rustiche e di insediamenti agricoli nelle vicinanze
della città, con continuità di vita di parecchi secoli e
sembrano costituire una limitata testimonianza della
presenza di strutture legate allo sfruttamento agrico-
lo del territorio gravitante intorno alla
Jtltia Augusta
Taurinorum.
Il decumano massimo della città trovava al di
fuori della porta la sua prosecuzione nell'antica via
delle Gallie (la medioevale via Franchigena) che
conduceva a
Segusium
(Susa) e, attraverso i valichi
del Monginevro e del Moncenisio, oltralpe. Questa
arteria rappresenta a partire dall'età romana una del-
le principali vie di comunicazione fra l'Italia e il
mondo transalpino. Uscita dalla
porta praetoria
(Segusina) procedeva verso ovest sulla destra oro-
grafica della Dora; nel suo tratto iniziale, fra Torino
e Avigliana (la
statio ad fines
che segna il confine
politico e doganale tra la
XI regio augustea
e la
provincia delle
Atpes Cottiae)
il suo andamento era
presumibilmente rettilineo. Le tombe
(
42
) che si at-
testano fra la Dora e lo stradale di Rivoli in prossimi-
tà della vecchia strada Torino-Collegno (in Collegno
si è identificata la prima stazione
ad quintum)
ne
indicano in maniera approssimativa il percorso
(
43
)
I ritrovamenti di tombe anche a distanza maggiore
da questa grande arteria di traffico
(
44
) suggeriscono
l'esistenza e il fiorire di insediamenti rurali gravitan-
ti intorno ad una viabilità minore ad essa collegata.
Dalla
porta principalis dextera
(Porta Marmo-
rea) partiva la direttrice di transito che conduceva
dall'area torinese alla pianura pedemontana sud-oc-
cidentale. Questa arteria doveva snodarsi parallela-
mente al corso del Po, ad una certa distanza da esso,
prima di aprirsi a ventaglio verso le più importanti
città della
Liguria.
Il percorso iniziale, dopo aver
superato l'area immediatamente adiacente alla cinta,
in cui si è ipotizzato un possibile ampliamento urba-
no, è suggerito, ancora una volta, dal ritrovamento
di tombe
(
45
). Inoltre la presenza di sepolture databi-
li alla fine VI-inizio VII sec. d.C.
(
46
) mostra il
persistere dell'uso anche in età altomedioevale di
questo asse viario, che doveva collegare Torino,
sede di ducato longobardo, con il ducato di Asti,
attraverso il centro di Testona
(
47
). Nel discostarsi
della strada dall'itinerario principale, che doveva
avvenire in corrispondenza di un passaggio sul Po,
la direttrice per
Caburrum-Forum Vibi
(Cavour) è
suggerita dal ritrovamento di un cippo miliare nei
pressi del Castello del Drosso
(48).
In mancanza di dati che testimonino la presenza
di un passaggio sul Po, tuttavia presumibile
(
49
),
collegato alla viabilità sulla destra del fiume lungo le
pendici o attraverso la collina, acquista particolare
interesse la segnalazione di una quantità relativa-
mente considerevole di mattoni romani reimpiegati
nella costruzione dell'antico campanile della parroc-
chiale di Sassi. Materiale laterizio che documenta,
in questa regione, la presenza di strutture di tipo
agricolo - residenziale in età romana
(
50
), mentre il
ritrovamento, sempre tra i materiali di reimpiego del
campanile, di un'epigrafe marmorea dedicatoria di
un centurione iscritto alla tribù
Potlia
(
51
),
ripropone
il problema dell'estensione del territorio dell'antica
Torino (iscritta alla tribù
Stettatina)
(
52
). Tuttavia i
ritrovamenti collinari, sia pure sporadici
(
53
), docu-
mentano la dislocazione di ville rustiche e di inse-
diamenti rurali, legati alla città e gravitanti su di
essa, e ne attestano la continuità dall'età preromana
all'età barbarica. Anche gli avanzi dispersi di una
necropoli, già anticamente distrutta, rinvenuti in
Regione Fioccardo
(
54
) sono da correlare con altri
ritrovamenti nel territorio di Moncalieri
(
55
), testi-
monianze oltre che di un probabile insediamento,
anche di una possibile direttrice di transito da indi-
viduarsi lungo la sponda destra del Po.
NOTE
(1) Così, ad esempio, l'area del Parco della Rimembranza,
in cui nuovi sondaggi potrebbero mettere in luce testimonianze
dell'insediamento umano fin dall'età preistorica. Ancor più, il
Teatro e le Porte Palatine, se collegate in un percorso musea-
le „ sia con il Museo di Antichità sia con il vicino Duomo, le cui
fasi più antiche, qualora rese leggibili attraverso i reperti qui
ritrovati, costituirebbero documento della Torino di età paleo-
cristiana e altomedioevale. Per il dibattito architettonico - urba-
nistico cfr. LUISA CARDUCCI, SILVIA TOMALINO,
Porte Palati-
ne,
in .< Studi Piemontesi», nov. 1975, pp. 296-306.
(2) Essa si snodava da nord: dalla torre angolare nord-ovest
presso la chiesa della Consolata lungo l'attuale via Giulio, piaz-
za Cesare Augusto con la
porta principalis sinistra.
Porta Pala-
tina, fino alla torre angolare nord-est inglobata nella manica
ottocentesca di Palazzo Reale; taglio a petto dei giardini reali;
lato est: piazza Castello con resti della
porta decumana
in Pa-
lazzo Madama. via Eleonora Duse, torre angolare sud-est inglo-
bata nel Palazzo dell'Accademia delle Scienze; lato sud: via
Maria Vittoria, via Santa Teresa, via Cernaia; lato ovest: corso
Siccardi, via della Consolata. (cfr. PIETRO BAROCELLI,
Nuove
notizie sulla cinta romana di Torino,
in <Atti SPABA , XVI,
1936, estratto fuori testo, pp. I -10).
(3) M. PAROLETTI, 1819, P. ler.
(4) C. PROMIS, 1869.
(5) Pianta di Torino con indicazione dei resti romani e
medioevati supposti e veduti da diversi autori e di quelli moder-
namente accertati,
Scala: I a 1000.
(6)
AA.VV.,
Forma Urbana
1968, vol. I, A, fig. 25.
p. 355.
798


















