
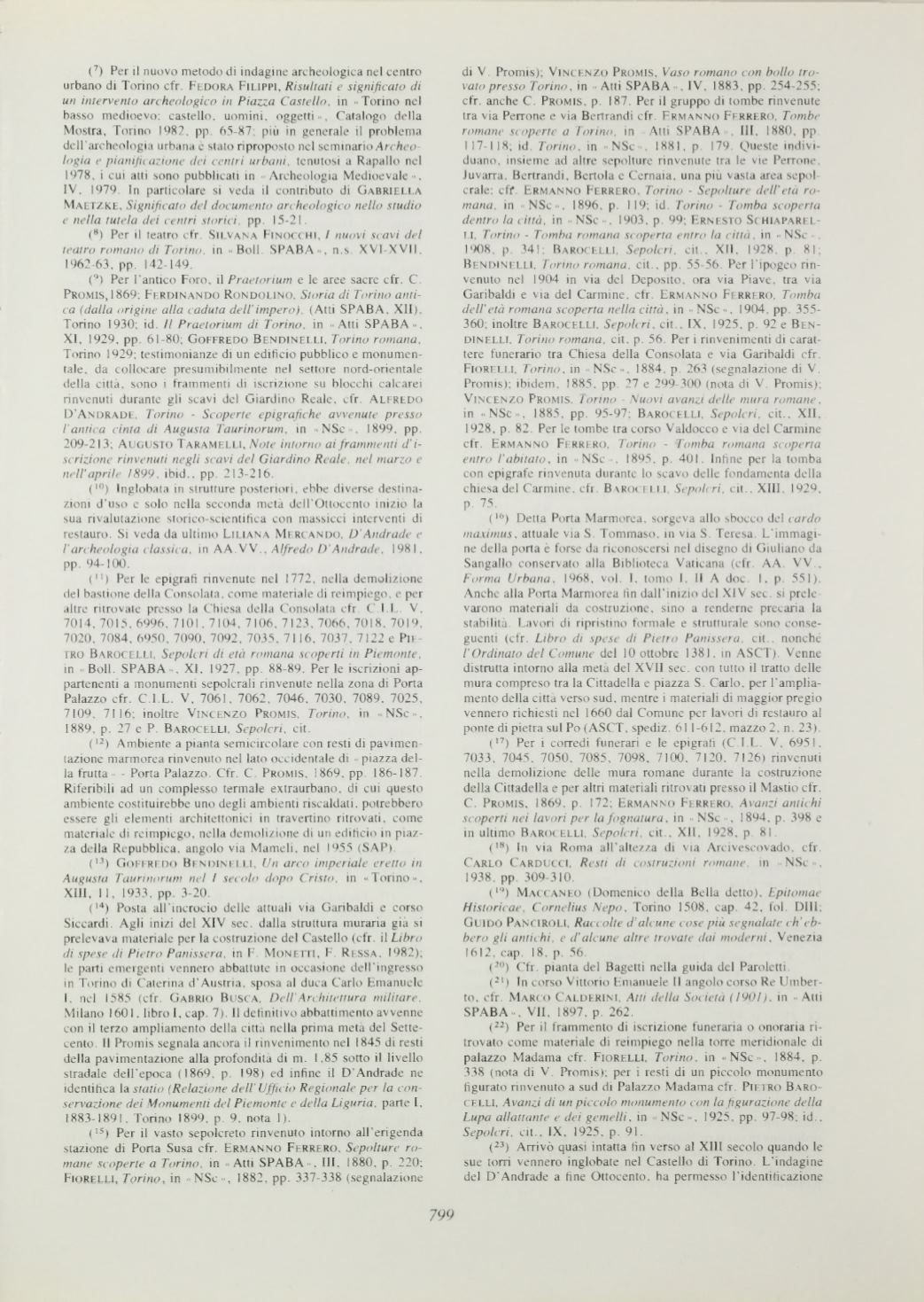
(7) Per il nuovo metodo di indagine archeologica nel centro
urbano di Torino cfr.
FEDORA FILIPPI,
Risultati e significato di
un intervento archeotogico in Piazza Castello,
in « Torino nel
basso medioevo: castello, uomini, oggetti», Catalogo della
Mostra, Torino 1982, pp. 65-87; più in generale il problema
dell'archeologia urbana è stato riproposto nel seminario
Archeo-
logia e pianificazione dei ceniri urbani,
tenutosi a Rapallo nel
1978, i cui atti sono pubblicati in Archeologia Medioevale
IV, 1979. In particolare si veda il contributo di
GABRIELLA
MAETZKE,
Significato del documento archeologico nello studio
e nella tutela dei centri storici,
pp. 15-21.
(8) Per il teatro cfr.
SILVANA FINOCCHI,
I nuovi scavi del
teatro romano di Torino,
in 'Boll. SPABA
,
n.s. XVI-XVII,
1962-63, pp. 142-149.
(
9
) Per l'antico Foro, il
Praetorium
e le aree sacre cfr. C.
PROMIS,1869;
FERDINANDO RONDOLINO,
Storia di Torino anti-
ca (datla origine alla caduta detl'impero),
(Atti SPABA, XII),
Torino 1930; id.
Il Praetorium di Torino,
in « Atti SPABA
» ,
XI, 1929, pp. 61-80;
GOFFREDO BENDINELLI,
Torino romana,
Torino 1929; testimonianze di un edificio pubblico e monumen-
tale, da collocare presumibilmente nel settore nord-orientale
della città, sono i frammenti di iscrizione su blocchi calcarei
rinvenuti durante gli scavi del Giardino Reale, cfr.
ALFREDO
D'ANDRADE,
Torino - Scoperte epigrafiche avvenute presso
l'antica cinta di Augusta Taurinorum,
in « NSc ,. , 1899, pp.
209-213; AUGUSTO
TARAMELLI,
Note intorno ai frammenti d'i-
scrizione rinvenuti negli scavi del Giardino Reale, nel marzo e
nell'aprile 1899,
ibid., pp. 213-216.
(lo) Inglobata in strutture posteriori, ebbe diverse destina-
zioni d'uso e solo nella seconda metà dell'Ottocento iniziò la
sua rivalutazione storico-scientifica con massicci interventi di
restauro. Si veda da
ultimo LILIANA MERCANDO,
D'Andrade e
l'archeologia classica,
in
AA.VV.,
Alfredo D'Andrade,
1981,
pp. 94-100.
(") Per le epigrafi rinvenute nel 1772, nella demolizione
del bastione della Consolata, come materiale di reimpiego, e per
altre ritrovate presso la Chiesa della Consolata cfr. C.I.L. V,
7014, 7015, 6996, 7101, 7104, 7106, 7123, 7066, 7018, 7019,
7020, 7084, 6950, 7090, 7092, 7035, 7116, 7037, 7122 e
PIE-
TRO BAROCELLI,
Sepolcri di età romana scoperti in Piemonte,
in « Boll. SPABA XI, 1927, pp. 88-89. Per le iscrizioni ap-
partenenti a monumenti sepolcrali rinvenute nella zona di Porta
Palazzo cfr. C.I.L. V, 7061, 7062, 7046, 7030, 7089, 7025,
7109, 7116; inoltre
VINCENZO PROMIS,
Torino,
in «NSc
»,
1889, p. 27 e P.
BAROCELLI,
Sepolcri,
cit.
(12) Ambiente a pianta semicircolare con resti di pavimen-
tazione marmorea rinvenuto nel lato occidentale di <. piazza del-
la frutta .. - Porta Palazzo. Cfr. C.
PROMIS,
1869, pp. 186-187.
Riferibili ad un complesso termale extraurbano, di cui questo
ambiente costituirebbe uno degli ambienti riscaldati, potrebbero
essere gli elementi architettonici in travertino ritrovati, come
materiale di reimpiego, nella demolizione di un edificio in piaz-
za della Repubblica, angolo via Mameli, nel 1955 (SAP).
(13) GOFFREDO BENDINELLI,
Un arco imperiale eretto in
Augusta Taurinorum nel I secoto dopo Cristo,
in «Torino
'.,
XIII, 11, 1933, pp. 3-20.
(14) Posta all'incrocio delle attuali via G
ar
ibaldi e corso
Siccardi. Agli inizi del XIV sec. dalla struttura muraria già si
prelevava materiale per la costruzione del Castello (cfr. il
Libro
di spese di Pietro Panissera,
in F.
MoNETTI,
F.
RESSA,
1982);
le parti emergenti vennero abbattute in occasione dell'ingresso
in Torino di Caterina d'Austria, sposa al duca Carlo Emanuele
I, nel 1585 (cfr.
GABRIo BUSCA,
Dell'Architettura militare,
Milano 1601, libro I, cap. 7). Il definitivo abbattimento avvenne
con il terzo ampliamento della città nella prima metà del Sette-
cento. Il Promis segnala ancora il rinvenimento nel 1845 di resti
della pavimentazione alla profondità di m. 1,85 sotto il livello
stradale dell'epoca (1869, p. 198) ed infine il D'Andrade ne
identifica la
statio (Relazione dell' Ufficio Regionale per la con-
servazione dei Monumenti del Piemonte e detla Liguria,
parte I,
1883-1891, Torino 1899, p. 9, nota 1).
(15) Per il vasto sepolcreto rinvenuto intorno all'erigenda
stazione di Porta Susa cfr.
ERMANNO FERRERO,
Sepolture ro-
mane
scoperte a Torino,
in Atti SPABA., III, 1880, p. 220;
FIORELLI,
Torino,
in «NSc.., 1882, pp. 337-338 (segnalazione
di V. Promis);
VINCENZO PRoMIS,
Vaso romano con botlo tro-
vato presso Torino, in «
Atti SPABA
,,
, IV, 1883, pp. 254-255;
cfr. anche C. PRoMIs, p. 187. Per il gruppo di tombe rinvenute
tra via Perrone e via Bertrandi cfr.
ERMANNO FERRERO,
Tombe
romane scoperte a Torino,
in Atti SPABA», III, 1880, pp.
117-118; id.
Torino,
in «NSc. , 1881, p. 179. Queste indivi-
duano, insieme ad altre sepolture rinvenute tra le vie Perrone,
Juvarra, Bertrandi, Bertola e Cernaia, una più vasta area sepol-
crale:
Cff. ERMANNO FERRERO,
Torino - Sepotture dell'età ro-
mana,
in «NSc » , 1896, p. 119; id.
Torino - Tomba scoperta
dentro la città,
in «NSc 1903, p. 99;
ERNESTO SCHIAPAREL-
LI,
Torino - Tomba romana scoperta entro la città,
in «NSc
1908, p. 341;
BAROCELII,
Sepotcri,
cit., XII, 1928, p. 81;
BENDINELLI,
Torino romana,
cit., pp. 55-56. Per l'ipogeo rin-
venuto nel 1904 in via del Deposito, ora via Piave, tra via
G
ar
ibaldi e via del Carmine, cfr.
ERMANNO FERRERO,
Tomba
dell'età romana scoperta nella città,
in «NSc», 1904, pp. 355-
360; inoltre
BAROCELLI,
Sepotcri,
cit., IX, 1925, p. 92 e
BEN-
DINELLI,
Torino romana,
cit, p. 56. Per i rinvenimenti di carat-
tere funerario tra Chiesa della Consolata e via G
ar
ibaldi cfr.
FIORELLI,
Torino,
in «NSc», 1884, p. 263 (segnalazione di V.
Promis); ibidem, 1885, pp. 27 e 299-300 (nota di V. Promis);
VINCENZO PRoMIs,
Torino - Nuovi avanzi dette mura romane,
in «NSc», 1885, pp. 95-97;
BAROCELLI,
Sepolcri,
cit., XII,
1928, p. 82. Per le tombe tra corso Valdocco e via del C
ar
mine
cfr.
ERMANNO FERRERO,
Torino - Tomba romana scoperta
entro t'abitato,
in «NSc», 1895, p. 401. Infine per la tomba
con epigrafe rinvenuta durante lo scavo delle fondamenta della
chiesa del Carmine, cfr.
BAROCELLI,
Sepolcri,
cit., XIII, 1929,
p. 75.
(16) Detta Porta Marmorea, sorgeva allo sbocco del
cardo
inasitnus,
attuale via S. Tommaso, in via S. Teresa. L'immagi-
ne della porta è forse da riconoscersi nel disegno di Giuliano da
Sangallo conservato alla Biblioteca Vaticana (cfr. AA. VV.,
Forata Urbana.
1968, vol. I, tomo I, Il A doc. I , p. 551).
Anche alla Porta Marmorea fin dall'inizio del XIV sec. si prele-
varono materiali da costruzione, sino a renderne precaria la
stabilità. Lavori di ripristino formale e strutturale sono conse-
guenti (cfr.
Libro di spese di Pietro Panissera,
cit., nonché
t'Ordinato det Comune
del 10 ottobre 1381, in ASCT). Venne
distrutta intorno alla metà del XVII sec. con tutto il tratto delle
mura compreso tra la Cittadella e piazza S. Carlo, per l'amplia-
mento della città verso sud, mentre i materiali di maggior pregio
vennero richiesti nel 1660 dal Comune per lavori di restauro al
ponte di pietra sul Po (ASCT, spediz. 611-612, mazzo 2, n. 23).
(17) Per i corredi funerari e le epigrafi (C.I.L. V, 6951,
7033, 7045, 7050, 7085, 7098, 7100, 7120, 7126) rinvenuti
nella demolizione delle mura romane durante la costruzione
della Cittadella e per altri materiali ritrovati presso il Mastio cfr.
C.
PROMIS,
1869, p. 172;
ERMANNO FERRERO,
Avanzi antichi
scoperti nei tavori per la fognatura,
in <, NSc » , 1894, p. 398 e
in ultimo
BAROCELLI,
Sepolcri,
cit., XII, 1928, p. 81.
(18) In via Roma all'altezza di via Arcivescovado, cfr.
CARLO CARDUCCI,
Resti di costruzioni romane,
in « NSc
» ,
1938, pp. 309-310.
(19) MACCANEO
(Domenico della Bella detto),
Epitomae
Historicae, Cornelius Nepo,
Torino 1508, cap. 42, fol. DIII;
GUIDO PANCIROLI,
Raccotte d'alcune cose più segnalate ch'eb-
bero gli antichi, e d'alcune altre trovate dai moderni,
Venezia
1612, cap. 18, p. 56.
(20) Cfr. pianta del Bagetti nella guida del Paroletti.
(21) In corso Vittorio Emanuele II angolo corso Re Umber-
to, cfr.
MARCO CALDERINI,
Atti della Società (1901).
in «Atti
SPABA.., VII, 1897, p. 262.
(22) Per il frammento di iscrizione funeraria o onoraria ri-
trovato come materiale di reimpiego nella torre meridionale di
palazzo Madama cfr.
FIORELLI,
Torino,
in «NSc » , 1884, p.
338 (nota di V. Promis); per i resti di un piccolo monumento
figurato rinvenuto a sud di Palazzo Madama cfr.
PIETRO BARO-
CELLI,
Avanzi di un piccolo monumento con la figurazione detla
Lupa atlattante e dei gemelti, in «
NSc», 1925, pp. 97-98; id..
Sepolcri, cit.,
IX, 1925, p. 91.
(23) Arrivò quasi intatta fin verso al XIII secolo quando le
sue torri vennero inglobate nel Castello di Torino. L'indagine
del D'Andrade a fine Ottocento, ha permesso l'identificazione
799


















