
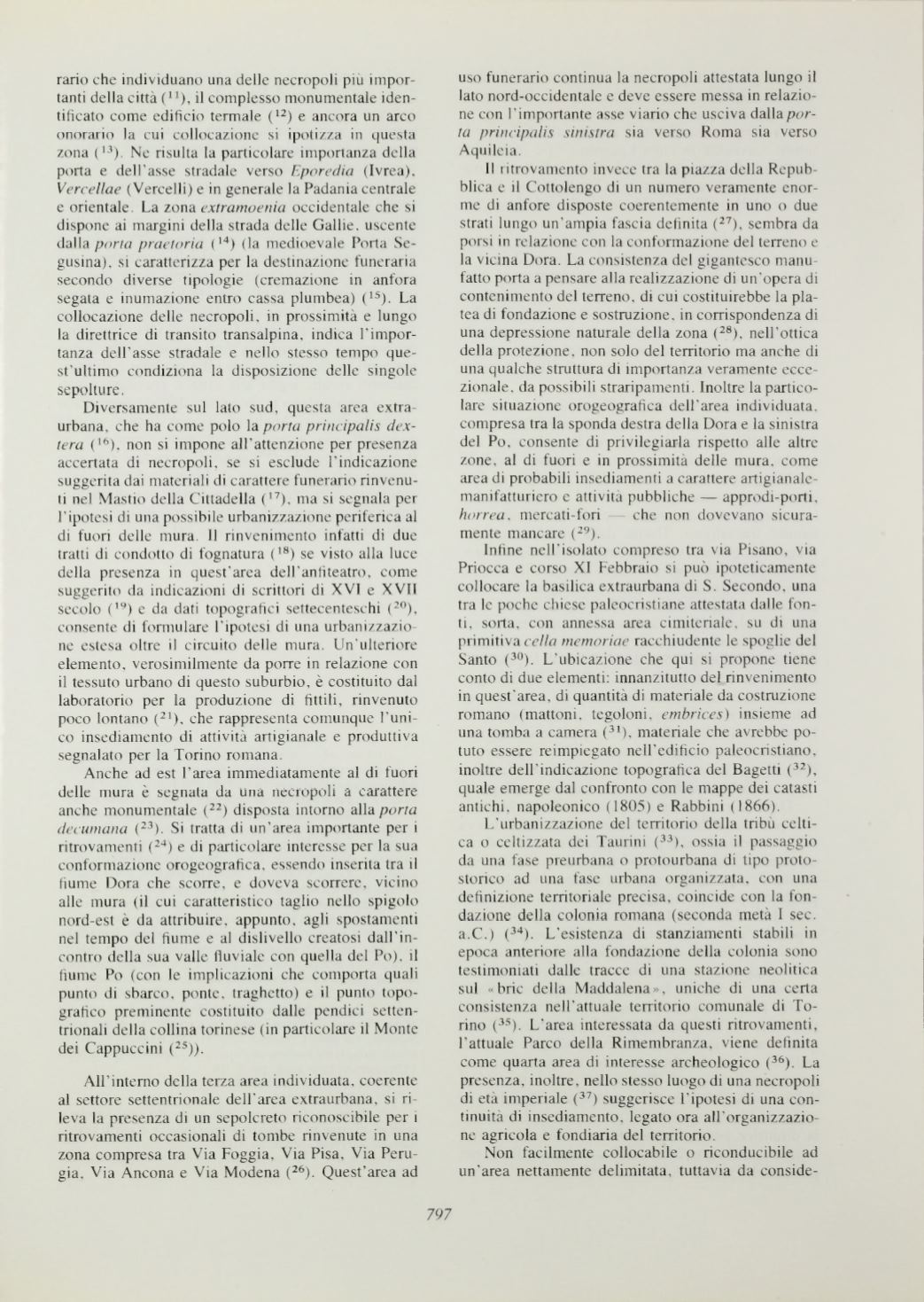
rario che individuano una delle necropoli più impor-
tanti della città (
11
), il complesso monumentale iden-
tificato come edificio termale
(12)
e ancora un arco
onorario la cui collocazione si ipotizza in questa
zona (
13
). Ne risulta la particolare importanza della
porta e dell'asse stradale verso
Eporedia
(Ivrea),
Verceltae
(Vercelli) e in generale la Padania centrale
e orientale. La zona
extramoenia
occidentale che si
dispone ai margini della strada delle Gallie, uscente
dalla
porta praetoria
(
14
) (la medioevale Porta Se-
gusina), si caratterizza per la destinazione funeraria
secondo diverse tipologie (cremazione in anfora
segata e inumazione entro cassa plumbea) (
15
). La
collocazione delle necropoli, in prossimità e lungo
la direttrice di transito transalpina, indica l'impor-
tanza dell'asse stradale e nello stesso tempo que-
st'ultimo condiziona la disposizione delle singole
sepolture.
Diversamente sul lato sud, questa area extra-
urbana, che ha come polo la
porta principatis dex-
tera
(
I6
), non si impone all'attenzione per presenza
accertata di necropoli, se si esclude l'indicazione
suggerita dai materiali di carattere funerario rinvenu-
ti nel Mastio della Cittadella (
17
), ma si segnala per
l'ipotesi di una possibile urbanizzazione periferica al
di fuori delle mura. Il rinvenimento infatti di due
tratti di condotto di fognatura (
18
) se visto alla luce
della presenza in quest'area dell'anfiteatro, come
suggerito da indicazioni di scrittori di XVI e XVII
secolo (
19
) e da dati topografici settecenteschi (
20
),
consente di formulare l'ipotesi di una urbanizzazio-
ne estesa oltre il circuito delle mura. Un'ulteriore
elemento, verosimilmente da porre in relazione con
il tessuto urbano di questo suburbio,
è
costituito dal
laboratorio per la produzione di fittili, rinvenuto
poco lontano (
21
), che rappresenta comunque l'uni-
co insediamento di attività artigianale e produttiva
segnalato per la Torino romana.
Anche ad est l'area immediatamente al di fuori
delle mura è segnata da una necropoli a carattere
anche monumentale (
22
) disposta intorno alla
porta
decumana (
23
).
Si tratta di un'area importante per i
ritrovamenti (
24
) e di particolare interesse per la sua
conformazione orogeografica, essendo inserita tra il
fiume Dora che scorre, e doveva scorrere, vicino
alle mura (il cui caratteristico taglio nello spigolo
nord-est è da attribuire, appunto, agli spostamenti
nel tempo del fiume e al dislivello creatosi dall'in-
contro della sua valle fluviale con quella del Po), il
fiume Po (con le implicazioni che comporta quali
punto di sbarco, ponte, traghetto) e il punto topo-
grafico preminente costituito dalle pendici setten-
trionali della collina torinese (in particolare il Monte
dei Cappuccini (25)).
All'interno della terza area individuata, coerente
al settore settentrionale dell'area extraurbana, si ri-
leva la presenza di un sepolcreto riconoscibile per i
ritrovamenti occasionali di tombe rinvenute in una
zona compresa tra Via Foggia, Via Pisa, Via Peru-
gia, Via Ancona e Via Modena (
26
). Quest'area ad
uso funerario continua la necropoli attestata lungo il
lato nord-occidentale e deve essere messa in relazio-
ne con l'importante asse viario che usciva dalla
por-
ta principatis sinistra
sia verso Roma sia verso
Aquileia.
Il ritrovamento invece tra la piazza della Repub-
blica e il Cottolengo di un numero veramente enor-
me di anfore disposte coerentemente in uno o due
strati lungo un'ampia fascia definita (
27
), sembra da
porsi in relazione con la conformazione del terreno e
la vicina Dora. La consistenza del gigantesco manu-
fatto porta a pensare alla realizzazione di un'opera di
contenimento del terreno, di cui costituirebbe la pla-
tea di fondazione e sostruzione, in corrispondenza di
una depressione naturale della zona (
28
), nell'ottica
della protezione, non solo del territorio ma anche di
una qualche struttura di importanza veramente ecce-
zionale, da possibili straripamenti. Inoltre la partico-
lare situazione orogeografica dell'area individuata,
compresa tra la sponda destra della Dora e la sinistra
del Po, consente di privilegiarla rispetto alle altre
zone, al di fuori e in prossimità delle mura, come
area di probabili insediamenti a carattere artigianale-
manifatturiero e attività pubbliche — approdi-porti,
horrea,
mercati-fori — che non dovevano sicura-
mente mancare (
29
).
Infine nell'isolato compreso tra via Pisano, via
Priocca e corso XI Febbraio si può ipoteticamente
collocare la basilica extraurbana di S. Secondo, una
tra le poche chiese paleocristiane attestata dalle fon-
ti, sorta, con annessa area cimiteriale, su di una
primitiva
cetla memoriae
racchiudente le spoglie del
Santo (
30
). L'ubicazione che qui si propone tiene
conto di due elementi: innanzitutto del rinvenimento
in quest'area, di quantità di materiale da costruzione
romano (mattoni, tegoloni,
embrices)
insieme ad
una tomba a camera (
31
), materiale che avrebbe po-
tuto essere reimpiegato nell'edificio paleocristiano,
inoltre dell'indicazione topografica del Bagetti (32),
quale emerge dal confronto con le mappe dei catasti
antichi, napoleonico (1805) e Rabbini (1866).
L'urbanizzazione del territorio della tribù celti-
ca o celtizzata dei Taurini (
33
), ossia il passaggio
da una fase preurbana o protourbana di tipo proto-
storico ad una fase urbana organizzata, con una
definizione territoriale precisa, coincide con la fon-
dazione della colonia romana (seconda metà I sec.
a.C.) (
34
). L'esistenza di stanziamenti stabili in
epoca anteriore alla fondazione della colonia sono
testimoniati dalle tracce di una stazione neolitica
sul «brie della Maddalena»
,
uniche di una certa
consistenza nell'attuale territorio comunale di To-
rino (
35
). L'area interessata da questi ritrovamenti,
l'attuale Parco della Rimembranza, viene definita
come quarta area di interesse archeologico (
36
). La
presenza, inoltre, nello stesso luogo di una necropoli
di età imperiale (
37
) suggerisce l'ipotesi di una con-
tinuità di insediamento, legato ora all'organizzazio-
ne agricola e fondiaria del territorio.
Non facilmente collocabile o riconducibile ad
un'area nettamente delimitata, tuttavia da conside-
797


















