
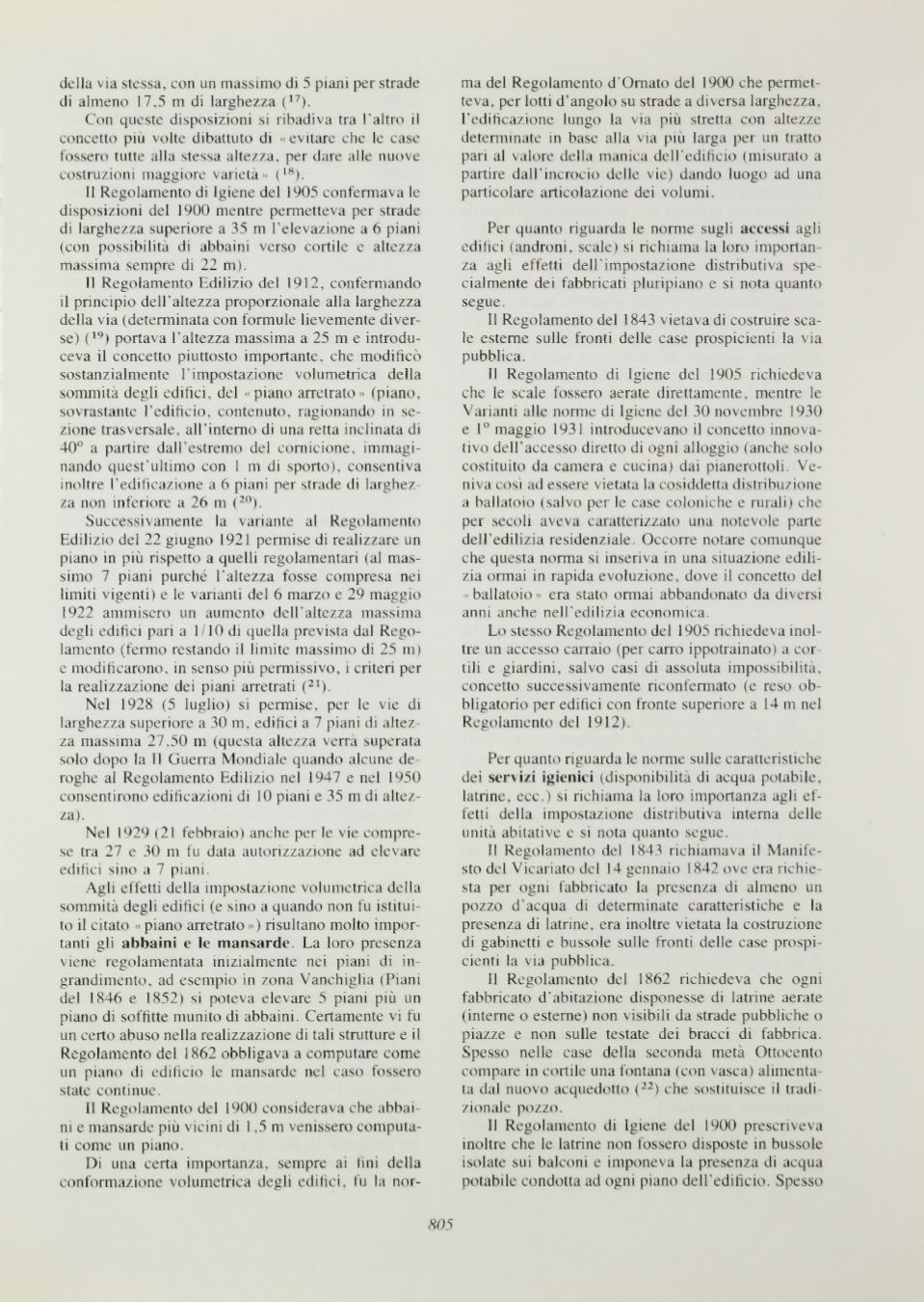
della via stessa, con un massimo di 5 piani per strade
di almeno 17,5 m di larghezza (
17
).
Con queste disposizioni si ribadiva tra l'altro il
concetto più volte dibattuto di « evitare che le case
fossero tutte alla stessa altezza, per dare alle nuove
costruzioni maggiore varietà» (
18
).
Il Regolamento di Igiene del 1905 confermava le
disposizioni del 1900 mentre permetteva per strade
di larghezza superiore a 35 m l'elevazione a 6 piani
(con possibilità di abbaini verso cortile e altezza
massima sempre di 22 m).
Il Regolamento Edilizio del 1912, confermando
il principio dell'altezza proporzionale alla larghezza
della via (determinata con formule lievemente diver-
se) (
19
) portava l'altezza massima a 25 m e introdu-
ceva il concetto piuttosto importante, che modificò
sostanzialmente l'impostazione volumetrica della
sommità degli edifici, del «piano arretrato» (piano,
sovrastante l'edificio, contenuto, ragionando in se-
zione trasversale, all'interno di una retta inclinata di
40° a partire dall'estremo del cornicione, immagi-
nando quest'ultimo con
1
m di sporto), consentiva
inoltre l'edificazione a 6 piani per strade di larghez-
za non inferiore a 26 m (
20
).
Successivamente la variante al Regolamento
Edilizio del 22 giugno 1921 permise di realizzare un
piano in più rispetto a quelli regolamentari (al mas-
simo 7 piani purché l'altezza fosse compresa nei
limiti vigenti) e le varianti del 6 marzo e 29 maggio
1922 ammisero un aumento dell'altezza massima
degli edifici pari a 1/10 di quella prevista dal Rego-
lamento (fermo restando il limite massimo di 25 m)
e
modificarono, in senso più permissivo, i criteri per
la realizzazione dei piani arretrati (
21
).
Nel 1928 (5 luglio) si permise, per le vie di
larghezza superiore a 30 m, edifici a 7 piani di altez-
za massima 27,50 m (questa altezza verrà superata
solo dopo la II Guerra Mondiale quando alcune de-
roghe al Regolamento Edilizio nel 1947 e nel 1950
consentirono edificazioni di 10 piani e 35 m di altez-
za).
Nel 1929 (21 febbraio) anche per le vie compre-
se tra 27 e 30 m fu data autorizzazione ad elevare
edifici sino a 7 piani.
Agli effetti della impostazione volumetrica della
sommità degli edifici (e sino a quando non fu istitui-
to il citato « piano arretrato ») risultano molto impor-
tanti gli
abbaini e le mansarde.
La loro presenza
viene regolamentata inizialmente nei piani di in-
grandimento, ad esempio in zona Vanchiglia (Piani
del 1846 e 1852) si poteva elevare 5 piani più un
piano di soffitte munito di abbaini. Certamente vi fu
un certo abuso nella realizzazione di tali strutture e il
Regolamento del 1862 obbligava a computare come
un piano di edificio le mansarde nel caso fossero
state continue.
Il Regolamento del 1900 considerava che abbai-
ni e mansarde più vicini di
1,5
m venissero computa-
ti come un piano.
Di una certa importanza, sempre ai fini della
conformazione volumetrica degli edifici, fu la nor-
ma del Regolamento d'Ornato del 1900 che permet-
teva, per lotti d'angolo su strade a diversa larghezza,
l'edificazione lungo la via più stretta con altezze
determinate in base alla via più larga per un tratto
pari al valore della manica dell'edificio (misurato a
partire dall'incrocio delle vie) dando luogo ad una
particolare articolazione dei volumi.
Per quanto riguarda le norme sugli
accessi
agli
edifici (androni, scale) si richiama la loro importan-
za agli effetti dell'impostazione distributiva spe-
cialmente dei fabbricati pluripiano e si nota quanto
segue.
Il Regolamento del 1843 vietava di costruire sca-
le esterne sulle fronti delle case prospicienti la via
pubblica.
Il Regolamento di Igiene del 1905 richiedeva
che le scale fossero aerate direttamente, mentre le
Varianti alle norme di Igiene del 30 novembre 1930
e 1° maggio 1931 introducevano il concetto innova-
tivo dell'accesso diretto di ogni alloggio (anche solo
costituito da camera e cucina) dai pianerottoli. Ve-
niva così ad essere vietata la cosiddetta distribuzione
a ballatoio (salvo per le case coloniche e rurali) che
per secoli aveva caratterizzato una notevole parte
dell'edilizia residenziale. Occorre notare comunque
che questa norma si inseriva in una situazione edili-
zia ormai in rapida evoluzione, dove il concetto del
« ballatoio » era stato ormai abbandonato da diversi
anni anche nell'edilizia economica.
Lo stesso Regolamento del 1905 richiedeva inol-
tre un accesso carraio (per carro ippotrainato) a cor-
tili e giardini, salvo casi di assoluta impossibilità,
concetto successivamente riconfermato (e reso ob-
bligatorio per edifici con fronte superiore a 14 m nel
Regolamento del 1912).
Per quanto riguarda le norme sulle caratteristiche
dei
servizi igienici
(disponibilità di acqua potabile,
latrine, ecc.) si richiama la loro importanza agli ef-
fetti della impostazione distributiva interna delle
unità abitative e si nota quanto segue.
Il Regolamento del 1843 richiamava il Manife-
sto del Vicariato del 14 gennaio 1842 ove era richie-
sta per ogni fabbricato la presenza di almeno un
pozzo d'acqua di determinate caratteristiche e la
presenza di latrine, era inoltre vietata la costruzione
di gabinetti e bussole sulle fronti delle case prospi-
cienti la via pubblica.
Il Regolamento del 1862 richiedeva che ogni
fabbricato d'abitazione disponesse di latrine aerate
(interne o esterne) non visibili da strade pubbliche o
piazze e non sulle testate dei bracci di fabbrica.
Spesso nelle case della seconda metà Ottocento
compare in cortile una fontana (con vasca) alimenta-
ta dal nuovo acquedotto (
22
) che sostituisce il tradi-
zionale pozzo.
Il Regolamento di Igiene del 1900 prescriveva
inoltre che le latrine non fossero disposte in bussole
isolate sui balconi e imponeva la presenza di acqua
potabile condotta ad ogni piano dell'edificio. Spesso
805


















