
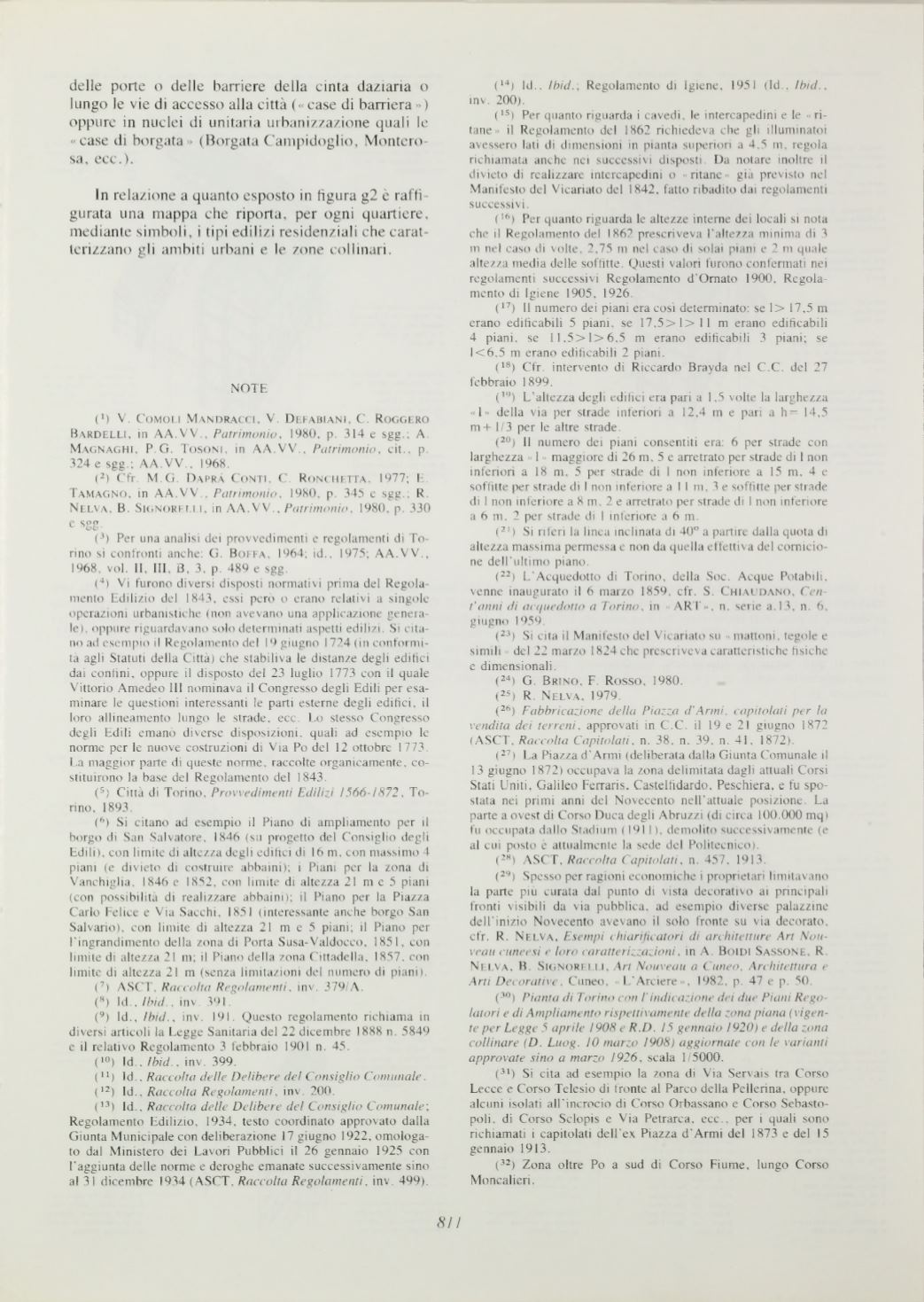
delle porte o delle barriere della cinta daziaria o
lungo le vie di accesso alla città (« case di barriera »)
oppure in nuclei di unitaria urbanizzazione quali le
«case di borgata» (Borgata Campidoglio, Montero-
sa, ecc.).
In relazione a quanto esposto in figura g2 è raffi-
gurata una mappa che riporta, per ogni quartiere,
mediante simboli, i tipi edilizi residenziali che carat-
terizzano gli ambiti urbani e le zone collinari.
NOTE
(1) V.
COMOLI MANDRACCI, V. DEFABIANI, C. ROGGERO
BARDELLI,
in
AA.VV.,
Patrimonio,
1980, p. 314 e sgg.; A.
MAGNAGHI,
P. G.
TOSONI,
in
AA.VV.,
Patrimonio,
cit., p.
324 e sgg.;
AA.VV., 1968.
(2) Cfr. M. G.
DAPRA CONTI, C. RONCHETTA,
1977; E.
TAMAGNO,
in
AA.VV.,
Patrimonio,
1980, p. 345 e sgg.; R.
NELVA,
B.
SIGNORELLI,
in
AA.VV.,
Patrimonio,
1980, p. 330
e sgg.
(3) Per una analisi dei provvedimenti e regolamenti di To-
rino si confronti anche: G.
BOFFA,
1964; id., 1975;
AA.VV.,
1968, vol. II, III, B, 3, p. 489 e sgg.
(4) Vi furono diversi disposti normativi prima def Regola-
mento Edilizio del 1843, essi però o erano relativi a singole
operazioni urbanistiche (non avevano una applicazione genera-
le), oppure riguardavano solo determinati aspetti edilizi. Si cita-
no ad esempio il Regolamento del 19 giugno 1724 (in conformi-
tà agli Statuti della Città) che stabiliva le distanze degli edifici
dai confini, oppure il disposto del 23 luglio 1773 con il quale
Vittorio Amedeo Ill nominava il Congresso degli Edili per esa-
minare le questioni interessanti le parti esterne degli edifici, il
loro allineamento lungo le strade, ecc. Lo stesso Congresso
degli Edili emanò diverse disposizioni, quali ad esempio le
norme per le nuove costruzioni di Via Po del 12 ottobre
1773.
La maggior parte di queste norme, raccolte organicamente, co-
stituirono la base del Regolamento del 1843.
(5) Città di Torino,
Provvedimenti Edilizi 1566-1872,
To-
rino, 1893.
(6) Si citano ad esempio il Piano di ampliamento per il
borgo di San Salvatore, 1846 (su progetto del Consiglio degli
Edili), con limite di altezza degli edifici di 16 m, con massimo 4
piani (e divieto di costruire abbaini); i Piani per la zona di
Vanchiglia, 1846 e 1852, con limite di altezza 21 m e 5 piani
(con possibilità di realizzare abbaini); il Piano per la Piazza
Carlo Felice e Via Sacchi, 1851 (interessante anche borgo San
Salvario), con limite di altezza 21 m e 5 piani; il Piano per
l'ingrandimento della zona di Porta Susa-Valdocco, 1851, con
limite di altezza 21 m; il Piano della zona Cittadella, 1857, con
limite di altezza 21 m (senza limitazioni del numero di piani).
(7) ASCT,
Raccolta Regolamenti,
inv. 379/A.
(8) Id.,
Ibid.,
inv. 391.
(9) Id.,
Ibid.,
inv. 191. Questo regolamento richiama in
diversi articoli la Legge Sanitaria del 22 dicembre 1888 n. 5849
e il relativo Regolamento 3 febbraio 1901 n. 45.
(10) Id.,
Ibid.,
inv. 399.
(
11
) Id.,
Raccolta delle Detibere del Consiglio Comunale.
(12) Id.,
Raccolta Regolamenti,
inv. 200.
(13) Id.,
Raccolta delle Delibere del Consigtio Comunale;
Regolamento Edilizio, 1934, testo coordinato approvato dalla
Giunta Municipale con deliberazione 17 giugno 1922, omologa-
to dal Ministero dei Lavori Pubblici il 26 gennaio 1925 con
l'aggiunta delle norme e deroghe emanate successivamente sino
al 31 dicembre 1934 (ASCT,
Raccolta Regolamenti,
inv. 499).
(14) Id.,
Ibid.;
Regolamento di Igiene, 1951 (Id.,
Ibid.,
inv. 200).
(15) Per quanto riguarda i cavedi, le intercapedini e le «ri-
tane» il Regolamento del 1862 richiedeva che gli illuminatoi
avessero lati di dimensioni in pianta superiori a 4,5 m, regola
richiamata anche nei successivi disposti. Da notare inoltre il
divieto di realizzare intercapedini o «ritane
„
già previsto nel
Manifesto del Vicariato del 1842, fatto ribadito dai regolamenti
successivi.
(16) Per quanto riguarda le altezze interne dei locali si nota
che il Regolamento del 1862 prescriveva l'altezza minima di 3
m nel caso di volte, 2,75 m nel caso di solai piani e 2 m quale
altezza media delle soffitte. Questi valori furono confermati nei
regolamenti successivi Regolamento d'Ornato 1900, Regola-
mento di Igiene 1905, 1926.
(17) Il numero dei piani era così determinato: se 1> 17,5 m
erano edificabili 5 piani, se 17,5> 1> 11 m erano edificabili
4 piani, se 11,5> 1> 6,5 m erano edificabili 3 piani; se
I<6,5 m erano edificabili 2 piani.
(18) Cfr. intervento di Riccardo Brayda nel C.C. del 27
febbraio 1899.
(19) L'altezza degli edifici era pari a 1,5 volte la larghezza
«1» della via per strade inferiori a 12,4 m e pari a h= 14,5
m+ 113 per le altre strade.
(20) Il numero dei piani consentiti era: 6 per strade con
larghezza "1. maggiore di 26 m, 5 e arretrato per strade di l non
inferiori a 18 m, 5 per strade di 1 non inferiore a 15 m, 4 e
soffitte per strade di I non inferiore a I 1 m, 3 e soffitte per strade
di I non inferiore a 8 m, 2 e arretrato per strade di I non inferiore
a 6 m, 2 per strade di 1 inferiore a 6 m.
(21) Si riferì la linea inclinata di 40° a partire dalla quota di
altezza massima permessa e non da quella effettiva del cornicio-
ne dell'ultimo piano.
(22) L'Acquedotto di Torino, della Soc. Acque Potabili,
venne inaugurato il 6 marzo 1859, cfr. S.
CHIAUDANO,
Cen-
t'anni di acquedotto a Torino, in «
ART», n. serie a.13, n. 6,
giugno 1959.
(23) Si cita il Manifesto del Vicariato su „ mattoni, tegole e
simili » del 22 marzo 1824 che prescriveva caratteristiche fisiche
e dimensionali.
(24) G.
BRINO,
F. Rosso, 1980.
(25) R.
NELVA,
1979.
(26) Fabbricazione della Piazza d'Anni, capitolati per la
vendita dei terreni,
approvati in C.C. il 19 e 21 giugno 1872
(ASCT,
Raccolta Capitolati,
n. 38, n. 39, n. 41, 1872).
(27) La Piazza d'Armi (deliberata dalla Giunta Comunale il
13 giugno 1872) occupava la zona delimitata dagli attuali Corsi
Stati Uniti. Galileo Ferraris, Castelfidardo, Peschiera, e fu spo-
stata nei primi anni del Novecento nell'attuale posizione. La
parte a ovest di Corso Duca degli Abruzzi (di circa 100.000 mq)
fu occupata dallo Stadium (1911), demolito successivamente (e
al cui posto è attualmente la sede del Politecnico).
(28) ASCT,
Raccolta Capitolati,
n. 457, 1913.
(29) Spesso per ragioni economiche i proprietari limitavano
la parte più curata dal punto di vista decorativo ai principali
fronti visibili da via pubblica, ad esempio diverse palazzine
dell'inizio Novecento avevano il solo fronte su via decorato,
cfr. R.
NELVA,
Esempi chiarificatori di architetture Art Nou-
veau cuneesi e loro caratterizzazioni,
in A.
BoIDI SASSONE,
R.
NELVA,
B.
SIGNORELLI,
Art Nouveau a Cuneo, Architettura e
Arti Decorative,
Cuneo, ' L'Arciere»
,
1982, p. 47 e p. 50.
(30) Pianta di Torino con l'indicazione dei due Piani Rego-
latori e di Ampliamento rispettivamente della zona piana (vigen-
te per Legge 5 aprile 1908 e R.D. 15 gennaio 1920) e delta zona
collinare (D. Luog. 10 marzo 1908) aggiornate con le varianti
approvate sino a marzo 1926,
scala 1/5000.
(31) Si cita ad esempio la zona di Via Servais tra Corso
Lecce e Corso Telesio di fronte al Parco della Pellerina, oppure
alcuni isolati all'incrocio di Corso Orbassano e Corso Sebasto-
poli, di Corso Sclopis e Via Petrarca, ecc., per i quali sono
richiamati i capitolati dell'ex Piazza d'Armi del 1873 e del 15
gennaio 1913.
(32) Zona oltre Po a sud di Corso Fiume, lungo Corso
Moncalieri.
81/


















