
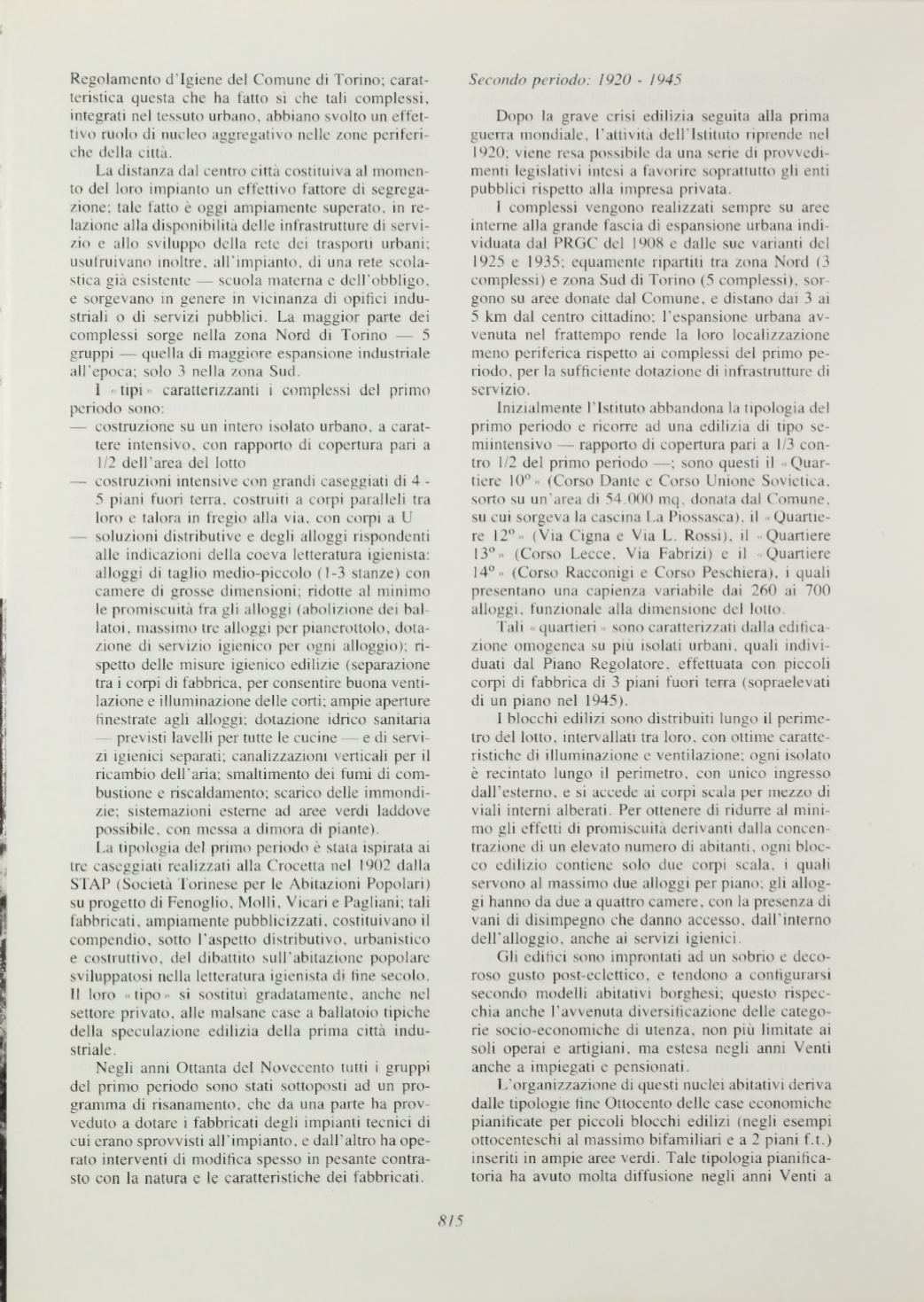
Regolamento d'Igiene del Comune di Torino; carat-
teristica questa che ha fatto sì che tali complessi,
integrati nel tessuto urbano, abbiano svolto un effet-
tivo ruolo di nucleo aggregativo nelle zone periferi-
che della città.
La distanza dal centro città costituiva al momen-
to del loro impianto un effettivo fattore di segrega-
zione; tale fatto è oggi ampiamente superato, in re-
lazione alla disponibilità delle infrastrutture di servi-
zio e allo sviluppo della rete dei trasporti urbani;
usufruivano inoltre, all'impianto, di una rete scola-
stica già esistente — scuola materna e dell'obbligo,
e sorgevano in genere in vicinanza di opifici indu-
striali o di servizi pubblici. La maggior parte dei
complessi sorge nella zona Nord di Torino 5
gruppi — quella di maggiore espansione industriale
all'epoca; solo 3 nella zona Sud.
I « tipi » caratterizzanti i complessi del primo
periodo sono:
costruzione su un intero isolato urbano, a carat-
tere intensivo, con rapporto di copertura pari a
1/2 dell'area del lotto
costruzioni intensive con grandi caseggiati di 4 -
5 piani fuori terra, costruiti a corpi paralleli tra
loro e talora in fregio alla via, con corpi a U
soluzioni distributive e degli alloggi rispondenti
alle indicazioni della coeva letteratura igienista:
alloggi di taglio medio-piccolo (1-3 stanze) con
camere di grosse dimensioni; ridotte al minimo
le promiscuità fra gli alloggi (abolizione dei bal-
latoi, massimo tre alloggi per pianerottolo, dota-
zione di servizio igienico per ogni alloggio); ri-
spetto delle misure igienico edilizie (separazione
tra i corpi di fabbrica, per consentire buona venti-
lazione e illuminazione delle corti; ampie aperture
finestrate agli alloggi; dotazione idrico sanitaria
previsti lavelli per tutte le cucine e di servi-
zi igienici separati; canalizzazioni verticali per il
ricambio dell'aria; smaltimento dei fumi di com-
bustione e riscaldamento; scarico delle immondi-
zie; sistemazioni esterne ad aree verdi laddove
possibile, con messa a dimora di piante).
La tipologia del primo periodo è stata ispirata ai
tre caseggiati realizzati alla Crocetta nel 1902 dalla
STAP (Società Torinese per le Abitazioni Popolari)
su progetto di Fenoglio, Molli, Vicari e Pagliani; tali
fabbricati, ampiamente pubblicizzati, costituivano il
compendio, sotto l'aspetto distributivo, urbanistico
e costruttivo, del dibattito sull'abitazione popolare
sviluppatosi nella letteratura igienista di fine secolo.
Il loro « tipo » si sostituì gradatamente, anche nel
settore privato, alle malsane case a ballatoio tipiche
della speculazione edilizia della prima città indu-
striale.
Negli anni Ottanta del Novecento tutti i gruppi
del primo periodo sono stati sottoposti ad un pro-
gramma di risanamento, che da una parte ha prov-
veduto a dotare i fabbricati degli impianti tecnici di
cui erano sprovvisti all'impianto, e dall'altro ha ope-
rato interventi di modifica spesso in pesante contra-
sto con la natura e le caratteristiche dei fabbricati.
Secondo periodo: 1920 - 1945
Dopo la grave crisi edilizia seguita alla prima
guerra mondiale, l'attività dell'Istituto riprende nel
1920; viene resa possibile da una serie di provvedi-
menti legislativi intesi a favorire soprattutto gli enti
pubblici rispetto alla impresa privata.
I complessi vengono realizzati sempre su aree
interne alla grande fascia di espansione urbana indi-
viduata dal PRGC del 1908 e dalle sue varianti del
1925 e 1935; equamente ripartiti tra zona Nord (3
complessi) e zona Sud di Torino (5 complessi), sor-
gono su aree donate dal Comune, e distano dai 3 ai
5 km dal centro cittadino; l'espansione urbana av-
venuta nel frattempo rende la loro localizzazione
meno periferica rispetto ai complessi del primo pe-
riodo, per la sufficiente dotazione di infrastrutture di
servizio.
Inizialmente l'Istituto abbandona la tipologia del
primo periodo e ricorre ad una edilizia di tipo se-
miintensivo — rapporto di copertura pari a 1/3 con-
tro 1/2 del primo periodo —; sono questi il «Quar-
tiere 10° » (Corso Dante e Corso Unione Sovietica,
sorto su un'area di 54.000 mq, donata dal Comune,
su cui sorgeva la cascina La Piossasca), il «Quartie-
re 12°» (Via Cigna e Via L. Rossi), il «Quartiere
13°» (Corso Lecce, Via Fabrizi) e il «Quartiere
14°. (Corso Racconigi e Corso Peschiera), i quali
presentano una capienza variabile dai 260 ai 700
alloggi, funzionale alla dimensione del lotto.
Tali « quartieri » sono caratterizzati dalla edifica-
zione omogenea su più isolati urbani, quali indivi-
duati dal Piano Regolatore, effettuata con piccoli
corpi di fabbrica di 3 piani fuori terra (sopraelevati
di un piano nel 1945).
I blocchi edilizi sono distribuiti lungo il perime-
tro del lotto, intervallati tra loro, con ottime caratte-
ristiche di illuminazione e ventilazione; ogni isolato
è
recintato lungo il perimetro, con unico ingresso
dall'esterno, e si accede ai corpi scala per mezzo di
viali interni alberati. Per ottenere di ridurre al mini-
mo gli effetti di promiscuità derivanti dalla concen-
trazione di un elevato numero di abitanti, ogni bloc-
co edilizio contiene solo due corpi scala, i quali
servono al massimo due alloggi per piano; gli allog-
gi hanno da due a quattro camere, con la presenza di
vani di disimpegno che danno accesso, dall'interno
dell'alloggio, anche ai servizi igienici.
Gli edifici sono improntati ad un sobrio e deco-
roso gusto post-eclettico, e tendono a configurarsi
secondo modelli abitativi borghesi; questo rispec-
chia anche l'avvenuta diversificazione delle catego-
rie socio-economiche di utenza, non più limitate ai
soli operai e artigiani, ma estesa negli anni Venti
anche a impiegati e pensionati.
L'organizzazione di questi nuclei abitativi deriva
dalle tipologie fine Ottocento delle case economiche
pianificate per piccoli blocchi edilizi (negli esempi
ottocenteschi al massimo bifamiliari e a 2 piani f.t.)
inseriti in ampie aree verdi. Tale tipologia pianifica-
toria ha avuto molta diffusione negli anni Venti a
815


















