
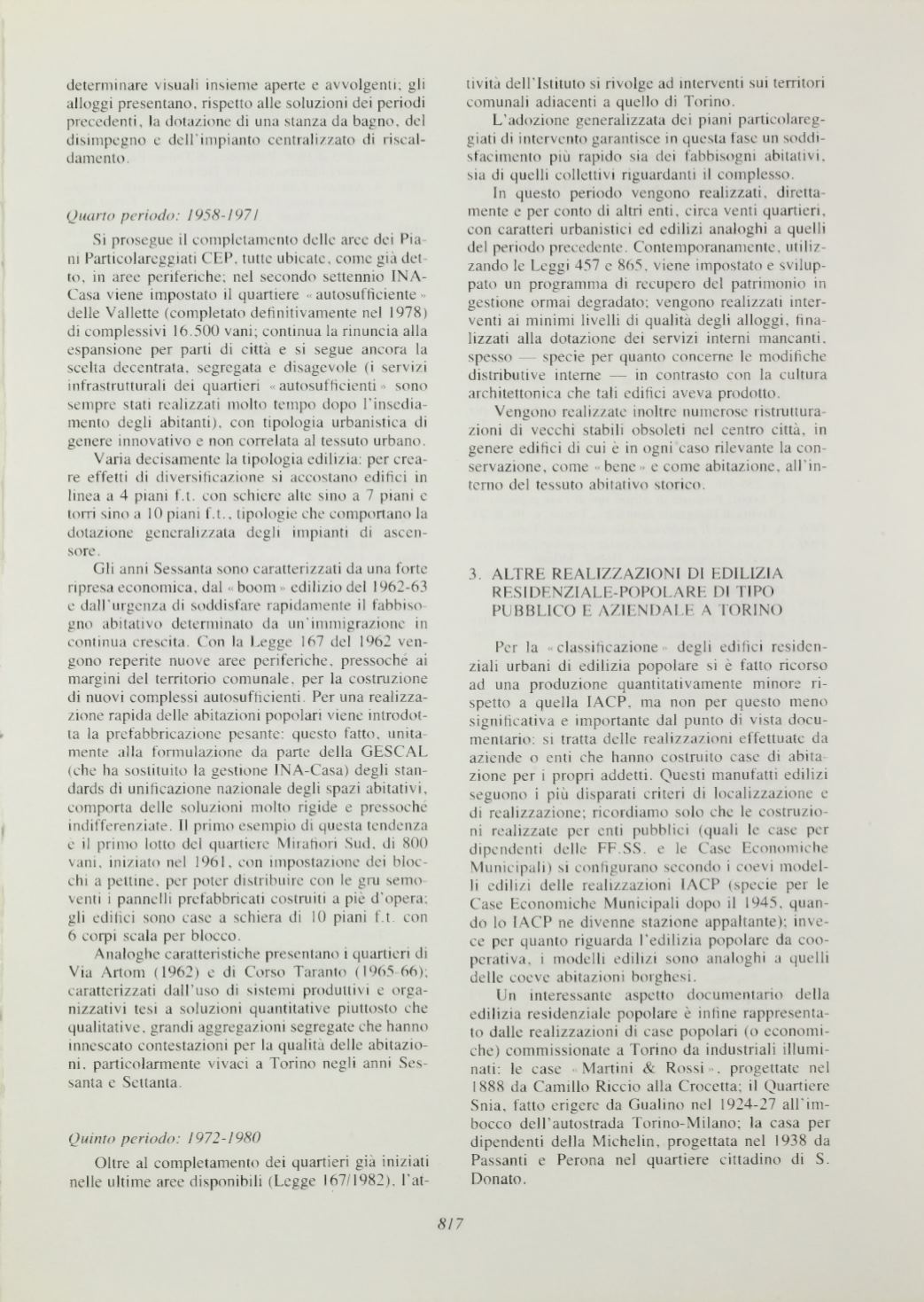
determinare visuali insieme aperte e avvolgenti; gli
alloggi presentano, rispetto alle soluzioni dei periodi
precedenti, la dotazione di una stanza da bagno, del
disimpegno e dell'impianto centralizzato di riscal-
damento.
Quarto periodo: 1958-1971
Si prosegue il completamento delle aree dei Pia-
ni Particolareggiati CEP, tutte ubicate, come già det-
to, in aree periferiche; nel secondo settennio INA-
Casa viene impostato il quartiere « autosufficiente
delle Vallette (completato definitivamente nel 1978)
di complessivi 16.500 vani; continua la rinuncia alla
espansione per parti di città e si segue ancora la
scelta decentrata, segregata e disagevole (i servizi
infrastrutturali dei quartieri « autosufficienti » sono
sempre stati realizzati molto tempo dopo l'insedia-
mento degli abitanti), con tipologia urbanistica di
genere innovativo e non correlata al tessuto urbano.
Varia decisamente la tipologia edilizia: per crea-
re effetti di diversificazione si accostano edifici in
linea a 4 piani f.t. con schiere alte sino a 7 piani e
torri sino a 10 piani f.t., tipologie che comportano la
dotazione generalizzata degli impianti di ascen-
sore.
Gli anni Sessanta sono caratterizzati da una forte
ripresa economica, dal « boom » edilizio del 1962-63
e dall'urgenza di soddisfare rapidamente il fabbiso-
gno abitativo determinato da un'immigrazione in
continua crescita. Con la Legge 167 del 1962 ven-
gono reperite nuove aree periferiche, pressoché ai
margini del territorio comunale, per la costruzione
di nuovi complessi autosufficienti. Per una realizza-
zione rapida delle abitazioni popolari viene introdot-
ta la prefabbricazione pesante: questo fatto, unita-
mente alla formulazione da parte della GESCAL
(che ha sostituito la gestione INA-Casa) degli stan-
dards di unificazione nazionale degli spazi abitativi,
comporta delle soluzioni molto rigide e pressoché
indifferenziate. Il primo esempio di questa tendenza
è il primo lotto del quartiere Mirafiori Sud, di 800
vani, iniziato nel 1961, con impostazione dei bloc-
chi a pettine, per poter distribuire con le gru semo-
venti i pannelli prefabbricati costruiti a piè d'opera;
gli edifici sono case a schiera
di
10 piani f.t. con
6 corpi scala per blocco.
Analoghe caratteristiche presentano i quartieri di
Via Artom (1962) e di Corso Taranto (1965-66);
caratterizzati dall'uso di sistemi produttivi e orga-
nizzativi tesi a soluzioni quantitative piuttosto che
qualitative, grandi aggregazioni segregate che hanno
innescato contestazioni per la qualità delle abitazio-
ni, particolarmente vivaci a Torino negli anni Ses-
santa e Settanta.
Quinto periodo: 1972-1980
Oltre al completamento dei quartieri già iniziati
nelle ultime aree disponibili (Legge 167/1982), l'at-
tività dell'Istituto si rivolge ad interventi sui territori
comunali adiacenti a quello di Torino.
L'adozione generalizzata dei piani particolareg-
giati di intervento garantisce in questa fase un soddi-
sfacimento più rapido sia dei fabbisogni abitativi,
sia di quelli collettivi riguardanti il complesso.
In questo periodo vengono realizzati, diretta-
mente e per conto di altri enti, circa venti quartieri,
con caratteri urbanistici ed edilizi analoghi a quelli
del periodo precedente. Contemporanamente, utiliz-
zando le Leggi 457 e 865, viene impostato e svilup-
pato un programma di recupero del patrimonio in
gestione ormai degradato; vengono realizzati inter-
venti ai minimi livelli di qualità degli alloggi, fina-
lizzati alla dotazione dei servizi interni mancanti,
spesso specie per quanto concerne le modifiche
distributive interne in contrasto con la cultura
architettonica che tali edifici aveva prodotto.
Vengono realizzate inoltre numerose ristruttura-
zioni di vecchi stabili obsoleti nel centro città, in
genere edifici di cui è in ogni caso rilevante la con-
servazione, come « bene « e come abitazione, all'in-
terno del tessuto abitativo storico.
3. ALTRE REALIZZAZIONI DI EDILIZIA
RESIDENZIALE-POPOLARE DI TIPO
PUBBLICO E AZIENDALE A TORINO
Per la « classificazione » degli edifici residen-
ziali urbani di edilizia popolare si è fatto ricorso
ad una produzione quantitativamente minore ri-
spetto a quella IACP, ma non per questo meno
significativa e importante dal punto di vista docu-
mentario: si tratta delle realizzazioni effettuate da
aziende o enti che hanno costruito case di abita-
zione per i propri addetti. Questi manufatti edilizi
seguono i più disparati criteri di localizzazione e
di realizzazione; ricordiamo solo che le costruzio-
ni realizzate per enti pubblici (quali le case per
dipendenti delle
FF.SS. e le Case Economiche
Municipali) si configurano secondo i coevi model-
li edilizi delle realizzazioni IACP (specie per le
Case Economiche Municipali dopo il 1945, quan-
do lo IACP ne divenne stazione appaltante); inve-
ce per quanto riguarda l'edilizia popolare da coo-
perativa, i modelli edilizi sono analoghi a quelli
delle coeve abitazioni borghesi.
Un interessante aspetto documentario della
edilizia residenziale popolare è infine rappresenta-
to dalle realizzazioni di case popolari (o economi-
che) commissionate a Torino da industriali illumi-
nati: le case «Martini & Rossi «, progettate nel
1888 da Camillo Riccio alla Crocetta; il Quartiere
Snia, fatto erigere da Gualino nel 1924-27 all'im-
bocco dell'autostrada Torino-Milano; la casa per
dipendenti della Michelin, progettata nel 1938 da
Passanti e Perona nel quartiere cittadino di S.
Donato.
817


















