
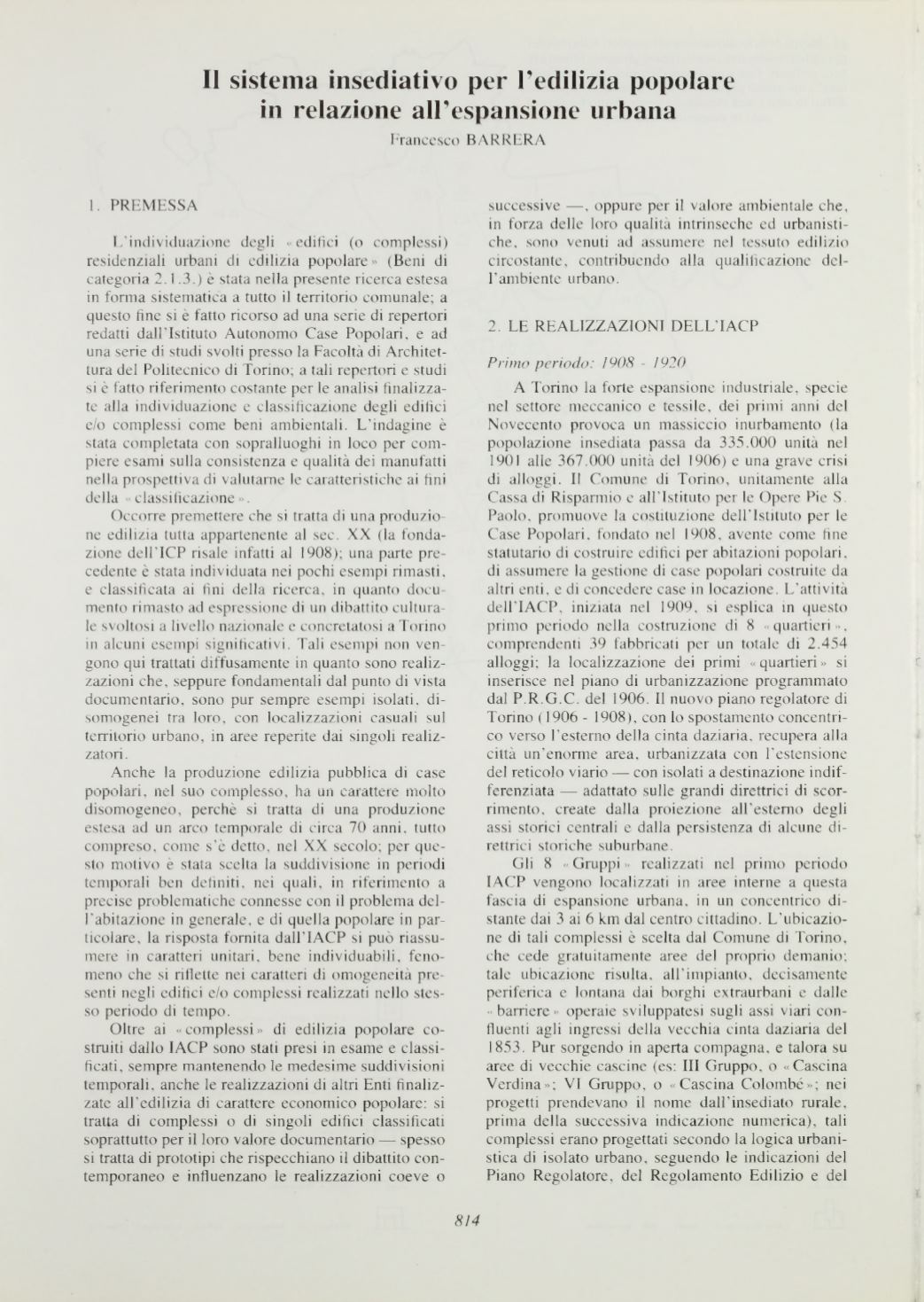
Il sistema insediativo per l'edilizia popolare
in relazione all'espansione urbana
Francesco BARRERA
1. PREMESSA
L'individuazione degli « edifici (o complessi)
residenziali urbani di edilizia popolare » (Beni di
categoria 2.1.3.) è stata nella presente ricerca estesa
in forma sistematica a tutto il territorio comunale; a
questo fine si è fatto ricorso ad una serie di repertori
redatti dall'Istituto Autonomo Case Popolari, e ad
una serie di studi svolti presso la Facoltà di Architet-
tura del Politecnico di Torino; a tali repertori e studi
si è fatto riferimento costante per le analisi finalizza-
te alla individuazione e classificazione degli edifici
e/o complessi come beni ambientali. L'indagine è
stata completata con sopralluoghi in loco per com-
piere esami sulla consistenza e qualità dei manufatti
nella prospettiva di valutarne le caratteristiche ai fini
della « classificazione ».
Occorre premettere che si tratta di una produzio-
ne edilizia tutta appartenente al sec. XX (la fonda-
zione dell'ICP risale infatti al 1908); una parte pre-
cedente è stata individuata nei pochi esempi rimasti,
e classificata ai fini della ricerca, in quanto docu-
mento rimasto ad espressione di un dibattito cultura-
le svoltosi a livello nazionale e concretatosi a Torino
in alcuni esempi significativi. Tali esempi non ven-
gono qui trattati diffusamente in quanto sono realiz-
zazioni che, seppure fondamentali dal punto di vista
documentario, sono pur sempre esempi isolati, di-
somogenei tra loro, con localizzazioni casuali sul
territorio urbano, in aree reperite dai singoli realiz-
zatori.
Anche la produzione edilizia pubblica di case
popolari, nel suo complesso, ha un carattere molto
disomogeneo, perchè si tratta di una produzione
estesa ad un arco temporale di circa 70 anni, tutto
compreso, come s'è detto, nel XX secolo; per que-
sto motivo è stata scelta la suddivisione in periodi
temporali ben definiti, nei quali, in riferimento a
precise problematiche connesse con il problema del-
l'abitazione in generale, e di quella popolare in par-
ticolare, la risposta fornita dall'IACP si può riassu-
mere in caratteri unitari, bene individuabili, feno-
meno che si riflette nei caratteri di omogeneità pre-
senti negli edifici e/o complessi realizzati nello stes-
so periodo di tempo.
Oltre ai «complessi» di edilizia popolare co-
struiti dallo IACP sono stati presi in esame e classi-
ficati, sempre mantenendo le medesime suddivisioni
temporali, anche le realizzazioni di altri Enti finaliz-
zate all'edilizia di carattere economico popolare: si
tratta di complessi o di singoli edifici classificati
soprattutto per il loro valore documentario — spesso
si tratta di prototipi che rispecchiano il dibattito con-
temporaneo e influenzano le realizzazioni coeve o
successive —, oppure per il valore ambientale che,
in forza delle loro qualità intrinseche ed urbanisti-
che, sono venuti ad assumere nel tessuto edilizio
circostante, contribuendo alla qualificazione del-
l'ambiente urbano.
2. LE REALIZZAZIONI DELL'IACP
Primo periodo: 1908 - 1920
A Torino la forte espansione industriale, specie
nel settore meccanico e tessile, dei primi anni del
Novecento provoca un massiccio inurbamento (la
popolazione insediata passa da 335.000 unità nel
1901 alle 367.000 unità del 1906) e una grave crisi
di alloggi. Il Comune di Torino, unitamente alla
Cassa di Risparmio e all'Istituto per le Opere Pie S.
Paolo, promuove la costituzione dell'Istituto per le
Case Popolari, fondato nel 1908, avente come fine
statutario di costruire edifici per abitazioni popolari,
di assumere la gestione di case popolari costruite da
altri enti, e di concedere case in locazione. L'attività
dell'IACP, iniziata nel 1909, si esplica in questo
primo periodo nella costruzione di 8 « quartieri »,
comprendenti 39 fabbricati per un totale di 2.454
alloggi; la localizzazione dei primi «quartieri» si
inserisce nel piano di urbanizzazione programmato
dal P.R.G.C. del 1906. I1 nuovo piano regolatore di
Torino (1906 - 1908), con lo spostamento concentri-
co verso l'esterno della cinta daziaria, recupera alla
città un'enorme area, urbanizzata con l'estensione
del reticolo viario — con isolati a destinazione indif-
ferenziata adattato sulle grandi direttrici di scor-
rimento, create dalla proiezione all'esterno degli
assi storici centrali e dalla persistenza di alcune di-
rettrici storiche suburbane.
Gli 8 « Gruppi » realizzati nel primo periodo
IACP vengono localizzati in aree interne a questa
fascia di espansione urbana, in un concentrico di-
stante dai 3 ai 6 km dal centro cittadino. L'ubicazio-
ne di tali complessi è scelta dal Comune di Torino,
che cede gratuitamente aree del proprio demanio;
tale ubicazione risulta, all'impianto, decisamente
periferica e lontana dai borghi extraurbani e dalle
«
barriere» operaie sviluppatesi sugli assi viari con-
fluenti agli ingressi della vecchia cinta daziaria del
1853. Pur sorgendo in aperta compagna, e talora su
aree di vecchie cascine (es: III Gruppo, o « Cascina
Verdina»; VI Gruppo, o «Cascina Colombé»; nei
progetti prendevano il nome dall'insediato rurale,
prima della successiva indicazione numerica), tali
complessi erano progettati secondo la logica urbani-
stica di isolato urbano, seguendo le indicazioni del
Piano Regolatore, del Regolamento Edilizio e del
814


















